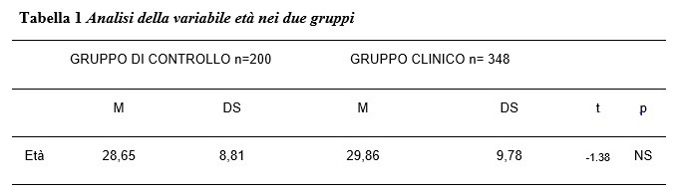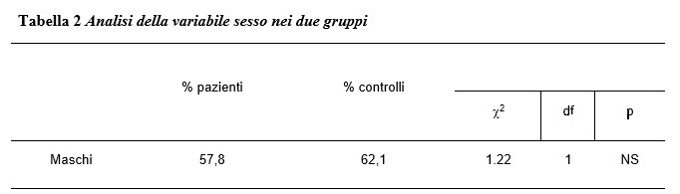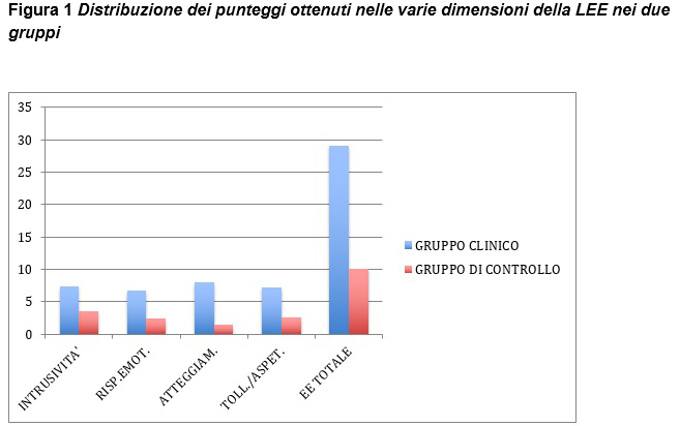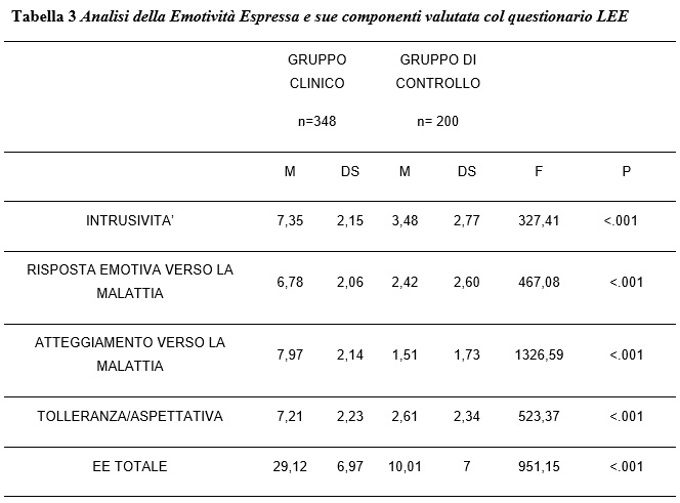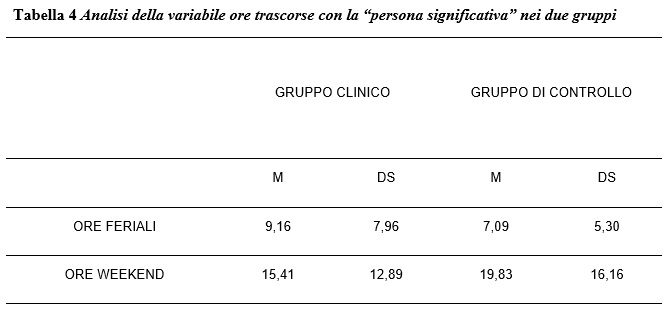Il Coaching e il life coach: che cos’è e quali benefici produce
Pubblichiamo con piacere questo interessante, equilibrato ed esaustivo articolo sul coaching, un argomento che interessa molti psicologi. Non è però inutile ricordare che il coaching, sicuramente una pratica utile ed efficace in molti campi professionali -come spiega benissimo l’articolo-, non può e non deve essere utilizzato come succedaneo improvvisato di trattamenti psicoterapeutici per la sofferenza mentale. Vale naturalmente anche il contrario: lo psicoterapeuta non può improvvisarsi coach. Buona lettura.
Giovanni Maria Ruggiero, Direttore
Cos’è il coaching e il life coach?
Il Coaching è una disciplina relativamente nuova in Italia, che ha radici molto più antiche… Socrate invitava a “Conoscere se stessi”; Pindaro era solito salutare i suoi discepoli dicendo: “Diventa ciò che sei”; Parmenide sosteneva che tutto è possibile: “Basta trovare il coraggio di percorrere la via” ed Eraclito affermava: “L’unica cosa permanente è il cambiamento”. Con l’emergere del movimento Umanista, si comincia a parlare di coaching anche nel mondo del business. Ma la reale innovazione è venuta con la fusione tra lo sport e il mondo degli affari, che ha reinventato questo termine. Tim Gallwey (1974) con il suo Inner Game of Tennis fu uno dei primi promotori del coaching nel contesto degli affari, a cui sono susseguiti rapidamente altri coach sportivi di fama notevole, come John Whitmore (campione di corse automobilistiche) il quale vede il coaching come: «il processo di responsabilizzazione degli altri. Per Coaching non intendiamo semplicemente una tecnica escogitata lì per lì e rigorosamente applicata in determinate circostanze: si tratta piuttosto di un modo di guidare e gestire le persone, un modo di pensare, e quindi anche un modo di essere.»; David Hemery (medaglista olimpico del salto ad ostacoli), David Witaker (coach olimpico di hockey).
Il coaching, nel significato moderno, è stato supportato dalla “Teoria dell’apprendimento costruttivo” di Williams & Irwing (2001), la cui credenza centrale è che non esiste una sola vera interpretazione della realtà. Nel coaching il presupposto è la conoscenza e la consapevolezza di sé, delle proprie risorse e delle aree migliorabili. Si tratta di focalizzare mete specifiche per trovare le strategie più adeguate. E’ un progetto di crescita mirato, con traguardi specifici, che facilita il cambiamento, attraverso un percorso autorigenerativo. Il cliente è responsabile di ogni suo passo, il Coach lo aiuta a diventare consapevole dei suoi obiettivi e a realizzarli al meglio.
Il coaching diventa una strada che permette di conciliare il rispetto delle più profonde caratteristiche della persona con l’esigenza dell’organizzazione di ottenere prestazioni sempre più elevate. Non è una “tecnica”, una modalità superficiale e manipolatoria per spremere le persone e ottenere da esse una performance ottimale, ma una filosofia a cui ispirare la relazione, un modo di trattare le persone che consenta a queste di trovare nella performance il risultato di una scelta, l’espressione e la realizzazione di se stesse. Quindi il coaching è uno stimolo e uno strumento di cambiamento sia a livello culturale, sia individuale che organizzativo.
Il Coaching è uno strumento altamente efficace che aiuta le persone a far quadrare il bilancio della propria vita privata o professionale, a migliorare i rapporti con gli altri, scoprendo le strategie più adeguate per raggiungere i propri obiettivi. Quindi il coaching è visto come una partnership con i clienti che, attraverso un processo creativo, stimola la riflessione, ispirandoli a massimizzare il proprio potenziale personale e professionale.
Grazie all’attività svolta dal coach, i clienti sono in grado di apprendere ed elaborare le tecniche e le strategie di azione che permetteranno loro di migliorare sia le performance che la qualità della propria vita. La metodologia di coaching adottata dall’ ICF2 prevede che il cliente sia prima di tutto rispettato, sia dal punto di vista personale che professionale, e venga considerato in grado di gestire efficacemente la propria vita ed il proprio ambito lavorativo. Ogni cliente viene visto come una persona creativa e piena di risorse, non a caso le tecniche utilizzate di interazione del coach sono l’ascolto attivo e domande mirate perché danno la possibilità di porsi come facilitatore nei confronti del coachee. Quindi il coaching è concepito per aiutare i clienti a incrementare le loro conoscenze e performance e migliorare la qualità della vita.
Sulla base di ciò, le responsabilità del coach sono:
1. scoprire, rendere chiari ed allineare gli obiettivi che il cliente desidera raggiungere; guidare il cliente in una scoperta personale di tali obiettivi;
2. far in modo che le soluzioni e le strategie da seguire emergano dal cliente stesso;
3. lasciare piena autonomia e responsabilità al cliente.
Quando richiedere un intervento di coaching
Il cliente nel coaching è una persona o un team che vuole raggiungere uno o più dei seguenti punti: un livello più elevato di performance, di apprendimento o di soddisfazione. Il cliente individuale nel coaching può intraprendere delle azioni per muovere verso un obiettivo con l’aiuto del coach; non sta cercando una guarigione emotiva o sollievi da un dolore psicologico; non è, quindi, eccessivamente limitato sotto il profilo delle sue capacità di iniziativa e di azione, né è così insicuro per impegnarsi in questo genere di progresso. La parola “cliente” è usata per definire la persona che usufruisce del coaching, indipendentemente da chi paga il servizio.
Ci sono molte ragioni per le quali una persona o un team possono scegliere di lavorare con un coach, alcune tra le principali sono:
– c’è qualcosa in gioco (una sfida, un obiettivo protratto o una grossa opportunità) ed è urgente, importante o appassionante, o tutte queste cose insieme;
– c’è una lacuna di consapevolezza, di capacità, di fiducia o di risorse;
– e’ stato richiesto un lavoro a pieno regime ed è a stretta scadenza;
– c’è il desiderio di ottenere risultati più rapidamente;
– c’è bisogno di invertire la direzione presa nel lavoro o nella vita personale a causa di un insuccesso;
– il modo di relazionarsi con gli altri non è efficace o non aiuta la persona a raggiungere i suoi obiettivi prioritari;
– c’è una mancanza di chiarezza nella persona a fronte delle scelte da fare;
– la persona ha molto successo e questo successo comincia a diventare problematico;
– non c’è equilibrio tra il lavoro e la vita privata e questo genera delle conseguenze indesiderate;
– la persona non ha identificato le sue potenzialità principali né sa come utilizzarle al meglio;
– la persona vuole che il lavoro e la vita siano più semplici, meno complicate;
– c’è il bisogno e il desiderio di essere meglio organizzati e sapersi meglio gestire.
Chi è il life coach?
Le Competenze del Coach sono:
– Predisposizione all’ascolto e il desiderio di mettersi sempre in discussione.
– Empatia: creare un rapporto empatico con il coachee senza mai sovrapporsi a lui.
– Saper guidare il coachee nell’autorealizzazione e nella consapevolezza di sé. Senza essere giudicante.
– Un coach non dà consigli o pareri, né dà informazioni. Fornisce supporto nel raggiungimento di un risultato. È un allenatore che migliora le prestazioni del proprio cliente.
Le 11 competenze rilasciate dalla ICF sono raggruppate in 4 sottogruppi, così suddivisi:
a) Porre le basi;
1) soddisfare linee guida etiche e standard professionali;
2) stabilire il contratto di coaching;
b) creare insieme la relazione;
3) stabilire fiducia e confidenza con il cliente;
4) presenza di coaching;
c) comunicare efficacemente;
5) ascoltare attivamente;
6) fare domande potenti;
7) comunicazione diretta;
d) facilitare apprendimento e risultati;
8) creare consapevolezza;
9) progettare azioni;
10) pianificare e definire obiettivi;
11) gestione del progresso e affidabilità.
Il coaching include un approccio elogiativo che si fonda sul riconoscimento di ciò che è giusto, di ciò che funziona, di ciò che è desiderato, di ciò che è necessario per arrivare all’obiettivo. L’approccio elogiativo prevede domande basate sulla scoperta, una modalità proattiva (in opposizione a quella reattiva) nella gestione delle sfide e delle opportunità personali, una formulazione costruttiva di osservazioni e feedback finalizzati ad ottenere reazioni positive dagli altri.
Pertanto la relazione è la base del coaching. Il coach e il cliente sviluppano intenzionalmente una relazione che è caratterizzata da un reciproco e crescente rispetto e apprezzamento come persone. Durante ciascun incontro è il cliente stesso a scegliere l’argomento della conversazione, mentre il coach lo ascolta ponendo osservazioni e domande. Questa interazione contribuisce a creare maggiore chiarezza ed induce il cliente a divenire proattivo. Nel coaching si osserva “dove si trova il cliente oggi”, quale sia cioè la situazione attuale di partenza, e si definisce, in comune accordo, ciò che egli è disposto a fare per raggiungere “la meta in cui vorrebbe trovarsi domani”.. Quindi, il coaching si concentra principalmente sul presente e il futuro, non si concentra sul passato o sull’impatto del passato sul presente, usa le informazioni del passato solo per chiarire la situazione presente. Far muovere il cliente in avanti non può dipendere da fatti del passato.
Come si articola un percorso di coaching
Generalmente un percorso di coaching si avvia con un colloquio personale (fatto di persona oppure telefonicamente) per valutare le attuali opportunità e sfide del cliente, per definire le finalità della relazione, per identificare le priorità di azione e per stabilire quali sono i risultati specifici che si vogliono raggiungere. Le sessioni di coaching possono essere condotte di persona (in presenza) oppure al telefono o tramite sistemi audio/video a distanza (es. Skype); la durata di ogni sessione viene concordata preventivamente, e varia, in genere, da un minimo di mezz’ora a un massimo di due ore.
Tra le sessioni di coaching programmate si può richiedere al cliente di compiere determinate azioni che lo aiutino al raggiungimento dei propri obiettivi prioritari. Il coach, inoltre, può fornire risorse supplementari, sotto forma di articoli, questionari, valutazioni o modelli per aiutare la riflessione e l’azione del cliente. La sessione si divide in tre, la prima sessione riguarda l’apertura, che rappresenta il primo impatto sia per il coachee che per il coach. Si stabiliscono le regole dell’incontro e si esplicita la metodologia di lavoro (cioè quanto durano gli incontri, dove si svolgeranno, che costo avranno, in che modo la partnership è coinvolta…). Si sondano le aspettative del coachee per iniziare a fare una analisi della domanda (esempio del coachee: difficoltà a relazionarsi efficacemente con il capo).
Possiamo identificare una seconda fase, la fase centrale del colloquio dove si mettono in pratica le dinamiche della sessione, si pongono le basi per la relazione ed il lavoro sugli obiettivi. In questa fase si raccolgono le informazioni ed i fatti riportati ma si cerca di lavorare concretamente in relazione all’obiettivo del coachee (esempio il coach cerca di farsi raccontare esattamente quando ed in quali situazioni il coachee si sente non efficace nella relazione con il capo).
Infine possiamo individuare una fase finale, il momento della chiusura. In questa ultima fase, si puntualizzano gli elementi più importanti che sono emersi dal colloquio e si stabilisce l’incontro successivo. Si tende a chiudere sempre con un lavoro pratico che il coachee dovrà fare su se stesso (esempio il coachee si impegna “ogni volta che devo incontrare il capo, per evitare di sentirmi impreparato, simulo una riunione/preparo una scaletta di base per una conversazione”). Occasionalmente si possono dare consigli, opinioni o suggerimenti nel coaching. Entrambe le parti capiscono che il cliente è libero di accettarli o declinarli ed è lui che si assume la responsabilità delle azioni da prendere. Un coach può esprimere richieste affinché il cliente promuova azioni adatte a conseguire un risultato desiderato da lui stesso. Il coach non fa tali richieste per stabilire un problema del cliente o per capirne il passato.
Nel coaching le informazioni ottenute dal cliente sono usate dal coach per stimolare la consapevolezza del cliente e aiutarlo a scegliere il tipo di azione. Questi informazioni non sono usate per valutare la performance o fornire relazioni per qualcuno, fuorché per il cliente stesso. Il coaching ha la libertà e la flessibilità per affrontare una vasta varietà di argomenti personali e professionali. In una relazione di coaching, solo il cliente ed il coach determinano il fine del loro lavoro. Il coaching non è necessariamente limitato ad una discussione strettamente delineata. Nel coaching, ogni contributo dato dal coach per produrre il risultato desiderato dal cliente, viene dato attraverso una progressiva interazione con il cliente. Il ruolo del coach non è di produrre un prodotto o un risultato acquisito al di fuori delle sessioni di coaching. Il coaching è studiato per permettere ai cliente di acquisire una maggiore capacità di produrre risultati e una grande fiducia nelle capacità che gli occorrono. Va da sé che i clienti non abbandonano il coaching con la percezione della necessità di appoggiarsi al coach per produrre simili risultati nel futuro.
La durata di una relazione di coaching varia in funzione dalle esigenze della persona o del team: può variare da un minimo di tre sessioni fino a un massimo di nove o dieci mesi. Per alcuni tipi di coaching mirato, può funzionare bene un periodo dai 3 ai 6 mesi di lavoro; per altri tipi di coaching il cliente può trovare proficuo lavorare più a lungo con il coach. I fattori che possono influire sulla durata comprendono: il tipo di obiettivi e di risultati che si vogliono raggiungere, il modo con cui le persone o i team amano lavorare, la frequenza delle sessioni, le risorse finanziarie disponibili per sostenere il coaching.
I benefici del coaching e gli ambiti in cui è richiesto
I benefici: l’attività di coaching accelera la crescita dell’individuo in quanto grazie ad essa ognuno giunge a focalizzare in maniera più efficace e consapevole gli obiettivi da raggiungere e le conseguenti scelte da porre in atto. Grazie all’attività svolta dal coach, i clienti sono in grado di apprendere ed elaborare le tecniche e le strategie di azione che permetteranno loro di migliorare sia le performance che la qualità della propria vita. I clienti che si impegnano in una relazione di coaching possono aspettarsi di sperimentare nuove prospettive di sfide e opportunità personali, un accrescimento nelle capacità di pensiero e nella presa di decisioni. Inoltre beneficiano di un miglioramento nell’efficienza interpersonale e una maggiore fiducia nell’esprimere i ruoli scelti nella vita e al lavoro. In coerenza con l’impegno a migliorare la loro efficienza personale, i clienti che scelgono un coach possono aspettarsi anche di vedere risultati apprezzabili nelle aree della produttività, della soddisfazione personale nella vita e nel lavoro e del raggiungimento di importanti obiettivi personali.
Attualmente il coaching viene applicato in sette differenti tipologie:
– Business coaching, che si rivolge a liberi professionisti e imprenditori di piccole e medie imprese;
– Executive coaching, per top manager ed executive;
– Corporate coaching, per lo sviluppo di manager in azienda;
–Career coaching, aiuta ad affrontare scelte professionali;
– Team coaching, interviene su gruppi per migliorare la performance, la collaborazione e la realizzazione di progetti comuni;
– Personal coaching, lavora direttamente con il cliente su diverse aree della vita privata e lavorativa;
– Life coaching, per privati che decidono di migliorare alcune aree della propria vita.
A differenza del corporate e dell’executive coach, già da anni apprezzati e ricercati da grandi e medie aziende, il life coach è una figura nuova che in Italia si sta sviluppando solo negli ultimi anni. Si occupa soprattutto di tematiche inerenti la sfera della vita privata della persona, e in termini italiani potremmo definirlo un “allenatore della vita”.
Conclusioni
Il life coach è un professionista prezioso per tutti coloro che hanno bisogno di risolvere problemi specifici di cui sono già consapevoli, ma anche per coloro che desiderano una migliore qualità della vita e non sanno esattamente su quale aspetto focalizzarsi per poter raggiungere un’armonia generale e un senso di benessere. Il life coach ha quindi un’esperienza non solo nel campo professionale ma anche su tematiche legate al privato.
Il compito di un life coach è quello di aiutare l’individuo a mettere in luce le aree della vita privata che richiedono un maggiore impegno, motivazione o qualche cambiamento. Il compito del cliente, invece, è quello di impegnarsi a seguire le proprie scelte e a mettere in pratica le azioni programmate. Naturalmente, se non c’è la volontà da parte di un individuo di impegnarsi in un percorso di coaching, il lavoro del coach non porterà nessun beneficio.
Una caratteristica fondamentale del life coaching è che il coach non spinge il coachee a ripercorrere le esperienze passate, a focalizzarsi su questioni irrisolte, né tantomeno tenterà di affrontare problematiche di tipo psicologico, bensì parte dal presente per spostarsi verso il futuro, focalizzandosi esclusivamente sulla persona. Indipendentemente da ciò che costituisce la storia di ognuno di noi, secondo la filosofia del coaching, è possibile costruire una strategia personale che possa portare verso un risultato desiderato. L’insieme di azioni, la verifica di ogni passo successivo, la consapevole assunzione di responsabilità, fa sì che ogni cambiamento possa essere duraturo. Il coach non dà suggerimenti e soprattutto non giudica, offre piuttosto un’aspettativa esterna che sostiene il suo cliente e le sue scelte.
Le aree su cui si può intervenire insieme a un life coach sono molte e varie, come relazioni interpersonali, gestione del tempo, equilibrio tra vita privata e lavoro, rimozione di idee bloccanti che impediscono di agire come si vorrebbe, ma anche sviluppo personale e capacità di affrontare eventi straordinari. Tutti questi temi, a volte anche delicati, possono essere affrontati con estrema serenità grazie alla fiducia, la riservatezza e il rispetto, che vengono garantiti dalla relazione di coaching e che sono essenziali per la realizzazione di un percorso efficace.
Un percorso di life coaching ha una durata variabile a seconda del tema da affrontare e degli obiettivi prefissati.
Dott.ssa Simona Di Paolo