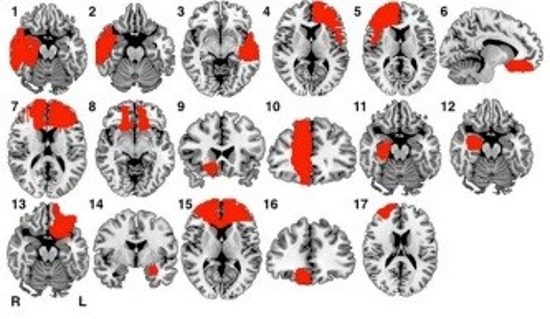Eiaculazione precoce: eziopatologia e trattamento cognitivo-comportamentale
L’ eiaculazione precoce (PE) è la disfunzione sessuale più comune tra gli uomini (Patrick et al., 2005). Alcuni professionisti della salute ritengono che sia l’argomento più discusso in medicina sessuale (Jannini & Porst, 2011). L’ eiaculazione precoce colpisce il 20-30% degli uomini ed è caratterizzata dalla perdita o dall’assenza di controllo eiaculatorio, accompagnata spesso da difficoltà interpersonali e stress (Patrick et al., 2005).
Andrea Goldoni, OPEN SCHOOL STUDI COGNITIVI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Che cos’è l’ eiaculazione precoce?
L’ eiaculazione precoce incide su diversi aspetti della vita maschile, come soddisfazione sessuale, autostima sessuale, controllo eiaculatorio, livelli di stress interpersonale e relazioni sentimentali. E’ stata inoltre associata a una serie di effetti psicologici negativi quali ansia e depressione, riguardanti chi ne è affetto ma anche i partner (Rosen, Althof et al., 2008). L’ eiaculazione precoce può costituire un fattore significativo di stress all’interno della coppia, e causare un abbassamento della qualità di vita, dell’autostima, e dell’autoefficacia. Negli uomini single può influenzare negativamente la motivazione a cercare un partner.
La diagnosi di eiaculazione precoce rappresenta una sfida, in quanto molti professionisti della salute non possiedono informazioni sufficienti riguardo i criteri da utilizzare e le opzioni di trattamento (Brock et al., 2009). Inoltre parlare di eiaculazione precoce solleva la questione su quale sia effettivamente un tempo di eiaculazione adeguato.
Già nel 1917 Karl Abraham descriveva l’ eiaculazione rapida, da lui definita ejaculatio praecox. Durante le prime decadi del ventesimo secolo, l’ eiaculazione precoce era considerata, specialmente nella teoria psicoanalitica, come una nevrosi legata a conflitti inconsci, e veniva trattata attraverso l’analisi (Abraham, 1917; Stekel, 1927). Nel 1943, la visione totalmente psicologica di Adler venne messa in discussione da Bernhard Schapiro, un endocrinologo tedesco, che considerava l’ eiaculazione precoce come un disturbo psicosomatico, affermando che le eiaculazioni rapide erano causate da fattori sia biologici che psicologici. Inoltre propose per la prima volta la suddivisione del disturbo in due tipologie, Tipo B e Tipo A. Nel 1989 Godpodinoff rinominò le due tipologie come lifelong (primaria) e acquisita (secondaria).
Tipologie di eiaculazione precoce
L’ eiaculazione precoce primaria è una sindrome caratterizzata da un insieme di sintomi caratteristici, che includono un’eiaculazione rapida durante quasi ogni rapporto sessuale, in un tempo compreso tra 30 e 60 secondi nella maggior parte dei casi (80%) o tra 1 e 2 minuti (20%), con ogni o quasi ogni partner sessuale, e a partire dai primi rapporti sessuali. L’ eiaculazione precoce acquisita consiste in un’eiaculazione rapida che insorge durante il percorso di vita, spesso a carattere situazionale, a fronte di precedenti esperienze eiaculatorie normali. (Waldinger, 1998; McMahon, 2002).
Nella letteratura scientifica sono presenti diverse definizioni dell’ eiaculazione precoce, poiché non vi è un accordo univoco sulle sue caratteristiche. Al fine di migliorare il confronto tra i vari studi, Waldinger et al. hanno introdotto il parametro dello IELT, il tempo di latenza eiaculatoria intravaginale, definito come il tempo che trascorre tra l’immissione intravaginale e l’inizio dell’eiaculazione. Waldinger riporta che la maggior parte degli uomini che cercano attivamente trattamento per l’ eiaculazione precoce primaria, circa il 90%, eiacula entro un minuto di penetrazione. Ricerche e studi osservazionali di uomini affetti da eiaculazione precoce hanno dimostrato che IELT pari o inferiori a un minuto hanno una prevalenza di circa 2,5% all’interno della popolazione generale, ma una percentuale di uomini con IELT nella norma riferisce di essere affetta da eiaculazione precoce (Patrick et al, 2005; Waldinger et al, 2005a, 2009).
Per tenere conto di questa diversità, Waldinger e Schweitzer (2006b, 2008) hanno proposto una nuova classificazione dell’ eiaculazione precoce nella quale sono distinti quattro tipologie sulla base della durata dello IELT, della frequenza con cui vengono riferiti gli episodi e dei momenti di vita in cui avvengono. In aggiunta all’ eiaculazione precoce primaria e acquisita, questa classificazione include quella variabile e quella soggettiva. Gli uomini con eiaculazione precoce variabile sperimentano occasionalmente un’eiaculazione prematura. Ciò non deve essere considerato come un disturbo, ma come una naturale variazione del tempo di eiaculazione, normalmente presente negli uomini (Waldinger, 2013). Gli uomini con eiaculazione precoce soggettiva invece riferiscono di essere affetti da eiaculazione precoce mentre in realtà hanno un tempo di eiaculazione normale o addirittura più esteso del normale (Waldinger, 2013). Il riferire la presenza di eiaculazione precoce da parte di questi uomini è probabilmente legato a fattori psicologici e/o culturali. Le costanti eiaculazioni anticipate della eiaculazione precoce primaria suggerirebbero la presenza di una disfunzione neurobiologica sottostante, mentre l’ eiaculazione precoce acquisita sarebbe più legata a fattori medici e psicologici.
Serefoglu et al. (2010, 2011) hanno confermato l’esistenza di questi quattro sottotipi in un campione di uomini turchi. Recentemente, Zhang et al. (2013) e Gao et al. (2013) utilizzando una metodologia simile hanno riportato la presenza dei quattro sottotipi anche in un campione di uomini in Cina. In futuro, la ricerca continua su questa nuova classificazione potrebbe portare a una migliore conoscenza dell’ eiaculazione precoce e a definizioni più precise. (Waldinger & Schweitzer, 2008).
Definizione di eiaculazione precoce e sintomi
Ad oggi, una delle definizioni più utilizzate in ambito clinico è quella fornita dal DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013):
A. Una modalità persistente o ricorrente di eiaculazione che si verifica durante i rapporti sessuali, circa un minuto dopo la penetrazione vaginale e prima che l’uomo lo desideri.
Nota: Anche se la diagnosi di eiaculazione precoce può essere applicata a individui impegnati in attività sessuali non intravaginali, non sono stati stabiliti specifici criteri di durata per queste attività.
B. I sintomi dei Criterio A devono essere presenti come minimo per circa 6 mesi e devono essere provati in tutte o quasi tutte (circa il 75-100%) le occasioni di attività sessuale (in determinate circostanze situazionali o, se generalizzato, in ogni circostanza).
C. I sintomi del Criterio A causano nell’individuo un disagio clinicamente significativo.
D. La disfunzione sessuale non è meglio spiegata da un disturbo mentale non sessuale o come conseguenza di un grave disagio relazionale o di altri significativi fattori stressanti e non è attribuibile agli effetti di una sostanza/farmaco o di un’altra condizione medica.
Specificare se:
Permanente: Il disturbo è presente da quando l’individuo è diventato sessualmente attivo.
Acquisita: Il disturbo inizia dopo un periodo di funzionamento sessuale relativamente normale.
Specificare se:
Generalizzata: Non è limitato a determinati tipi di stimolazione, situazioni o partner.
Situazionale: Si verifica solo con certi tipi di stimolazione, situazioni o partner.
Specificare gravità attuale:
Lieve: l’eiaculazione si verifica entro circa 30-60 secondi dopo la penetrazione vaginale.
Moderato: l’eiaculazione si verifica entro circa 15-30 secondi dopo la penetrazione vaginale.
Grave: l’eiaculazione si verifica prima dell’attività sessuale, all’inizio dell’attività sessuale o entro circa 15 secondi circa dalla penetrazione vaginale.
Le possibili cause dell’eiaculazione precoce
Storicamente ci sono stati diversi tentativi di spiegare le cause dell’ eiaculazione precoce, attraverso teorie sia biologiche che psicologiche. Nel 1970 William Masters e Virginia Johnson, due sessuologi americani, hanno postulato che la eiaculazione precoce sia il risultato di un comportamento appreso, rigettando il punto di vista psicoanalitico di Adler e quello psicosomatico di Schapiro. Sostenevano che l’eiaculazione rapida fosse collegata ai primi rapporti sessuali, in quanto esperienze iniziali connotate da rapidità ed ansia e potevano condizionare gli uomini ad eiaculare velocemente. Non sono stati tuttavia effettuati studi che abbiano messo a confronto le prime esperienze di condizionamento fra uomini con eiaculazione precoce e uomini senza il disturbo, per cui non si può sapere se le esperienze di condizionamento sono specifiche per gli uomini con eiaculazione precoce.
Nel 1998, Waldinger et al. hanno postulato che l’ eiaculazione precoce primaria sia una disfunzione determinata neurobiologicamente e geneticamente, correlata a una ridotta neurotrasmissione serotoninergica e all’ipersensibilità e iposensibilità di specifici recettori 5-HT. Waldinger ha quindi respinto le precedenti ipotesi psicologiche e comportamentiste riguardanti l’eziologia e la patogenesi della eiaculazione precoce primaria. Studi recenti suggeriscono che in alcuni uomini variazioni neurobiologiche e genetiche potrebbero contribuire all’eziopatologia della eiaculazione precoce primaria, e che tale condizione potrebbe essere mantenuta e aggravata da fattori psicologici e ambientali (Janssen et al., 2009).
La eiaculazione precoce acquisita è dovuta generalmente ad ansia da prestazione sessuale (Hartmann et al, 2005), problemi psicologici o relazionali (Hartmann et al., 2005), disfunzione erettile (Laumann et al., 2005), occasionalmente prostatite (Screponi et al., 2001), ipertiroidismo (Carani et al., 2005) o ad astinenza e disintossicazione da farmaci prescritti (Adson e Kotljar, 2003) o consumati a scopo ricreativo (Peugh e Belenko, 2001). Gli uomini affetti da questa problematica sono generalmente anziani, hanno un indice di massa corporea (BMI) più elevato, ed hanno una maggiore incidenza di patologie in comorbilità rispetto agli uomini affetti da eiaculazione precoce primaria, variabile e soggettiva, come ipertensione, disturbo del desiderio sessuale, diabete mellito, prostatite cronica e disfunzione erettile.
L’ansia è stata indicata come causa da diversi autori ed è tuttora comunemente considerata come una delle cause più probabili, nonostante l’evidenza empirica a supporto sia piuttosto scarsa (Jern et al., 2009; Janssen et al., 2009). Diversi autori ipotizzano che l’ansia attivi il sistema nervoso simpatico e riduca la soglia di eiaculazione (Janssen et al., 2009).
Effetti dell’eiaculazione precoce sulla coppia e sulla qualità di vita
Le disfunzioni sessuali femminili presenti nella partner (come anorgasmia, desiderio sessuale ipoattivo, avversione sessuale, disturbi dell’eccitazione sessuale, e disturbi da dolore sessuale, come il vaginismo, potrebbero essere correlati alla eiaculazione precoce acquisita (Dogan e Dogan, 2008).
L’ eiaculazione precoce infatti può riguardare non solo chi né è affetto, ma anche il/la partner. Nel momento in cui una coppia affronta la eiaculazione precoce la situazione viene definita asincrona (Jannini & Porst, 2011, p.301). Una coppia asincrona può fare sesso anche molto frequentemente, ma la qualità del rapporto è assente o ridotta. Il partner non affetto da eiaculazione precoce può sentirsi deluso o irritato dal fatto che l’altro raggiunga l’orgasmo molto prima. E’ come se non ci fosse sincronizzazione, e questo crea una situazione frustrante per la coppia. Se la qualità del sesso è scarsa a causa dell’eiaculazione precoce, il partner che ne è affetto potrebbe sperimentare emozioni negative, che potrebbero portare a una risposta fisica sfavorevole. Così come in molte disfunzioni sessuali, è il significato che viene conferito al disturbo a poter influenzare il rapporto di coppia (Graziottin et al, 2011, p.306).
Nel momento in cui i significati attribuiti al disturbo portano a rabbia e delusione, sorgono conflitti di coppia che creano un senso di separazione sessuale tra i due partner.
Gli studi che hanno messo a confronto gli uomini affetti da eiaculazione precoce con quelli che non hanno il disturbo hanno mostrato una differenza marcata nella qualità di vita tra i due gruppi. In uno di questi studi, sono stati scelti 1,587 uomini affetti e non affetti da eiaculazione precoce e sono state poste loro domande riguardanti la loro vita personale e il senso generale di soddisfazione di vita. Per valutare accuratamente gli uomini, è stato impiegato un test chiamato Premature Ejaculation Profile (PEP). Gli uomini affetti da eiaculazione precoce hanno riportato un livello maggiore di stress, bassa autostima, livelli ridotti di funzionamento sessuale e un livello ridotto di qualità di vita (Graziottin et al., 2011, p.305). Gli uomini single possono essere influenzati dai sentimenti di imbarazzo legati al disturbo, tanto da rinunciare al corteggiamento. Il disturbo ha un impatto considerevole sulla vita degli uomini, che hanno una probabilità più alta di sviluppare una disfunzione erettile a causa delle emozioni di vergogna.
Graziottin et al. (2011) hanno indagato le differenze presenti in donne legate a un partner affetto da eiaculazione precoce rispetto a donne legate a uomini privi del disturbo. Il desiderio sessuale, la lubrificazione e gli orgasmi erano significativamente peggiori nelle donne legate a un partner con eiaculazione precoce, e il 52% di loro ha riportato problemi di orgasmo, mentre per le donne legate a un partner senza disturbo la percentuale è stata del 23%.
Il trattamento dell’eiaculazione precoce: un approccio cognitivo-comportamentale
Del 20-30% di uomini affetti da eiaculazione precoce, solo il 1-12% ha riferito di aver ricevuto trattamento (Patrick et al., 2005, p.359). Cercare un trattamento può rappresentare fonte di imbarazzo e le opzioni di trattamento potrebbero non essere chiare. Sono presenti forme di trattamento basate sui farmaci, sulla psicoterapia, o su una combinazione delle due cose (Steggall, Fowler, & Pryce, 2008, p.365).
Rowland et al. (2010) affermano che una delle opzioni migliori sia quella di abbinare la terapia farmacologica a una psicoterapia, e che quest’ultima sia l’intervento d’elezione per le forme di eiaculazione precoce naturale e soggettiva.
La terapia cognitivo-comportamentale è uno degli approcci più utilizzati per il trattamento dei disturbi sessuali, anche per l’eiaculazione precoce (Mohammadi et al., 2013). Il trattamento di questo disturbo comprende tre componenti generali: (a) la componente educazionale, nella quale si affrontano argomenti come anatomia e fisiologia sessuale, orgasmo ed eiaculazione, il ruolo dell’ansia, i meccanismi di condizionamento e il meccanismo di funzionamento dell’ eiaculazione precoce. Viene generalmente condotta in presenza del/della partner; (b) la componente comportamentale, che comprende l’apprendimento e l’applicazione di tecniche come lo squeeze, lo start-stop e il rilassamento; (c) la componente cognitiva, che riguarda l’esplorazione e la modifica delle cognizioni che possono predisporre al disturbo, oltre che costituire fattori precipitanti e di mantenimento, come le credenze che generano ansia.
La componente educazionale può includere informazioni sulla prevalenza della eiaculazione precoce e sullo IELT medio nella popolazione generale al fine di correggere false credenze e miti legati al disturbo. Inoltre può comprendere informazioni riguardanti varie attività sessuali appaganti alternative al coito, in modo da estendere il repertorio sessuale della coppia, assieme a strategie per affrontare l’evitamento dell’attività sessuale e l’indisponibilità al dialogo con il/la partner relativo a tematiche sessuali. Queste strategie educative sono studiate per fornire motivazione al trattamento farmacologico, ridurre l’ansia da prestazione, e attuare una prima modifica degli schemi sessuali maladattivi.
Una delle tecniche comportamentali più utilizzate nel trattamento dell’eiaculazione precoce è quella dello squeeze, o compressione (Masters e Johnson, 1970). Durante l’autostimolazione, nel momento in cui l’eiaculazione sembra inevitabile, viene applicata una pressione sotto il glande attraverso il pollice, l’indice e il medio. Tale operazione inibisce l’eiaculazione e dovrebbe essere ripetuta diverse volte prima di lasciarsi andare all’orgasmo.
In un secondo momento può essere applicata durante la stimolazione da parte del/della partner. Rappresenta uno step nell’apprendimento del controllo eiaculatorio, che successivamente può essere ulteriormente affinato tramite la tecnica dello stop-start (Seman, 1956). Tale tecnica consiste nel fermarsi e ritirare il pene durante il coito, nel momento in cui l’uomo percepisce di essere prossimo all’eiaculazione e di non poter più controllare il riflesso eiaculatorio. Il rapporto viene ripreso quando sente di aver recuperato completamente il controllo.
Per quanto riguarda la componente cognitiva, le osservazioni cliniche e i modelli teorici enfatizzano l’importanza delle strutture cognitive centrali (schemi o credenze centrali) sui processi sessuali disfunzionali (Carey, Wincze e Meisler, 1993; McCarthy, 1986; Rosen, Leiblum e Spector, 1994; Sbrocco e Barlow, 1996). Il modello cognitivo-affettivo di Barlow (1986) postula che l’interazione tra l’arousal del sistema nervoso autonomo (attivazione simpatica) e le interferenze cognitive svolga un ruolo centrale nel determinare risposte sessuali funzionali e disfunzionali.
Sbrocco e Barlow (1996) e Wiegel, Scepowski e Barlow (2007) hanno ulteriormente sviluppato il modello originale, affermando che la vulnerabilità degli schemi è una delle componenti principali implicate nelle disfunzioni sessuali. Sbrocco e Barlow (1996) ipotizzano che gli individui affetti da una disfunzione sessuale abbiano solitamente un insieme di credenze sessuali irrealistiche e inaccurate e assumano un atteggiamento rigido e inflessibile. Nel momento in cui questi standard di riferimento elevati e irrazionali non sono soddisfatti possono sorgere implicazioni personali catastrofiche, che facilitano lo sviluppo di una visione di sé negativa (self-schema negativo) e predispongono l’individuo allo sviluppo di difficoltà sessuali. La ristrutturazione di tali schemi negativi può portare a miglioramenti nelle disfunzioni, a un atteggiamento più positivo nei confronti del sesso, a maggiore piacere sessuale e a un miglioramento della relazione di coppia.