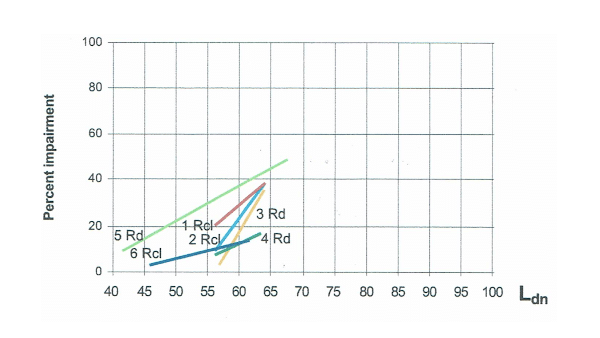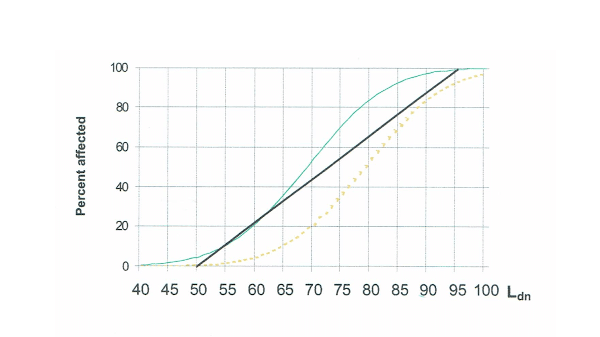Empatia nelle professioni sanitarie: punto di forza rischioso?
La crisi sanitaria cui stiamo assistendo oggigiorno, a causa dell’emergenza covid-19, ha inciso enormemente sul carico di lavoro degli operatori sanitari, sulla loro stanchezza fisica e sul loro benessere psicologico aumentando in maniera esponenziale i rischi dello sviluppo di sindromi da burnout.
Morelli Elisabetta e Poli Eleonora – OPEN SCHOOL Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Mestre
Le professioni in ambito sanitario sono caratterizzate, più di altre, da un costante coinvolgimento interpersonale e da un contatto con la sofferenza umana. Medici e infermieri, con un lavoro di squadra multidisciplinare, si confrontano quotidianamente con pazienti che rischiano la vita (Yoguero et al., 2017). La partecipazione emotiva è inevitabile e, se essa può arrecare soddisfazione e senso di efficacia personale, è per alcuni fonte di forte stress e rischio di burnout.
È dimostrato come un elemento chiave per la buona riuscita del trattamento del paziente sia l’empatia manifestata dalla figura curante (Walocha, Tomasewski, Wilczek-ruzyczka & Walocha, 2013). Essa aumenta la compliance del paziente e la sua fiducia nella terapia, migliora la prognosi di malattia e la soddisfazione della persona in cura e riduce il numero di azioni legali nei confronti del medico (Decety, Smith, Norman & Halpern, 2014; Fulop, Devecsery, Hausz, Kovacs & Csabai, 2011). I pazienti tendono inoltre a raccomandare il medico se esso è riconosciuto come empatico (Zenasni, Boujut, Woerner & Sultan, 2012).
Insomma è ormai chiaro che l’empatia nelle professioni sanitarie rappresenta un importante elemento che, associato a migliori competenze cliniche ed efficacia nella cura, produce un effetto positivo sulla qualità di vita dei pazienti così come del medico curante che valuta la relazione con i pazienti come fonte di maggiore soddisfazione personale.
Tuttavia l’empatia, pur essendo un punto di forza, può talvolta diventare rischiosa specie in ambiente sanitario in cui si ha a che fare con le situazioni più emotivamente angoscianti: malattia, morte e sofferenza in ogni forma. Questa dolorosa realtà può mettere a dura prova i professionisti sanitari portando a stanchezza da compassione, esaurimento, stress professionale e tutto ciò può tradursi in un basso senso di realizzazione e grave esaurimento emotivo.
Che cos’è, di preciso, l’empatia? In letteratura esistono diverse definizioni di empatia. Singer (2006), per esempio, definisce l’empatia in questo modo: empatizziamo con gli altri quando vi è uno stato affettivo il quale è isomorfo allo stato affettivo di un’altra persona, il quale è stato suscitato osservando o immaginando uno stato emotivo di un’altra persona e quando sappiamo che lo stato affettivo dell’altra persona è la fonte del nostro stato affettivo. In altre parole, l’empatia è l’abilità di vedere il mondo come lo vedono gli altri, essere non giudicanti, comprendere i sentimenti altrui mantenendoli però distinti dai propri. Si tratta di un costrutto multidimensionale caratterizzato da due componenti principali: empatia emozionale ed empatia cognitiva. L’empatia emozionale, detta anche contagio emotivo, è una risposta automatica che ci porta a provare la stessa emozione provata dalla persona che sta dinanzi a noi. L’empatia cognitiva, più sofisticata, consiste nella capacità di comprendere gli stati interni delle altre persone ed assumere il loro punto di vista. Si tratta di un processo intenzionale che coinvolge risorse esecutive e capacità di autoregolazione delle emozioni provate. Entrambe le forme sono necessarie poiché una persona potrebbe comprendere bene cosa pensa e prova l’altro, senza però “sentire” le emozioni dell’altro e averne compassione, oppure una persona può essere contagiata e travolta dalle emozioni degli altri, senza comprendere cosa avviene e distinguere i propri contenuti mentali da quelli dell’altro.
Dunque empatia è sinonimo di qualità della cura e migliore outcome terapeutico. Ma quali sono le conseguenze a lungo termine di tale assetto empatico? Un forte coinvolgimento emotivo nei riguardi del paziente è di beneficio anche al medico stesso o può essere invece causa di stress, esaurimento emotivo, e portare potenzialmente a burnout? La crisi sanitaria cui stiamo assistendo oggigiorno, a causa dell’emergenza covid-19, ha inciso enormemente sul carico di lavoro degli operatori sanitari, sulla loro stanchezza fisica e sul loro benessere psicologico. La rapidità di diffusione dell’epidemia, la scarsità di risorse e di luoghi di cura attrezzati, la gestione di turni stressanti, la carenza di personale ed il continuo confronto con situazioni di estrema sofferenza hanno aumentato in maniera esponenziale i rischi dello sviluppo di sindromi da burnout.
Il burnout, definito “patologia della relazione di aiuto” (Galam, 2007), è uno stato di esaurimento fisico, emotivo e mentale dovuto a un coinvolgimento, a lungo termine, in situazioni lavorative che sono ad alta richiestività emotiva. Questo stress occupazionale cronico ha implicazioni sia personali che interpersonali. Esso diminuisce l’interesse nel proprio lavoro e nel benessere del paziente, porta a minore comunicazione e ad una perdita di un’attitudine attiva verso il mondo esterno. Secondo il modello di Maslach, il burnout è definito da tre dimensioni tra loro interrelate: esaurimento emotivo, depersonalizzazione e scarsa soddisfazione personale. L’esaurimento emotivo si manifesta con perdita di entusiasmo sul lavoro ed un sentirsi privi di aiuto, intrappolati e sconfitti. La persona può manifestare sintomi quali mal di testa, aggressività e irritabilità, isolamento, ansia e depressione, disturbi del sonno, fino alla possibilità di mettere in atto comportamenti a rischio. La depersonalizzazione si verifica quando la figura sanitaria diventa cinica ed inizia a trattare il paziente con indifferenza, lo oggettivizza e sviluppa un’attitudine negativa verso i suoi colleghi e la professione. Il senso di scarsa autoefficacia è caratterizzato dal ritiro dell’individuo dalle sue responsabilità, da un distacco dal lavoro e dalla tendenza ad adottare una concezione di sé negativa come conseguenza di situazioni prive di ricompense e gratificazioni personali (Ferri, Guerra, Marcheselli, Cunico & Di Lorenzo, 2015; Romani & Ashkar, 2014). Se le conseguenze del burnout sono notevoli sull’individuo, altrettanto lo sono quelle sull’ambiente di lavoro. Nel professionista viene meno la capacità di essere di aiuto all’altro, si riduce così la qualità della cura ed aumenta l’insoddisfazione del paziente. Inoltre ritardi sul lavoro, assenteismo e licenziamenti comportano elevati costi per l’azienda.
Burnout ed empatia sono strettamente legati ma in letteratura vi sono risultati contraddittori in merito alla natura di tale relazione. Ciò riflette la varietà di ipotesi che cercano di spiegare la relazione causale tra insorgenza del burnout ed empatia (Thirioux, Birault & Jaafari, 2016; Vévodová, Vévoda, Vetešníková, Kisvetrová & Chrastina, 2016). L’empatia può essere causa del burnout o al contrario potrebbe rappresentare un fattore protettivo? Secondo la teoria della compassione (Figley, 2002), il burnout sarebbe legato a un eccesso di empatia, che renderebbe più vulnerabili ai fattori stressanti insiti nella professione; al contrario, secondo la teoria della dissonanza emotiva (Bonino, 2006), il burnout sarebbe associato a scarse abilità empatiche riscontrate soprattutto in persone con tratti alessitimici (Gleichgerrcht & Decety, 2013), cioè che presentano difficoltà nell’identificare, differenziare e descrivere le proprie emozioni in associazione a rappresentazioni mentali impoverite degli stati emotivi propri e altrui.
A quale teoria dare credito? Chiarezza può essere fatta considerando le due componenti principali dell’empatia: quella emozionale e quella cognitiva. L’empatia emozionale agisce come un riflesso e ci fa provare involontariamente ciò che prova l’altra persona, la sua sofferenza e ciò può portare ad iperarousal e ad un elevato distress. Il malessere dei pazienti e il loro costante bisogno di attenzione e ascolto porteranno ad essere emotivamente esausti e ad avvertire uno stato estremo di tensione, preoccupazione e incapacità di distacco dai problemi dei pazienti. In questo caso, lo stato emotivo negativo provato farà mettere in atto un’azione allo scopo di ridurre il malessere avvertito e non quello dell’altra persona con conseguente incapacità di prestare cure compassionevoli e di compiere diagnosi efficaci. Questo elevato distress personale, accompagnato a un distacco dall’altro, al fine di proteggersi dalla sofferenza, esporrà a un elevato rischio di sindrome da burnout (Hunt, Denieffe & Gooney, 2017).
L’empatia cognitiva permette di rappresentarsi gli stati mentali del sé e dell’altro come entità distinte e di regolare le proprie emozioni nelle diverse situazioni. Una persona con buoni livelli di empatia cognitiva sarà in grado di identificare quali emozioni appartengano a chi, durante il coinvolgimento empatico, sarà capace di operare il giusto coinvolgimento interpersonale con il paziente pur proteggendo i propri confini emotivi (Hunt et al., 2017). Ecco che allora il medico, oltre che il paziente, trarrà beneficio e soddisfazione dall’interazione e dal rapporto di cura con una conseguente riduzione dei potenziali rischi di sviluppare burnout. La capacità di regolare le proprie emozioni è cruciale. Senza tale abilità un eccesso di empatia emozionale potrebbe essere deleterio per il benessere della figura sanitaria e portare a un’incapacità di essere effettivamente d’aiuto al paziente. L’empatia emozionale può essere utile solamente nel momento in cui è mediata in maniera adattiva dall’empatia cognitiva e dalla capacità di autoregolazione altrimenti, può diventare un pericolo. La letteratura ha dimostrato che la vulnerabilità al distress nelle professioni di cura è specificamente legata a deficit nella regolazione delle proprie emozioni negative (Decety et al., 2014). Medici che hanno difficoltà a descrivere, identificare e regolare le proprie emozioni sembrano essere più inclini a esaurimento emotivo, distacco e basso senso di realizzazione. Al contrario, la capacità di consapevolezza sé/altro e di regolare le proprie esperienze emotive sembra contribuire al senso di compassione che viene dall’assistenza ai pazienti nella pratica clinica (Gleichgerrcht & Decety, 2013).
Quindi, la condivisione emotiva con scarsa autoregolazione e ridotta capacità di assumere la prospettiva dell’altro può portare a disagio personale, che diminuisce la preoccupazione empatica e il comportamento pro-sociale. Al contrario, un’empatia funzionale è data da un buon equilibrio tra la dimensione emotiva e quella cognitiva. Essere eccessivamente empatici con il dolore altrui senza avere le capacità di regolare le proprie emozioni, finisce per generare la sindrome da empatia, nota anche come stanchezza da compassione. Charles Figley (2002) la definisce come uno stato di profonda stanchezza e incessante preoccupazione per aver aiutato persone che hanno attraversato situazioni difficili o traumatiche.
L’approccio ideale per le figure sanitarie dovrebbe quindi essere quello di un’empatia clinica (Zenasni et al., 2012), che impedisce di essere troppo compassionevoli e simpatetici, ma senza per questo ignorare le reazioni emotive e i sentimenti dei pazienti. Essa implica la comprensione delle esperienze interne e delle prospettive del paziente come individuo separato, combinata con una capacità di comunicare tale comprensione al paziente. L’empatia clinica deve includere la capacità di distinguere il sé dall’altro in maniera tale da non provare le sue stesse emozioni e sofferenze. Questo protegge a lungo termine da esaurimento, da depersonalizzazione e aiuta a prevenire il burnout (Ekman & Halpern, 2015; Juszkiewicz & Debska, 2015).
Alla luce dei benefici che un approccio empatico può portare al benessere psicofisico dei professionisti della salute e dei pazienti, e agli elevati costi sociali ed economici che il burnout può comportare, è utile valutare quali possano essere le strategie che permettano di potenziare le abilità empatiche delle figure sanitarie evitando il burnout. Gli approcci evidence-based e la spinta tecnologica nella diagnosi e cura dei pazienti, senz’altro fondamentali e preziosi, possono far perdere la prospettiva umana sul paziente e condurre alla falsa idea che l’empatia sia estranea a tutto ciò e che non abbia rilevanza nel processo di trattamento e cura.
A livello organizzativo, nell’ambiente di lavoro, è importante favorire interazioni personali positive e creare un senso di appartenenza al gruppo, fornire feedback positivi all’operatore sanitario, curare il suo benessere e valorizzare il suo atteggiamento empatico (Haramati, Cotton, Padmore, Wald & Weissinger, 2017; Yoguero et al., 2017). Per quanto riguarda l’intervento sul singolo individuo, si è visto come l’empatia sia un’abilità che può essere imparata e sviluppata attraverso l’educazione e la pratica. Training empatici si sono rivelati efficaci sia su studenti universitari, sia su medici ed infermieri già avviati alla professione. Essi si focalizzano su abilità quali il dare attenzione all’altro, saper ascoltare se stessi e gli altri, saper automonitorare e autoregolare le proprie reazioni emotive, imparare l’ascolto attivo, acquisire maggior consapevolezza riguardo emozioni e pregiudizi che giocano un ruolo nella relazione di aiuto (Cunico, Sartori, Marognolli & Meneghini, 2012).
Pratiche di mindfulness hanno dimostrato un effetto significativo sulla riduzione del burnout tra gli operatori sanitari (Surguladze et al., 2018). La mindfulness potrebbe essere considerata più in generale come un’attitudine ad affrontare le situazioni emotive che ogni giorno, specie in questo periodo, il personale sanitario vive con un focus sull’esperienza attuale. Da questa prospettiva, la consapevolezza potrebbe avere un effetto positivo sulla regolazione delle emozioni nelle situazioni emotive quotidiane riducendo così ansia e stress e contribuendo al mantenimento dell’empatia.
L’empatia nell’ambito delle professioni sanitarie è un esercizio impegnativo che richiede flessibilità cognitiva e alti livelli di autoregolazione. Queste risorse cognitive possono diventare limitate a causa del lavoro impegnativo e molto stressante che espone medici e infermieri a una maggiore vulnerabilità per il burnout.
È importante saper riconoscere le emozioni negative suscitate dall’esperienza quotidiana e sapere che vi è la possibilità di parlare di esse e di burnout nell’ambiente di lavoro, senza incorrere nel rischio di essere stigmatizzati. Favorire programmi di formazione sull’empatia diventa quindi un obiettivo fondamentale per favorire il benessere professionale, specie in un momento storico come quello che stiamo attraversando.