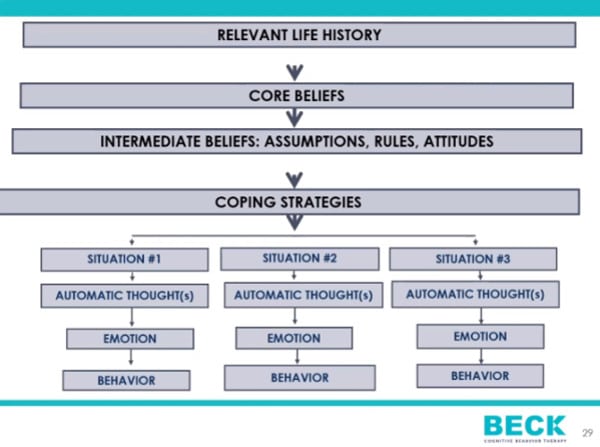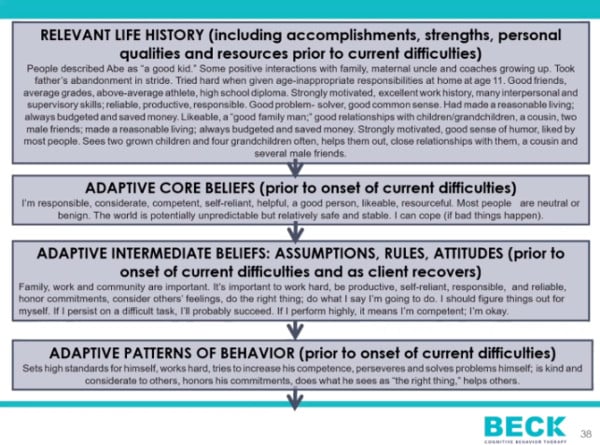Effetto Empatia. Le 7 chiavi delle neuroscienze per trasformare il nostro modo di amare, lavorare e comunicare (2020) di Helen Riess – Recensione del libro
L’empatia è necessaria e utile in ogni aspetto della vita umana. Helen Riess nel suo libro Effetto Empatia introduce le 7 chiavi dell’empatia.
Abstract
Cos’è che mi permette di entrare in relazione con qualcuno? Perché non sempre riusciamo ad esprimere le nostre emozioni e perché spesso interpretiamo in modo non corretto quelle degli altri? Tutti questi interrogativi possono riassumersi in un interrogativo solo: che cos’è l’
empatia? Può essere insegnata? Queste domande trovano risposta nel libro
Effetto Empatia. Le 7 chiavi delle neuroscienze per trasformare il nostro modo di amare, lavorare e comunicare, scritto dalla psichiatria Helen Riess che, dopo aver imparato le basi neuroscientifiche dell’empatia, sviluppò proprio un intervento di formazione sulla stessa testando poi i risultati attraverso uno studio randomizzato controllato.
L’empatia: la capacità umana che può essere insegnata
La dottoressa Riess, nel Dipartimento di Psichiatria del Massachusetts General Hospital (MGH) istituì l’Empathy and Relational Science Program in cui iniziò tutte quelle ricerche tese a mostrare come effettivamente l’empatia fosse una capacità che può essere insegnata, e che non fosse quindi solo una caratteristica innata dell’essere umano. Nelle ricerche condotte, sono stati reclutati medici specializzandi in sei discipline differenti per studiare se, dopo aver ricevuto una breve formazione all’empatia, le loro capacità di comprendere i segnali emotivi dei pazienti miglioravano e con esse la capacità di reagire in modo efficace. Nello specifico la formazione consisteva nell’imparare a interpretare in modo corretto le emozioni dei pazienti, attraverso lo studio del linguaggio del corpo e della postura. Non solo: è stato insegnato loro anche come gestire situazioni difficili e avere un controllo sulle proprie emozioni. Come avveniva la valutazione? Erano direttamente i pazienti a valutare le capacità empatiche dei medici, prima e dopo la formazione, senza che i pazienti stessi sapessero i dettagli dello studio. Il risultato: l’empatia poteva essere insegnata e appresa. I medici che parteciparono alla formazione, infatti, ricevevano un punteggio decisamente più alto sulla scala dell’empatia rispetto a chi non aveva preso parte alla formazione. Questo incremento di empatia porta con sé altri due risultati: i pazienti si fidano di più del proprio medico portando beneficio anche alla salute stessa, ma non solo. I medici che hanno un livello maggiore di empatia nelle interazioni con i propri pazienti risultano più soddisfatti del proprio lavoro e quindi meno esausti.
Helen Riess arrivò così a fondare la Empathethics Inc., un’azienda il cui focus è la formazione all’empatia attraverso le cosiddette 7 chiavi dell’empatia.
Prima di addentrarci nello specifico del libro Effetto Empatia, la Riess sottolinea che l’empatia ha componenti sia emotive che cognitive, motivo per il quale quando proviamo una reazione empatica, e quindi sentiamo quanto sente l’altro, riusciamo a reagire in modo appropriato e non come se poi quell’emozione specifica fosse davvero la nostra.
Che cos’è l’empatia? Quali sono le sue dimensioni?
Prima di addentrarsi nel vivo dell’empatia, Helen Riess fa un excursus su questo termine. Vediamo la comparsa del termine empatia agli inizi del ‘900 con il termine tedesco Einfühlung che equivale e dire ‘immedesimazione’. Questo termine veniva utilizzato dagli esteti tedeschi con l’intento di descrivere l’esperienza di osservare un’opera d’arte fino ad arrivare a sentirsi parte dell’esperienza emotiva evocata. Il primo significato dato quindi all’empatia è legato a una connessione con l’arte. Vediamo poi nel corso del tempo come questo termine viene confuso con altri. È un esempio la differenza tra la parola sympathy ed empathy: la prima è provare un senso di pena per qualcuno, quindi più simile alla compassione, la seconda invece implica il senso di condivisione dell’emozione.
A questo punto emblematico è il rimando allo psicologo Carl Rogers che sottolinea l’importanza del come se: io posso condividere l’emozione dell’altro, ma come se fosse la mia, altrimenti, se mi concentrassi solo sul mio disagio non potrei arrivare ad una risposta empatica e quindi a fornire il mio aiuto. Bisogna quindi comprendere la differenza tra empatia proiettiva e autentica proiezione empatica. Nella prima non si crea un’esperienza di connessione, ma viene utilizzata l’esperienza dell’altro per poter parlare delle proprie esperienze. L’empatia comprende invece la nostra capacità cognitiva dei sentimenti degli altri, distinguendo quindi i nostri sentimenti dai loro, come sottolineò nel 1955 il Reader’s Digest.
Arriviamo così al 1959, quando lo psicoanalista Heinz Kohut definisce l’empatia come un’introspezione vicariante, quindi come la capacità di considerare i sentimenti degli altri come se fossero i nostri, ma in un secondo momento analizzarli in modo oggettivo.
Dopo un breve excursus sul termine empatia si entra più nel vivo di cosa sia questa capacità umana. Molte ricerche hanno dimostrato che le stesse reti neurali che si attivano quando si vive un’esperienza, ad esempio di dolore in prima persona, sono le medesime che si attivano quando si osserva qualcuno viverla. Il nostro cervello è pronto e predisposto a provare dolore per gli altri fondamentalmente per due ragioni. Una si può definire per sopravvivenza: il cervello osserva cosa provoca dolore nell’altro e lo evita per se stesso. In secondo luogo, ma non meno importante, si prova dolore anche solo guardando qualcuno provarlo, in modo da aiutarlo. Ci sono dei neuroni specializzati in questo, nel capire cosa accade all’altro in quel substrato di mente che si può definire intelligenza della mente condivisa.
Molte ricerche ancora dimostrano come l’empatia sia cablata nel nostro cervello e abbia tre dimensioni: affettiva, cognitiva e la preoccupazione empatica.
Riassumendo: prima condividiamo il sentimento altrui, in un secondo momento – grazie all’aspetto cognitivo – comprendiamo cosa l’altro sta provando e per ultimo, l’unione di questi due aspetti porta alla ‘reazione empatica’: ci preoccupiamo concretamente di offrire il nostro aiuto all’altro. Non sempre però questa reazione porta ad un atto concreto, spesso sfocia ‘semplicemente’ in un senso di compassione.
Una vera svolta dell’empatia si ha nel 1996 quando un gruppo di ricercatori a Parma, guidati da Rizzolatti, fece una scoperta – per serendipity – eccezionale. Nello specifico ciò che scoprirono fu che l’area della corteccia premotoria, chiamata F5, dei macachi, si attivava sia quando erano loro stessi a compiere un’azione, sia quando la vedevano compiere. Senza volerlo scoprirono i neuroni specchio.
Dopo il 1996, furono molti gli studi sulla reazione emotiva di fronte le emozioni degli altri, come quelli della neuroscienziata Singer nel 2004, che in un suo articolo parla della reazione che abbiamo quando osserviamo il dolore altrui dimostrando come nel campo della scienza si cominci a spostare l’attenzione, dalle emozioni individuali, alle reazioni di chi vede l’emozione dell’altro.
In-group e l’out-group: cosa fa scattare l’empatia
Le tante scoperte in ambito scientifico sull’empatia mostrano che a livello neurobiologico siamo tutti connessi, ma ci sono degli aspetti che possono aumentare o diminuire il nostro grado di empatia.
Proviamo infatti maggiore empatia per le cause che ci sono più vicine, tendenza che viene chiamata dagli psicologi favoritismo dell’in-group, a discapito dell’out-group. Qui un punto fondamentale: alcuni studi hanno dimostrato che in molti individui anche il colore della pelle inficia sulla reazione empatica. Ad esempio hanno dimostrato che soggetti bianchi hanno un ritardo nel valutare espressioni di soggetti con la pelle nera. Ciò porta con sé una conseguenza che dovrebbe essere naturale: formare all’empatia è fondamentale per non continuare a rischiare che la nostra società compia errori legati all’incomprensione emotiva. Alla luce di tutte queste scoperte, una formazione all’empatia è necessaria perché ci sono molte professioni che possono portare alla compassion fatigue, come medici, insegnanti, infermieri. Un equilibrio tra l’empatia cognitiva e quella affettiva è pertanto necessario. Anche chi cerca di compiacere gli altri in ogni momento rischia questa specie di burnout. Spesso infatti chi cerca di fare felice qualcuno, crede di farlo perché mosso da empatia, ma magari il più delle volte lo fa per sentirti accettato. Come si capisce questo? Perché ci aspettiamo qualcosa in cambio e quando questo tarda ad arrivare ci adiriamo. Tra le storture dell’empatia, o per utilizzare le parole dell’autrice del libro, un’altra forma di impostura dell’empatia, è quella rappresentata dai cosiddetti ‘genitori elicottero’, quelli cioè che sono troppo protettivi nei confronti dei propri figli. In questo modo, i loro figli non avranno mai la possibilità di sviluppare le proprie capacità. Non solo: si aspetteranno che in ogni ambito, come quello lavorativo, ci sia questo trattamento di protezione.
È evidente dunque come una formazione all’empatia sia necessaria e utile in ogni aspetto della vita umana. È qui che Helen Riess introduce quindi le già citate 7 chiavi dell’empatia.
E.M.P.A.T.H.Y.® e le sue 7 chiavi
La comunicazione non verbale e l’empatia sono i due aspetti che ci potrebbero rendere migliori come esseri umani, eppure sono i due aspetti che vengono più lasciati da parte in ambito educativo. Fin da piccoli ci viene insegnato cosa dire e al massimo come dirlo, ma nessuno ci insegna come essere e come lasciare che gli altri siano. Imparare invece a migliorare la comunicazione non verbale migliorerebbe molti aspetti, primo tra tutti quello tra medico e paziente. Si instaura qui il discorso sul programma innovativo messo a punto dalla psichiatria Riess: E.M.P.A.T.H.Y.®
Inizialmente pensato in ambito sanitario, questo programma mira alla formazione empatica di medici e può essere esteso a tutte le categorie e professioni. L’obiettivo è solo uno: costruire relazioni più empatiche con il mondo. Per ogni lettera dell’acronimo ideato, c’è un significato della sua teoria.
Analizziamoli brevemente uno per uno.
La lettera ‘E’ sta per ‘entrare in contatto con l’espressione dell’altro’, il cervello infatti è molto sensibile agli sguardi. La ‘M’ sta per ‘muscolatura facciale’. Le espressioni facciali infatti mostrano molto di ciò che si sta provano interiormente, cogliere quindi il giusto significato delle espressioni altrui ci permette di entrare più facilmente in empatia. La ‘P’ per ‘postura’. Questa, come le espressioni, rivela come si sente davvero la persona che abbiamo di fronte. La ‘A’ per ‘affetto’, il termine scientifico per indicare l’emozione. Noi dobbiamo essere in grado di cogliere e di saper dare un nome all’emozione dell’altro, solo in questo modo siamo in grado di comunicare con qualcuno. La ‘T’ per ‘tono di voce’, che trasmette più del 38% del contenuto emotivo della comunicazione non verbale. La ‘H’ sta per ‘ho uno ascolto attivo’. L’ascolto empatico è proprio quello attivo e riflessivo che è molto difficile perché implica il dover mettere da parte le proprie emozioni a favore del sentire altrui. Dal punto di vista neurologico l’ascolto empatico implica che cerchiamo di ignorare i segnali di pericolo che ci manda l’amigdala mentre ascoltiamo il racconto dell’altro. Questo tipo di ascolto permette di entrare in sintonia con l’altro su due livelli: emotivo e cognitivo. In psicologia si utilizza l’esercizio del ‘parla-ascolta’ che consiste proprio nel parlare per dieci minuti, prima l’uno e poi l’altro, senza interruzione alcuna. Bisogna prestare attenzione al motivo per cui una persona è così turbata, in questo modo si riesce magari a trovare soluzioni a cui non si era arrivati prima. Infine, la lettera ‘Y’ sta per ‘you, la vostra risposta’ e con questo non si intende una risposta verbale. La risposta dell’empatia infatti, viene avvertita prima di tutto a livello fisiologico grazie ai circuiti cerebrali condivisi. Si inserisce in questo discorso uno studio del ricercatore Carl Marci che ha indagato se ci fosse una correlazione fisiologica tra i medici e i pazienti durante le visite e se questa correlazione fisiologica fosse correlata alle valutazioni sull’empatia dei medici fornite dai pazienti. Il risultato di questa ricerca è che, se manca la risposta empatica, non c’è neanche la sincronizzazione fisiologica che altrimenti esisterebbe.
Le 7 chiavi dell’empatia ci aiutano dunque ad affinare e ad incrementare questa capacità umana, cercando così di evitare quella divisione vista prima tra l’in-group e l’out-group per non parlare anche della tendenza dell’essere umano a creare un out-group anche all’interno del proprio in-group distruggendo così interamente l’empatia.
Una formazione alla stessa, ci aiuterebbe nella direzione di ricostruzione piuttosto che distruzione.
L’empatia che nasce e cresce con noi
Il sesto capitolo, Crescere con empatia, è molto interessante perché affronta il tema dello sviluppo della capacità empatica. Dal momento in cui veniamo al mondo, attraverso lo sguardo dei nostri genitori, ci imbattiamo per la prima volta nell’esperienza empatica. Gli schemi empatici iniziano intorno all’età di due anni, ma già appena nato il bambino, con il rapporto dei genitori, è posto di fronte l’empatia, nonostante ancora la sua teoria della mente (quella per cui sono consapevole che ognuno ha i propri stati mentali) non sia ancora sviluppata. Ogni bambino impara poi a sviluppare l’empatia secondo i propri tempi, così come si impara qualsiasi altra capacità, ad esempio il camminare. Un momento cruciale per lo sviluppo cognitivo dell’empatia sembra rintracciarsi intorno agli 8 anni, quando il bambino sviluppa alcune abilità cognitive come l’assunzione di prospettiva grazie alla quale comprende la condizione di vita della persona che ha di fronte. È tra la preadolescenza e l’adolescenza che gli schemi empatici si consolidano iniziando così a delineare che tipo di persona compassionevole sarà il bambino. Arrivando all’adolescenza, il ragazzo utilizzerà già le sette chiavi dell’empatia precedentemente descritte. In questo hanno un ruolo fondamentale tutte le influenze che il bambino sperimenta, ma soprattutto i genitori che sono lì con e per lui fin dal principio.
Emerge qui la differenza tra due concetti fondamentali per la cura del bambino: l’empatia prossimale e distale. La prima rappresenta una reazione immediata, la seconda ritardata. È fondamentale equilibrare entrambe, un’empatia prossimale è necessaria qualora il bambino piccolo si trovi di fronte un pericolo, ma ci sono dei casi in cui questa empatia è fuori luogo perché incide, o per meglio dire, interferisce, nella vita del piccolo, inficiando quindi il suo sviluppo. Ci sono dei casi infatti in cui è necessario applicare l’empatia distale, ovvero riuscire a fare un passo indietro; questo poi avrà una conseguenza positiva nel bambino, come l’avergli insegnato un’importante lezione di vita. L’esempio che fa l’autrice è calzante: se vostro figlio vi chiede una giustificazione per non aver svolto i compiti, vi sentirete spinti – dall’empatia prossimale – ad aiutare vostro figlio firmandogli la giustificazione. Ma questa è davvero la cosa giusta da fare? O sarebbe il caso – applicando l’empatia distale – di fare un passo indietro non cedendo a favore del suo futuro, perché affrontare le conseguenze della propria pigrizia lo aiuterà a non farlo di nuovo?
È importante comunque sottolineare che eventuali ‘intoppi’ in questo equilibrio empatico non pregiudicano irreparabilmente il futuro del bambino. In aggiunta, il modo in cui l’empatia viene percepita da ognuno di noi, fin dai primi anni di vita, tiene conto di varie combinazioni, quali l’ambiente o il momento: in sostanza il valore dell’empatia varia in ogni istante. La psichiatra rassicura quindi il lettore, sottolineando che non è mai troppo tardi per condurre il bambino ad una giusta e sana comprensione dell’altro. Questo sarà fondamentale in seguito per costruire delle relazioni sane e felici, a differenza di bambini meno empatici che tendono ad adottare di fronte agli altri e alle emozioni, un atteggiamento più aggressivo e insicuro.
Uno dei primissimi modi in cui un genitore insegna l’empatia è attraverso il rispecchiamento. Fu lo psicanalista Heinz Kohut – il fondatore della psicologia del sé – il primo a riconoscere l’importanza del rispecchiamento genitoriale per la crescita sana di un individuo. Il rispecchiamento consiste nel riflesso automatico delle sue espressioni facciali, schemi linguistici e atteggiamenti. Decenni prima che fossero scoperti i neuroni specchio, Kohut parla di transfert speculare, quel fenomeno per cui i bambini rafforzano il proprio senso del sé riflettendosi nei genitori. Utilizzando le parole dell’autrice: ‘significa che i bambini vedono riflessi negli occhi di chi li accudisce i propri punti di forza, la propria unicità e ciò che li rende speciali’. La mancanza di questo rispecchiamento genitoriale ha un impatto nocivo sullo sviluppo del sé. Il bambino che viene privato dell’attenzione, e quindi del rispecchiamento del genitore, tenderà a sviluppare un attaccamento insicuro che sfocerà in una personalità insicura che si rifletterà su tutti gli aspetti della sua vita. L’essere visti è fondamentale anche per sviluppare l’empatia in un bambino che è sempre alla ricerca dello sguardo dei genitori che, mancando, non permette loro di interiorizzare la validazione di sé, cercando continuamente conferme del fatto che in loro non ci sia nulla di sbagliato. Inoltre, è bene ricordare che i bambini imparano o meno l’empatia anche attraverso dei modelli comportamentali, ovvero tenderanno a idealizzare qualcuno ricercando schemi normativi nella propria vita.
È vero però anche il contrario: un eccesso di rispecchiamento può, allo stesso modo di quando se ne viene privati, portare a sviluppare un senso di sé in parte distorto e una scarsa empatia.
Un altro punto di questo capitolo che merita attenzione è che la grande diffusione degli schermi tecnologici, che in qualche modo sostituiscono gli sguardi, potrebbe ostacolare la creazione di legami forti, così come può impedire il rilascio di ossitocina, che avviene proprio in quelle occasioni in cui genitori e figli incrociano il loro sguardo. In questo modo, stando quindi di fronte a degli schermi piuttosto che di fronte ad uno sguardo, si impedisce anche all’empatia di accrescere, proprio perché si elimina ogni possibilità di vedere e sentire l’altro.
Altro concetto fondamentale che fa parte del crescere con empatia è quello del gemellaggio. Quando il bambino cresce tenderà infatti a creare dei legami fuori dall’ambito prettamente familiare e questo lo aiuterà nel rafforzamento del senso di sé. Il gemellaggio innesca un rapporto di fiducia tra due individui che stanno crescendo e questo lo aiuterà a mostrare all’altro le proprie fragilità sviluppando così l’empatia. Se questa esperienza viene sperimentata nei primi anni di vita, accresce la possibilità di influenzare positivamente le esperienze future di relazione. La privazione di questa può invece portare il bambino all’isolamento, generando comportamenti antisociali proprio per nascondere quella solitudine che a sua volta nasconde il senso di vergogna per la condizione in cui ci si trova. Per questo motivo i genitori devono incentivare l’incontro dei propri figli con gli altri bambini, dal momento che questo aiuta alla costruzione dell’empatia. Allo stesso tempo i genitori, durante i primi mesi del bambino, devono incentivare la cosiddetta frustrazione ottimale, fondamentale anch’essa nella formazione della capacità empatica. Intervenire subito e in modo eccessivo quando il proprio bambino piange, impedirà a questo di fare esperienza dell’attesa, attesa poi ripagata, che è necessaria per costruire un rapporto di fiducia teso quindi alla costruzione dell’empatia. Uno dei risvolti particolari dell’empatia risiede nel fatto che i circuiti cerebrali che condividiamo con i nostri figli sono così forti che ogni sua sofferenza genera in noi una sofferenza emotiva. In questo modo la nostra corteccia prefrontale si disattiva, di conseguenza il nostro raziocinio viene meno e siamo quindi spinti ad accontentare il nostro bambino pur di vederlo felice. Il passo che invece bisogna fare è indietro, per riconsiderare il tutto e capire se in quell’occasione faremo bene o male ad accontentarlo. Serve dunque cercare un giusto mezzo, tra l’esserci troppo e l’esserci troppo poco.
Dopo aver illustrato l’importanza dell’empatia nell’ambito della famiglia e quindi durante i primi anni di vita di un individuo, Helen Riess, si concentra sull’importanza dell’empatia anche in un altro ambito, quello dell’istruzione. L’empatia infatti fa una differenza rilevante nell’apprendimento. Il compito degli insegnanti in questo senso risiede nel saper assumere e comprendere il punto di vista dei propri studenti e avere quindi una teoria della mente molto solida. Come nell’ambito familiare, anche nell’istruzione è bene incentivare comportamenti equilibrati per quanto riguarda l’empatia. Nel dettaglio: bisogna favorire l’apprendimento ottimale attraverso un atteggiamento di rispetto a sfavore di una punizione (anche se meritata) tesa a mettere in imbarazzo l’alunno credendo che così capisca dove ha sbagliato. È interessante sottolineare a questo punto che il cervello dei ragazzi, durante tutta l’educazione scolastica, si modella e si plasma. Non aumenta di volume, ma rafforza le proprie connessioni tra le regioni che sono proprio alla base dell’apprendimento. Specialmente nell’età adolescenziale le aree del cervello legate alla socialità sono particolarmente attive, è per questo che l’adolescenza è un periodo molto delicato e cruciale per lo sviluppo della capacità empatica. Qui si inserisce quindi un altro discorso molto importante: sarebbe utile sfruttare approcci educativi che insistano proprio sulla natura sociale del cervello. È il caso del progetto PBL, Project Based Learning che ‘si basa sull’idea che le persone, specie i bambini, imparano ponendo domande, riflettendo sui concetti e interagendo con altri. Il concetto fondamentale […] è che si possono risolvere problemi del mondo reale sia attraverso esercizi di problem-solving sia con progetti di gruppo’. A scuola si possono dunque utilizzare le sette chiavi di E.M.P.A.T.H.Y.® per insegnare ai propri studenti ottenendo un maggiore risultato. E non solo: durante i primi di anni di vita di un individuo, come è stato già ampiamente mostrato in relazione al rapporto con i genitori, si gettano le basi per come sarà la personalità dello stesso. La scuola in questo senso, con i suoi insegnanti, ha la possibilità di gettare le basi per una buona e solida capacità empatica grazie alla quale questi ragazzi diventeranno adulti che sono in grado di comprendere le emozioni e prendere decisioni giuste e ponderate.
Oggi in molte scuole elementari si sta applicando un metodo educativo proprio di questa capacità. Sono infatti disponibili dei corsi di Open Circle in cui si insegna ai bambini sia ad esprimere le proprie emozioni, sia ad ascoltare quelle degli altri. Emblematico l’interrogativo che porta l’autrice di Effetto Empatia proprio a questo punto: ‘Come sarebbe il nostro mondo se tutti imparassero all’asilo ad ascoltare e a reagire ai sentimenti?’. È un interrogativo che dovremo porci tutti.
Dov’è l’empatia dietro uno schermo digitale?
Viviamo ormai in un mondo digitalizzato, dove non ci rispecchiamo più negli occhi degli altri, ma in uno schermo digitale che il più delle volte ci offre una realtà distorta. Quali sono le conseguenze di questo nel nostro cervello? E nella nostra capacità empatica? La conseguenza di ciò che accade a livello cerebrale a causa di tutta questa digitalizzazione – o per meglio dire, nell’uso che se ne fa – ha inevitabilmente delle conseguenze sulla nostra empatia. Il meccanismo ‘digitale’ per cui si salta da un sito all’altro, da una notizia all’altra, non portando approfondimento di nessun genere, fa sì che il nostro cervello abbia interazioni più veloci giungendo così a giudizi più affrettati. In questo modo è inevitabile che l’empatia venga scansata a favore di un’empatia superficiale, del tutto inesistente. Davanti ad uno schermo alcuni strumenti dell’empatia visti precedentemente, il contatto visivo tra tutti, viene meno e questo ci porta ad essere ‘comunicatori meno empatici’. In aggiunta, attraverso la comunicazione digitale, le conversazioni diventano più ambigue. L’emozione dell’altro viene dedotta, non attraverso lo scambio di informazioni quali lo sguardo o il tono di voce, ma prendendo in considerazione altri dettagli superficiali e fuorvianti, come il ritardo nella risposta o il tipo di emoticon utilizzata. Altra conseguenza dell’aumento del digitale nelle nostre vite, è l’aumento dell’insicurezza che nasce dal fatto che attraverso i social network vediamo la rappresentazione delle vite altrui come perfette, nelle quali sembra non esistere imprevisto. Il fatto però è proprio questo: sembra. Quanto di ciò che vediamo attraverso la finestra digitale è vero?
Tutto ciò, come si traduce a livello cerebrale? Con dei cambiamenti che non giocano a favore della specie umana. Ciò che sta cambiando in modo fondamentale sono i sistemi di ricompensa. Degli studi hanno rivelato infatti che il nostro cervello rilascia dopamina quando sente il suono di una notifica del proprio cellulare, e ne rilascia di più di quando legge poi l’effettivo messaggio. Si ipotizza anche una diminuzione della capacità di concentrazione a causa di un cervello che si adatta al ricevere informazioni brevi. Altri studi dimostrano come gli adolescenti fatichino a comprendere le espressioni degli altri e questo accade perché le interazioni faccia a faccia vengono sempre meno. Questo non accade sono negli adolescenti, in cui la capacità empatica si sta sviluppando, ma anche negli adulti dal momento che, così come l’empatia può essere imparata, è vero anche il contrario.
Passando infatti tutto il tempo di fronte ad uno schermo si perde la capacità empatica incentivata invece nell’incontro con l’altro.
Le emoji in qualche modo rivestono il compito che hanno il tono di voce e lo sguardo in una conversazione. L’utilizzo di queste in qualche modo ha reintrodotto la dimostrazione delle emozioni, ma non possono ovviamente sostituire l’empatia. Bisogna ricordare che l’empatia è un tratto tipicamente umano, e a questo proposito l’autrice sottolinea come sarebbe triste se un giorno tratti che sono così tipicamente umani, fossero affidati a delle fredde macchine. Un conto è farsi aiutare da esse, un conto è farsi sostituire.
L’empatia nell’arte: come cambiare cuore e mente
L’arte in ogni sua forma ha la possibilità di influenzare le nostre giornate. Qui la Riess fa una carrellata storica del concetto di empatia, nonché dell’empatia stessa. Come abbiamo già visto, il primo utilizzo del termine tedesco Einfühlung fu del filosofo dell’arte Vischer per descrivere la sensazione che suscita l’osservare un’opera. Il filosofo e psicologo tedesco Lipps estese questo termine alla comprensione interpersonale, Dilthey invece lo utilizzò per descrivere il processo per cui una persona arriva a conoscere, ma soprattutto a comprendere ciò che una persona sente e prova; questo è ciò che precedentemente è stato definito teoria della mente. Un ultimo interessante rimando è al filosofo inglese Titchener, che coniò il termine empathy traducendo il termine originario tedesco. Il motivo era che voleva esprimere in questo modo la capacità di comprendere gli stati emotivi degli altri come se fossero i propri. La differenza tra l’empatia nella vita quotidiana e quella dell’arte è che quest’ultima si identifica in un processo. Semplificando: non è detto che guardando l’arte in ogni sua forma è certo che proviamo quanto effettivamente intende trasmettere l’autore. È quella che Riegl chiama ‘la parte dell’osservatore’. L’arte in ogni sua forma è un esercizio di empatia perché rappresenta la percezione e la risposta tipica dell’empatia, oltre a rappresentare un atto di condivisione che può aiutare ad umanizzare qualsiasi settore.
E nella leadership che ruolo ha l’empatia?
È stata appena accennata l’importanza dell’empatia in ogni tipo di settore, non sono da meno la politica e la leadership. Quest’ultima ha inevitabilmente a che fare con le emozioni infatti: ‘i grandi leader sono estremamente sensibili alle emozioni altrui e sono molto bravi a regolare le proprie’. A questo si aggiunge il fatto che, neurobiologicamente parlando, tendiamo a prediligere un leader che esprima emozioni ed empatia. In questo contesto si inserisce lo psicologo Goleman con la sua idea di intelligenza sociale. Nel dettaglio, Goleman ha descritto come la leadership empatica riesca a modificare la chimica cerebrale non solo di chi segue un leader, ma anche del leader stesso. Cosa succede infatti nel nostro cervello? A livello chimico accade che i neurotrasmettitori come endorfine, dopamina, ossitocina e serotonina tendono a dare forza ai legami sociali. A livello neurale invece i circuiti condivisi riflettono i pensieri di un leader spingendo all’imitazione.
Interessante è accennare anche ad altri due neuroni che hanno un ruolo importante nella condivisione sociale nel caso della leadership. Le cellule fusiformi e i neuroni oscillatori. Spiegando brevemente: le prime – che si trovano nella corteccia cingolare anteriore e nell’insula – hanno la capacità di raggiungere gli altri neuroni grazie alle proprie ramificazioni e questo permette loro di potenziare le sensazioni del cervello. Attiva quello che Goleman chiama sistema di guida sociale, che aiuta a creare (o meno) un rapporto tra leader e seguaci. I secondi, quindi i neuroni oscillatori – che si trovano nel sistema nervoso centrale – sono ‘i coreografi del movimento fisico tra gli individui e nell’ambito di un gruppo’. Questi, nella leadership, stabiliscono una connessione con il gruppo. Basti rapportare tutto questo discorso nel luogo di lavoro: quanto lo stato d’animo del capo incide su tutti? Un leader che non riesce a trasmettere empatia, ma che trasmette solo ansia, può causare anche danni psicologici alle persone che ha intorno.
Ci sono invece leader che si approfittano di una falsa empatia, come? Approfittando dei bisogni dell’uomo, quelli in cima a quella che nel 1943 Abraham Maslow definì come la gerarchia dei bisogni. Le persone, secondo questa teoria, si concentrano prima sui bisogni ritenuti primari, come il cibo, il senso di appartenenza e solo in seguito perseguono bisogni più filosofici come ad esempio l’ideale di democrazia. Sfruttando quindi la paura della perdita dei beni per sopravvivere, un leader utilizza falsa empatia per raggiungere il consenso.
Quando l’empatia è difficile da trovare
Negli individui autistici, l’empatia presenta un deficit per cui è difficile per loro, se non impossibile, assumere la prospettiva dell’altro. La loro difficoltà sta nel decifrare l’espressione dell’altro, come ha studiato lo psicologo Simon Baron-Cohen. Le persone con disturbi dello spettro autistico, invece che giudicate, vanno comprese e aiutate. Loro sono quelle che secondo Baron-Cohen possiedo un grado zero positivo dell’empatia. Cosa vuol dire? Che la loro mancanza d’empatia non si scatena in azioni cattive o malvagie.
Cosa accade però quando siamo di fronte a un individuo che possiede un grado zero negativo dell’empatia? Parliamo di tutti coloro che compiono azioni malvagie, il più delle volte non provando nemmeno rimorso. Ricerche scientifiche hanno mostrato che anche in loro si presenta un danneggiamento nelle aree implicate nell’empatia. Non si ha ancora tutto il quadro neurobiologico completo, ma alcune ricerche, come quelle del neuroscienziato Jean Decety, hanno indicato come il cervello degli psicopatici differisca da quello degli altri. È come se non fossero in grado di percepire la paura delle loro vittime, mancano dei circuiti cerebrali condivisi.
Subentra qui un discorso che possiamo definire più filosofico. Provare empatia per queste persone, per tutte quelle quindi che identificano nell’out-group qualcuno da abbattere e per tutte quelle che compiono azioni deplorevoli, è difficile, se non impossibile. Cosa succede però se arriviamo a definire chi merita empatia e chi no? In questo caso l’empatia, invece di essere la regola, diventerebbe l’eccezione. Anche se difficile, il salto di qualità sarebbe quello di capire prima di giudicare, senza eccezione alcuna. Emblematico in questo senso quanto troviamo scritto: ‘comprendere […] non impedisce di attribuire responsabilità’, allo stesso tempo però comprendere cosa porta a compiere determinate azioni ci permette di trovare modi costruttivi per procedere in società.
Provare empatia per noi stessi: l’autoempatia
La comprensione che è giusto provare nei confronti degli altri e dei loro sentimenti, è la stessa che dovremo provare per noi. Quando invece ci troviamo di fronte noi stessi, quello che facciamo continuamente è autocriticarci, mentre invece dovremmo adottare autoempatia. Non dedichiamo mai del tempo a decifrare le nostre emozioni o a decifrare le nostre espressioni facciali, eppure farlo ci aiuterebbe a stare meglio. Uno studioso, psicologo del pianto, Adrianus Vingerhoets, ha rilevato che a seguito della visione di un film triste, le persone che avevano pianto, mostravano un umore migliore; questo potrebbe derivare dal fatto che il pianto ci aiuta a riprenderci da una forte emozione. Dare un nome a quello che stiamo temporaneamente provando, aiuta la nostra corteccia prefrontale a prendere le distanze da quanto stiamo vivendo, cercando quindi una reazione razionale. A questo proposito è importare ascoltare il nostro corpo. Lui ci invia tutti i segnali utili per capire cosa ci farebbe stare bene, dovremmo dare quindi modo a noi stessi di ascoltarlo.
La nostra probabile reticenza nell’autoempatia risiede nel fatto che temiamo essere giudicati come chi si sta autocommiserando. In realtà la differenza tra le due è sostanziale. Con l’autocommiserazione tendiamo a ‘permetterci’ di cedere di fronte ogni situazione, rifugiandoci anche in soluzioni dannose come l’uso di droghe o alcol. L’autoempatia, al contrario, è come una disciplina che richiede consapevolezza e studio. Di cosa? Di noi stessi, del nostro strato umano per cui meritiamo comprensione e lo studio di soluzioni efficaci e positive.
Questo esercizio e atteggiamento di autoempatia ha delle conseguenze anche sul rapporto con gli altri. È inevitabile infatti che, imparando ad esercitare empatia su noi stessi, saremo in grado di esercitarla anche con gli altri. Purtroppo però ha una competenza psicologica sottovalutata l’autoempatia. Viene confusa con la ‘voglia di non fare nulla’. In realtà invece molti studi hanno dimostrato che chi è autoempatico ha più vitalità rispetto a chi ha un atteggiamento critico nei confronti di se stesso.
Tirando le somme
Attraverso questo libro, di facile comprensione anche per chi non è del settore, Helen Riess mostra come, attraverso una formazione all’empatia, sia possibile davvero incrementare tale capacità. Una maggiore empatia può arricchire sia se stessi che l’intera società. Ogni settore e aspetto della vita umana può trarne un miglioramento. Nell’ambito familiare una maggiore empatia si traduce nella possibilità dei genitori di aiutare i figli nel realizzare le proprie potenzialità. I politici potrebbero rappresentare le esigenze di tutti, le aziende potrebbero, investendo davvero sui propri dipendenti, ricavare più successo perché chi forma l’azienda, si sentirebbe davvero realizzato e compreso.
Entrare in contatto con l’empatia ci permetterebbe di riconoscere l’umanità condivisa, ci aiuterebbe a non lasciarci condizionare dai pregiudizi legati alla razza, all’etnia, alla cultura o qualsiasi cosa ci faccia credere che siamo diversi come esseri umani. In questo è necessario che i leader mondiali comprendano che siamo tutti connessi.
In questo è necessario che ci sia più spazio per l’empatia.