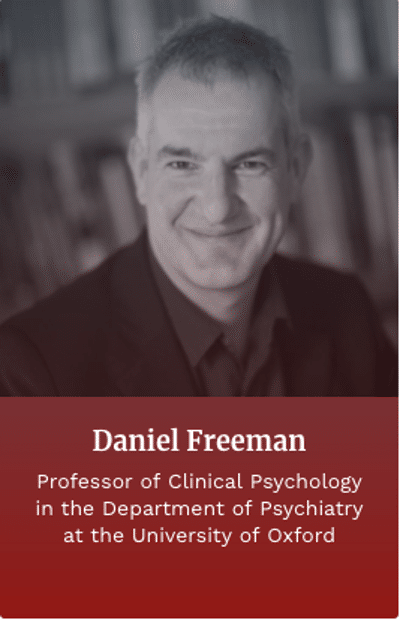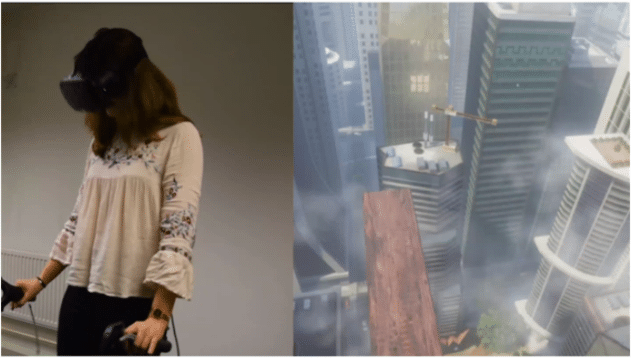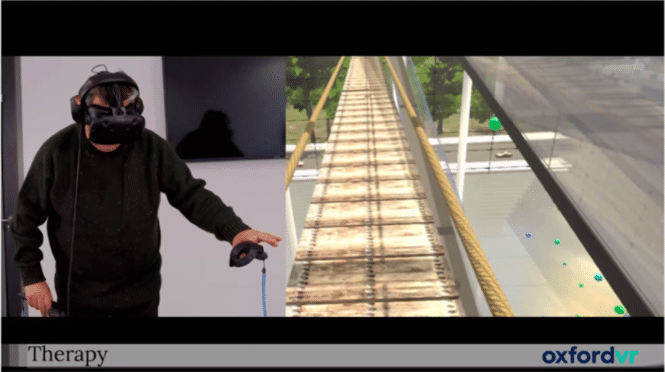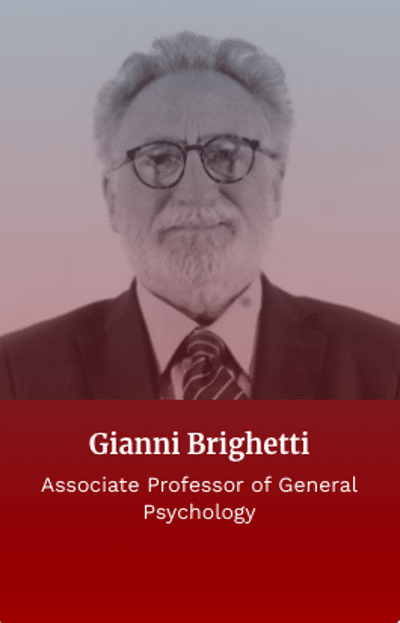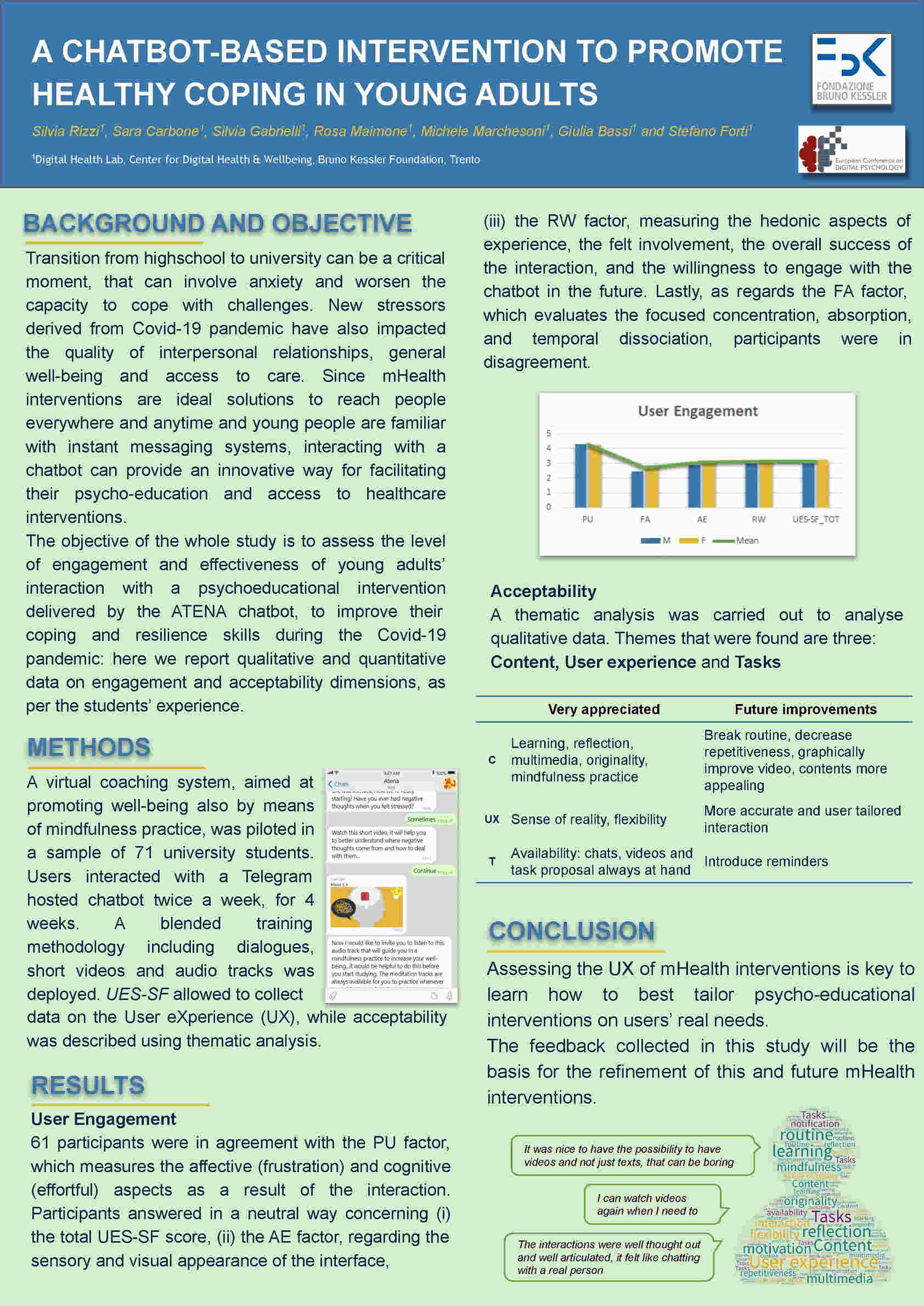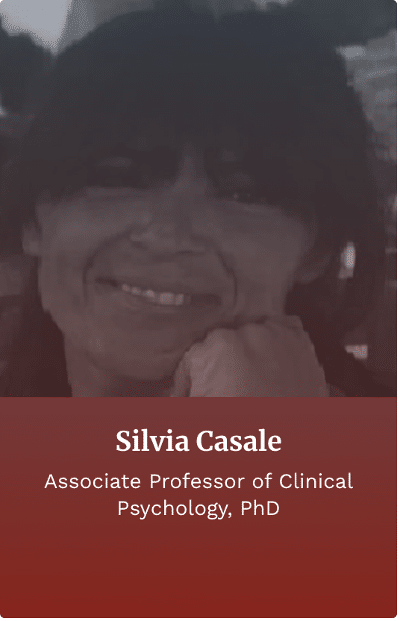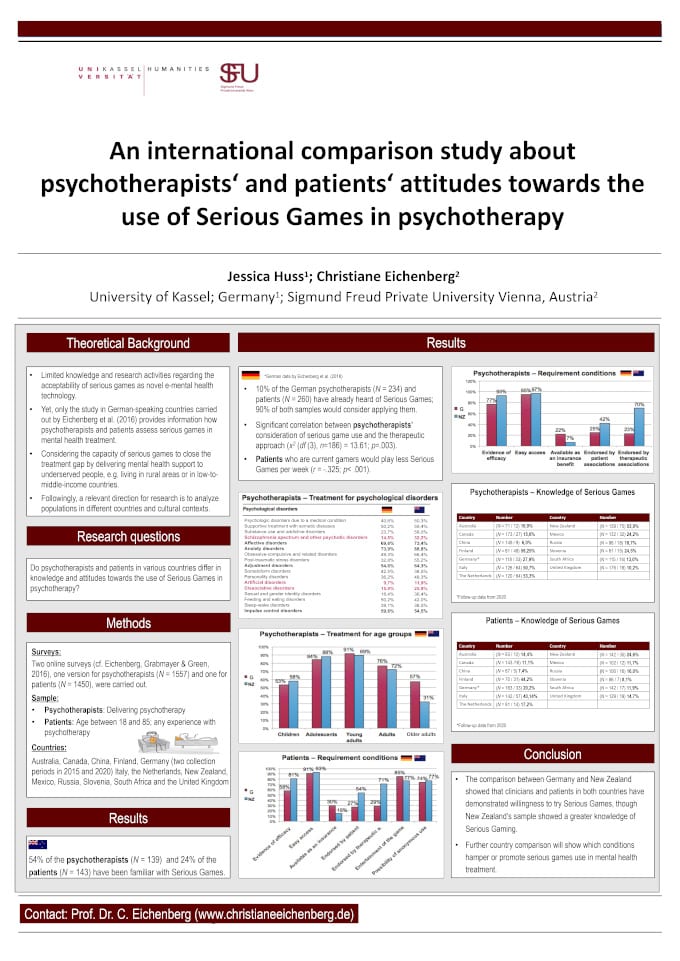Quantomeno un’ombra racconta di una luce – Recensione della serie SanPa
Dal punto di vista strettamente descrittivo il docufilm SanPa analizza il progetto di Muccioli attraverso una sequenza storica degli eventi che si sono susseguiti fino al 1995 e che hanno strutturato le convinzioni e le metodologie con cui accogliere persone con una dipendenza patologica a San Patrignano.
Quando il complesso tema della dipendenza patologica si presenta davanti agli occhi delle persone, sembra che arrivi un’iniezione di argomenti pronta a colmare una prolungata astinenza. Come spesso accade è un evento eclatante, una storia estrema, un abuso di potere o un desiderio di sentenze moralistiche a scatenare la discussione sulla dipendenza patologica. In questa occasione è stato un interessante documentario ad accendere i riflettori su quei luoghi che restano incastrati nel buio, su quelle persone che possono restare al buio per tutta la vita. L’esplosione del dibattito è stata simile a quella che si sente quando finalmente si scopre un segreto, quando si può svelare ciò che avevamo nascosto, quando qualcuno ci racconta il suo dolore e noi possiamo rispondere “anche io”.
Il documentario su San Patrignano va analizzato con particolare attenzione al periodo storico e culturale in cui Vincenzo Muccioli costruiva la Comunità, non si può prescindere dalla conoscenza, le informazioni e le convinzioni sui “tossici” che prevalevano sia dal punto di vista clinico sia dal punto di vista dell’opinione pubblica. Non si può prescindere dal fatto che alcune di quelle convinzioni siano presenti ancora oggi e rendano la possibilità di avallare certi sistemi un’eventualità quasi peggiore dell’averli applicati.
Alla fine degli anni ’70 era ancora presente il costume del matrimonio riparatore, solo nel 1981 venne abolita legalmente la possibilità per uno stupratore di fruire del beneficio di legge offrendo il matrimonio alla donna. Solo nel 1996 lo stupro da reato “contro la morale” viene riconosciuto in Italia come “reato contro la persona”. Questo per dire che segregare (o ritenere questa pratica un mezzo di cura utile) un tossico viziato, disubbidiente e colpevole della sua malasorte, non era così difficile da far passare come un atto accettabile o addirittura salvifico. Questo per dire che togliere il problema dagli occhi della gente poteva sostituire il difficile tentativo di impegnarsi a curarlo.
Quando ho visto il documentario ho cercato di separare la mia riflessione. Da una parte mi sono soffermato sull’idea di costruire un luogo di accoglienza e comprensione per persone con una dipendenza patologica, luogo in cui ricostruire la propria vita, confrontandosi e relazionandosi come non avevano potuto fare prima. Dall’altra parte ho ritenuto importante analizzare il come questo tipo di proposta viene percepito da chi la offre e da chi ne usufruisce.
Senza dubbio, tossici emarginati e famiglie devastate dalla gravità della dipendenza hanno trovato un contesto in cui incontrarsi, un posto dove separarsi, proteggersi e avere l’opportunità di interrompere l’uso di sostanze a vantaggio dell’uso dei rapporti umani, delle parole. Quei “ragazzi” hanno trovato un posto in cui qualcuno poteva farli esprimere e quelle famiglie hanno potuto trovare qualcuno che non le lasciasse in balia di crisi d’astinenza incomprensibili e aggressive.
Ecco, se ci si fosse fermati a questo non avrei altro da dire.
Dal documentario emerge, come accade spesso ancora oggi, il tentativo, l’obiettivo di salvare i tossici. La prima frase all’inizio del docufilm recita così:
Con lo stato impotente, un uomo vuole salvare i tossicodipendenti…con ogni mezzo necessario…
Se usassimo il verbo salvare per qualsiasi altra patologia, la frase in questione non avrebbe alcun senso, se mettessimo diabetici, cardiopatici, depressi, schizofrenici, …al posto di tossicodipendenti non ci sarebbe una logica in quella affermazione. Ora, il fatto che alla fine degli anni ’70 si potesse avere questa impostazione mi sembra del tutto accettabile, mi sembra coerente con la percezione del tossico e con le conoscenze scientifiche che si possedevano in quegli anni. Oggi (in realtà da qualche anno), considerare questa impostazione non solo condivisibile ma solo opinabile, non può più essere ammesso, non si può ancora oggi ritenere discutibile un tipo di definizione metodologica come questa, non si può più tralasciare l’enorme cambiamento conoscitivo sulla dipendenza patologica, cambiamento che ci permette di acquisire competenze e metodi di intervento adeguati.
Affrontare la patologia di una persona con l’intento di salvare la persona e non di curare la patologia di cui la persona soffre, non può essere il punto di partenza con cui approcciarsi alla dipendenza patologica, non può rappresentare l’elemento decisivo per inquadrare una patologia così totalizzante che coinvolge l’intera esistenza di un essere umano. Una patologia che si diffonde dalle ataviche pulsioni dell’uomo, coinvolgendo la ribellione, la libertà, la società, la ricerca di un posto del mondo, la speranza di essere amati e il senso stesso della vita.
In molte discussioni che ho ascoltato e a cui ho partecipato in merito al documentario su San Patrignano, emergono temi contraddittori che confermano, almeno ai miei occhi, le distorte convinzioni sui tossicodipendenti e la scarsa percezione della complessità in cui si inserisce la dipendenza patologica. Come funzionano i tossici, perché si drogano, come aiutarli quando non vogliono essere aiutati, sono in grado di intendere e di volere, è giusto fermarli con ogni mezzo, si possono punire persone che esprimono i sintomi di una malattia, è una malattia, sono liberi di potersi drogare, sono dei criminali, le famiglie cosa possono fare, di chi è la colpa se si drogano… Una serie di temi che hanno bisogno di risposte complesse, individualizzate sul singolo caso, differenziate in base alla storia di ogni individuo e che invece, ancora oggi, si limitano a semplicistiche valutazioni personali, a opinioni senza fondamenti epistemologici. Temi che a volte raggiungono picchi filosofici su argomenti come la libertà individuale, il libero arbitrio, la scelta di come condurre la propria vita o di disporre della propria morte. Temi che (per riprendere le affermazioni di Fabio Cantelli) non possono essere affrontati con formule dicotomiche ma che vanno inquadrati in quella area dell’esistenza piena di sfumature oscure, priva di risposte definitive e riluttante alle risposte semplici.
Ancora oggi la percezione del tossico contiene una serie di convinzioni e pregiudizi che eludono una corretta comprensione del problema e possono anche minare la pianificazione di un intervento terapeutico funzionale. Anche tra gli addetti ai lavori siamo costretti a precisare delle convinzioni personali prima di descrivere la dipendenza patologica: cosa pensi del metadone, sei favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere, deve toccare il fondo per capire la sua situazione, è una malattia cronica e recidivante, come permettere alle persone di avere rapporti sessuali durante i percorsi terapeutici in Comunità, posso trattenerlo se decide di interrompere un percorso terapeutico in Comunità.
Posso pensare che in Comunità togliere le sigarette sia utile per far capire ad una persona che non deve drogarsi? Coltivare i campi è un modo per arginare il suo desiderio di sostanze?
E’ molto complesso rispondere a queste domande perché vanno a toccare più aspetti contemporaneamente. Ad esempio coltivare i campi non riduce il desiderio dell’eroina, ma favorisce la costruzione di nuove capacità che a quella attività sono correlate. La costanza nel mantenere un impegno, la forza di continuare a fare una cosa anche se non ti va, la pianificazione di una giornata in base a degli impegni e non in base allo sbattersi per una dose, confrontarsi con il senso del dovere e la responsabilità, imparare che la libertà all’interno di un contesto ha a che fare con il rispetto delle regole di quel contesto, che la convivenza richiede la condivisione e la difesa di valori comuni. Tutte cose che possono essere utili per vivere e non solo per non farsi. Barattare il ricordo dell’eroina e la sua istantanea capacità di alleviare il dolore, colmare la vergogna di essere nati e far rispettare le regole contando le sigarette ad un tossico, invece, non induce cambiamenti eclatanti.
Dal punto di vista strettamente descrittivo il docufilm SanPa analizza il progetto di Muccioli attraverso una sequenza storica degli eventi che si sono susseguiti fino al 1995 e che hanno strutturato le convinzioni e le metodologie con cui accogliere persone con una dipendenza patologica a San Patrignano. Sarebbe anacronistico a tal proposito esaminare le differenze nelle caratteristiche dei tossici degli anni ’80 e nelle tematiche esistenziali tipiche di quegli anni con le espressioni fluide e meticce con cui oggi si manifesta la dipendenza patologica. L’opportunità che invece offre l’impatto del docufilm sugli spettatori sta nel poter affrontare il tema della “droga” e soprattutto delle persone che ne fanno uso, confrontandosi sui metodi terapeutici e le definizioni cliniche che spesso si limitano ancora oggi a “terapie del secondo me”, strategie di sorveglianza, essere buoni o cattivi, seguire guru paternalistici.
Sarebbe bello, almeno per me, e forse anche utile per i tossici, poter condividere e discutere di interventi terapeutici coerenti con le loro esistenze, con i loro tentativi di sopravvivenza, con la loro paura di fidarsi, con il loro contraddittorio modo di prendersi cura di se stessi, con la loro incapacità di credere in qualcosa e, per questo, inclini a non credere più a niente. Avrebbe senso cominciare a riflettere sul fatto che una persona dipendente da sostanze, ma anche chi usa sostanze in modo compatibile con una vita sociale funzionale, è un ottimo specchio della società tutta, degli effetti che un certo tipo di concezione del mondo produce sulla vita di tutte le persone. Avrebbe senso discutere delle differenze che esistono tra le sostanze stupefacenti, che non tutte le persone che si sono fatte una canna si faranno una pera (strano ripetere ancora questa affermazione nel 2021), che non tutte le persone che usano una volta una sostanza diventano dipendenti da quella sostanza, che una storia di dipendenza patologica non si limita a superficiali sperimentazioni o esibizioni adolescenziali, che toccare il fondo ti fa venire voglia di cercare una pala.
Io lavoro in una Comunità Terapeutica e, con i nostri pazienti, abbiamo deciso di vedere il documentario insieme per confrontarci e favorire una discussione condivisa.
Forse la dipendenza patologica è l’unica patologia (cioè studio della sofferenza) che non viene spiegata a chi ne soffre. In genere, quando ci si ammala di qualcosa, abbiamo la possibilità di ricevere una precisa descrizione di ciò che abbiamo, di come funziona e si evolve il nostro disturbo, sia esso organico o psicopatologico. Per questo vedere insieme ai diretti portatori sani (cioè tossici che non stanno facendo uso di sostanze) il documentario, ci è sembrato un’opportunità ricca di “spunti” di vista e di confronti costruttivi.
In Comunità ci sono 25 pazienti, noi li chiamiamo pazienti e non “ragazzi” perché alcuni di loro hanno più di 30 anni e continuare a chiamare ragazzi persone che sono uomini ci sembra poco rispettoso. Inoltre, dato che siamo piuttosto petulanti sul significato delle parole, il termine paziente deriva dal latino patiens, il participio presente del verbo pati con cui si intende “sofferente” o “che sopporta”. In questo modo possiamo dare più valore alla sofferenza che c’è intorno ad una dipendenza patologica, alle devastanti conseguenze che si sopportano in quelle condizioni. Infine, ci permette di considerare la tossicodipendenza come una soluzione e non come il problema, una soluzione al dolore che produce ulteriori sofferenze da sopportare.
L’abuso di sostanze stupefacenti che induce ad una dipendenza patologica è un modo più o meno consapevole per risolvere un disagio interiore, “la droga” funziona come una soluzione ad un problema antecedente, ad una percezione di impotenza di fronte alla realtà, ad una solitudine inspiegabile o alla sostituzione di un piacere introvabile.
In pratica: il problema non è la droga in sé, ma la droga in te.
Anche per questo motivo i pazienti che hanno una dipendenza patologica non arrivano ad una consultazione o a richiedere aiuto perché il loro problema è drogarsi, ma perché drogarsi è l’unica soluzione che hanno per affrontare o sospendere temporaneamente il loro dolore. Per questo motivo il terapeuta diventa un’intromissione tra il disagio che il paziente avverte e la soluzione che ha a disposizione. L’alcolista sa che il suo malessere (problema) terminerà una volta che inizierà a bere (soluzione), quindi il terapeuta (oppure il genitore, la moglie, il marito, l’amico, il figlio, il lavoro… ) rappresenta un’intromissione tra il problema e la soluzione. Ecco perché vi sono occasioni in cui il paziente, governato dall’urgenza di stare meglio come chiunque avverta un disagio, contrasta il terapeuta (la terapia), contrasta chi gli impedisce di applicare la sua strategia risolutiva (bere, farsi…) per il suo malessere, contrasta chi si frappone tra lui e la soluzione veloce, certa ed efficace che conosce. Non è paradossale, quindi, che un paziente possa tagliare proprio le mani che tentano di curarlo.
I 25 pazienti ricoverati in Comunità corrispondono ad un minuscolo settore di San Patrignano, quindi il confronto non può essere fatto sul come funziona un luogo che ospita fino a 1500 persone, con un posto in cui ci sono poco più di 30 persone, operatori compresi. Si può, però, avviare una discussione sulla dipendenza patologica e le convinzioni che da essa scaturiscono integrando i punti vista degli addetti ai lavori con quelli dei portatori sani. Questo significa affrontare le contraddizioni, i paradossi e la complessità che caratterizzano i comportamenti e il linguaggio di tutte le persone coinvolte nella patologia, di tutte le aree coinvolte nel trattamento di una dipendenza patologica.
Tra i pazienti ricoverati in Comunità ci sono persone che hanno intrapreso altri percorsi terapeutici residenziali, alcuni di loro sono anche stati a San Patrignano per l’intero programma e un paio sono andati via da San Patrignano precocemente. Hanno fatto Comunità in epoche diverse e con metodi diversi, i pazienti cinquantenni hanno sperimentato vari approcci terapeutici dagli anni ’80 ad oggi, i più giovani sono arrivati in una Comunità per tossicodipendenti senza avere una storia di tossicodipendenza. Alcuni sono arrivati per la prima volta in Comunità a 40 anni e altri provano a considerare la loro dipendenza patologica un problema sanitario e non giudiziario, sperimentandosi in un ambiente diverso da quello detentivo.
Quasi ognuno di loro è riuscito a smettere di bere, inalare, fumare o iniettarsi qualsiasi polvere disponibile almeno una volta nella vita, ricorrendo ad un’infinità di soluzioni. Si sono chiusi in casa, hanno pregato, si sono fatti arrestare, hanno preso un cane, hanno lavorato, si sono sposati, hanno fatto un figlio, hanno divorziato, si sono trasferiti lontano, hanno fatto psicoterapia, hanno imparato a cucinare, scalato o aumentato il dosaggio del metadone. Sono riusciti a smettere in Comunità molto rigide e regolamentate o in Comunità aperte e flessibili, hanno capito di non doversi “drogare” perché gli venivano tolte le sigarette, hanno capito ugualmente perché gli veniva offerto un caffè, hanno deciso di smettere perché venivano lasciati soli con se stessi e anche perché qualcuno gli stava sempre vicino. Insomma smettere non è così difficile se puoi farlo in un sacco di modi e passando per strade così diverse.
Ancora una volta emerge che: il problema non è se lo fai, ma come riesci a pensare e sentire la tua vita se non lo fai.
Durante la discussione del docufilm con i pazienti, uno degli argomenti esposti ad una varietà di sfumature è stato quello relativo alla capacità di intendere e di volere in una persona che ha una dipendenza patologica.
Nel documentario si precisa che la persona con una dipendenza patologica sia in grado di intendere, ma non di volere, cioè non sarebbe in grado di “volere il proprio bene” e, per questo motivo, un’altra persona che lo ha in terapia dovrebbe decidere per lui, fino ad escludere la sua volontà con ogni mezzo disponibile. È un discorso complesso e, come tale, va affrontato cercando di restare in un ambito terapeutico e pragmatico, senza ricorrere a semplificazioni stucchevoli e, per quanto possibile, senza addentrarsi in speculazioni filosofiche sulla libertà individuale e sulla facoltà di autodeterminarsi.
Viene da chiedersi anzitutto, se questa capacità di intendere e non di volere sia da considerarsi alterata solo quando il paziente vuole andarsene dalla Comunità oppure se la si debba riconoscere anche quando decide, vuole, entrare in Comunità. Se la persona che vuole entrare in Comunità è ancora sotto l’effetto delle sostanze oppure, quando chiede aiuto per affrontare la sua sofferenza, ha la lucida capacità di capire e di decidere cosa vuole. Se l’esito della sua dipendenza patologica è l’arresto, la perdita della patria potestà oppure essere stato allontanato da casa, e queste conseguenze determinano la sua volontà di entrare in Comunità, possiamo dire che ha deciso di smettere di farsi? (secondo me si possono considerare comunque un buon punto di partenza). Se la crisi astinenziale, o esistenziale, sia una condizione stabile in una persona affetta da dipendenza patologica dal momento che, secondo un riduttivo punto di vista fisiologico, il cervello di un tossicomane è sempre in astinenza, non è che ci va ogni tanto. Qualcuno potrebbe dire che il craving o la crisi astinenziale siano i parametri con cui valutare l’incapacità di volere: poiché la persona in stato di crisi astinenziale vuole andare ad usare sostanze e poiché, in seguito ad un periodo di astinenza, l’uso presenterebbe evidenti rischi anche per la sua vita, non si può considerare la persona capace di controllo dei propri stimoli e impulsi ad agire.
È vero che un operatore di Comunità sa cosa può accadere ad un paziente ricoverato in Comunità quando non riesce più a continuare il suo percorso terapeutico e decide di andare via. Sappiamo che la dipendenza patologica è una condizione che mette a rischio la vita della persona e che, nella maggior parte dei casi, ad un’interruzione improvvisa del percorso terapeutico fa seguito il ricorso all’uso di sostanze e, quindi, alla possibilità di un’overdose fatale. Purtroppo è così anche quando la persona viene espulsa da una Comunità, quando si esprime con comportamenti inappropriati ad un luogo di cura, introduce sostanze stupefacenti, manifesta aggressività. Non possiamo però rendere la Comunità un luogo “salvavita”, un posto che serve ad evitare la morte al paziente, privandolo di ogni responsabilità personale e limitandoci, da soli, ad evitargli il peggio.
Viene allora da considerare quale rete di protezione ci sia per situazioni di questo tipo, quale risposta integrata possano mettere in pratica i Servizi Sanitari che si occupano di dipendenza patologica per far fronte a questi problemi. Sarebbe utile interrogarsi sui differenti presupposti teorici dei percorsi di cura che le Comunità applicano, basandosi su personali e, a volte, contrastanti punti di riferimento. Avere l’intento di raggiungere un linguaggio condiviso che, pur valorizzando le risorse individuali, si impegni a non produrre incomprensioni e fraintendimenti dettati da pregiudizi sia sul tossico sia sui colleghi.
Viene da chiedersi perché la dipendenza patologica sia l’unica a non avere un reparto sanitario dedicato 24h al giorno 7 giorni su 7, perché molti Sert siano chiusi il sabato e la domenica, perché un paziente può avere delle crisi astinenziali, o esistenziali, solo dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 14.00 più due pomeriggi a settimana. Insomma, se vogliamo arrivare una volta per tutte a definire la dipendenza una vera patologia che necessita di cure mediche, psicoterapeutiche e sociali e che, proprio in quanto patologia, non si manifesta a giorni e orari prestabiliti, allora sarà necessario rivalutare il significato che gli diamo dal punto di vista clinico. È una patologia con le sue caratteristiche, come tutte le altre del resto, che ha a che fare con una ferita dolorosa e sanguinante nell’anima di chi ne soffre e, come si sa, l’anima di ognuno di noi non si spezza solo nei giorni feriali.
Chi soffre di questa patologia ha bisogno di sentirsi compreso, sia nel senso di “essere capito da qualcuno” sia nel senso di “essere compreso all’interno di qualcosa”, ha bisogno di sentire di poter essere pensato anche quando fa di tutto per confermare la sua convinzione di meritarsi di essere dimenticato.