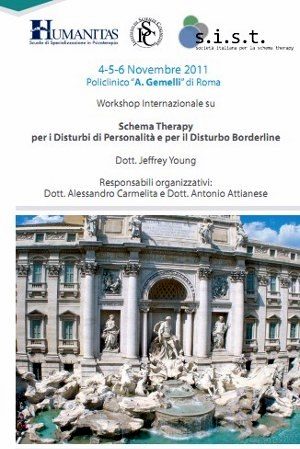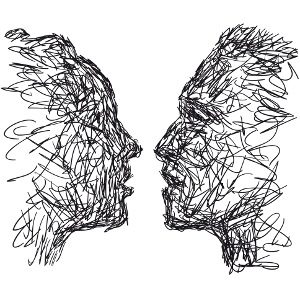Placebo ed effetto Placebo
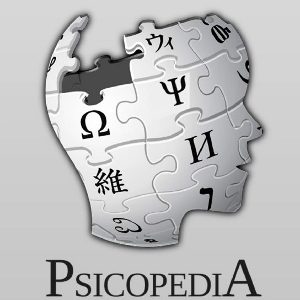 I termini “placebo” ed “effetto placebo”, sebbene da tempo siano entrati nel comune lessico professionale del medico, continuano ad indicare gli aspetti intriganti e misteriosi di ogni terapia, farmacologica o non farmacologica, essendo rispettivamente i fattori ed i processi incontrollati che confondono la dinamica della guarigione e ne mascherano la causa specifica.
I termini “placebo” ed “effetto placebo”, sebbene da tempo siano entrati nel comune lessico professionale del medico, continuano ad indicare gli aspetti intriganti e misteriosi di ogni terapia, farmacologica o non farmacologica, essendo rispettivamente i fattori ed i processi incontrollati che confondono la dinamica della guarigione e ne mascherano la causa specifica.
Nella cultura medica occidentale il placebo e l’effetto placebo non godono generalmente di buona fama, nonostante in passato la sola medicina veramente efficace per ogni malattia fosse il placebo.
Risale al 1811 la traduzione letterale “piacerò” dell’Hoopers Medical Dictionary che all’epoca definì il placebo come “Medicamento dato più per compiacere il paziente che per fornirgli beneficio”. Da allora i passi avanti sono stati molti, tanto che è ragionevole ipotizzare che il placebo rappresenti il medicinale maggiormente studiato e conosciuto per l’enorme mole di lavori, che nel corso dei decenni, l’hanno confrontato con le più svariate molecole, sulla base del metodo sperimentale basato sui controlli. Ma di che cosa si tratta?
È il confronto tra l’efficacia di un nuovo farmaco o un nuovo procedimento applicato su un gruppo di pazienti, rispetto a una sostanza neutra e innocua, il placebo appunto, somministrata a un altro gruppo altrettanto numeroso di pazienti. Sia i pazienti sia il medico sperimentatore devono, ovviamente, ignorare fino alla conclusione dell’esperimento, a quale gruppo saranno assegnati i diversi soggetti (metodo “doppio cieco”). La necessità di un gruppo di controllo è proprio legata all’esistenza dell’effetto placebo, in base al quale determinate malattie possono migliorare o guarire con la somministrazione di sostanze innocue e fasulle purché prescritte al paziente quali medicine.
Lancet (1994), ha identificato in un lavoro una serie di fattori che annullano o rinforzano l’effetto placebo, legittimandone così l’esistenza:
-
le iniezioni sono più efficaci delle compresse a parità di dosaggio e le compresse più grosse sono più efficaci di quelle piccole;
-
la fiducia del paziente nel medico aumenta l’effetto placebo, come pure gli attestati appesi alle pareti dello studio del medico;
-
l’effetto aumenta se si spiega al paziente il supposto meccanismo d’azione del farmaco;
-
l’effetto placebo è migliore nei pazienti ansiosi e in quelli dotati di scarsa capacità critica.
Il placebo, dunque, è definito nella letteratura scientifica come una sostanza priva di una attività farmacologica specifica, somministrata come controllo nei test clinici, oppure ad un particolare paziente per stimolarne potenziali benefici psicologici. La realtà dell’effetto placebo è accettata da gran parte della comunità scientifica. Nelle sperimentazioni cliniche, l’efficacia di una terapia è spesso valutata utilizzando, come controllo, elementi privi di princìpi attivi o procedure ritenute inefficaci, ed i progressi, nei soggetti non trattati, sono attribuiti proprio al placebo. Quindi, il placebo è rappresentato da una sostanza innocua o qualsiasi altra terapia o provvedimento non farmacologico (un consiglio, un conforto, un atto chirurgico) che, pur privo di efficacia terapeutica specifica, sia somministrato alla persona facendole credere che sia un trattamento necessario.
Per effetto placebo si intende una serie di reazioni che l’organismo mette in atto in risposta ad una terapia, ma corrispondono alle aspettative che l’individuo ha nei confronti della stessa. In altre parole, l’effetto placebo è una conseguenza del fatto che il paziente, specie se favorevolmente condizionato dai benefici di un trattamento precedente, si aspetta o crede che la terapia funzioni, indipendentemente dalla sua efficacia “specifica”. L’effetto placebo contribuisce all’efficacia di una terapia specificamente attiva: per discriminare tra queste due componenti si progettano gli studi clinici controllati contro placebo che quando possibili anche sotto il profilo etico sono considerati il gold standard della ricerca clinica. L’effetto placebo è fortemente influenzato da una serie di variabili soggettive quali la personalità e l’atteggiamento del medico (iatroplacebogenesi) nonché le aspettative del paziente.
Nella sperimentazione clinica, un nuovo farmaco si giudica efficace solo se dà risultati significativamente diversi da un placebo. La sperimentazione circa l’effetto placebo avviene in doppio cieco, dove né chi compie il test – medico – né il paziente sono al corrente di quale sia il farmaco e quale il placebo. Il meccanismo alla base dell’effetto placebo è psicosomatico nel senso che il sistema nervoso, in risposta al significato pieno di attese dato alla terapia placebica prescrittagli, induce modificazioni neurovegetative e produce una serie numerosa di endorfine, ormoni, mediatori, capaci di modificare la sua percezione del dolore, i suoi equilibri ormonali, la sua risposta cardiovascolare e la sua reazione immunitaria. In una certa misura possono confondersi con l’effetto placebo anche la guarigione spontanea di un sintomo o di una malattia, così come pure il fenomeno della regressione verso la media. In altre parole il paziente si rivolge al medico “quando proprio non ne può più” e poi i suoi disturbi rientrerebbero comunque nella media. Questo ritorno ai livelli normali del disturbo può essere scambiato per effetto placebo. I risultati dell’effetto Placebo potrebbero essere coadiuvati da un numero di variabili intervenienti, tra cui:
-
fattori biologici (ad es. le endorfine che medierebbero l’effetto antalgico placebo)
In definitiva, il placebo, può essere inteso come un insieme di fattori extrafarmacologici capaci di indurre modificazioni dei processi, anche biologici, di guarigione intervenendo a livello del sistema psichico: non per nulla molti autori considerano quasi sinonimi i termini placebo e suggestione.
Effetto nocebo
E’ necessario fare un distinguo, nel momento in cui un atto terapeutico provoca un effetto negativo su di un sintomo o una malattia indipendentemente dalla sua specifica efficacia viene chiamato nocebo (il futuro del verbo latino nocere, letteralmente “nuocerò”). Può essere spesso ricondotto ad un atteggiamento ansiogeno da parte del medico o, più in generale, ad un rapporto medico-paziente impostato in modo non corretto. D’altra parte è necessario considerare la componente “nocebo” in una terapia farmacologicamente attiva e validamente testata, qualora ci si trovi in presenza di effetto psicosomatico negativo dovuto a scarsa fiducia nel farmaco o nel medico curante.



 Un gruppo di ricercatori della
Un gruppo di ricercatori della 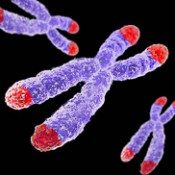
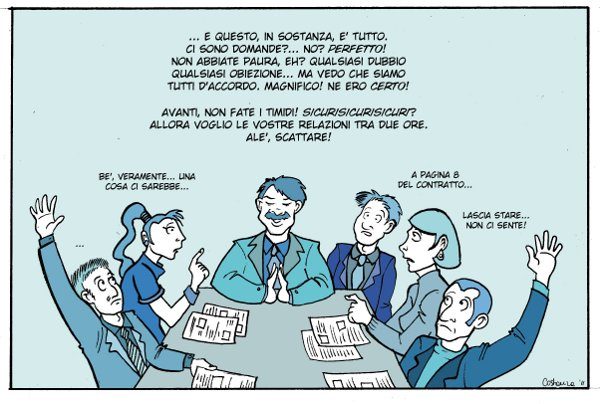 Le notizie di questi giorni sulla situazione europea mi hanno fatto riflettere sulle caratteristiche psico(pato?)logiche dei leader mondiali e sulle qualità che un leader autorevole (forma di leadership che la psicologia sociale ritiene più adatta e funzionale) dovrebbe avere e su chi si arroga l’arduo compito di riconoscere nell’altro tali qualità.
Le notizie di questi giorni sulla situazione europea mi hanno fatto riflettere sulle caratteristiche psico(pato?)logiche dei leader mondiali e sulle qualità che un leader autorevole (forma di leadership che la psicologia sociale ritiene più adatta e funzionale) dovrebbe avere e su chi si arroga l’arduo compito di riconoscere nell’altro tali qualità.
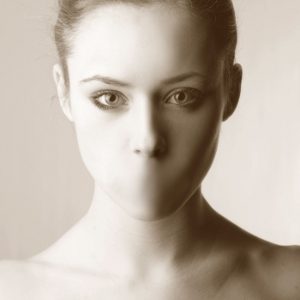 Il 19 novembre all’Università Cattolica di Milano si è tenuta la prima conferenza della
Il 19 novembre all’Università Cattolica di Milano si è tenuta la prima conferenza della  Nel regno Unito ci sono 332.600 persone in età lavorativa affette da un disturbo dello spettro autistico (DSA) e solo il 6% di loro ha un lavoro a tempo pieno; in Germania sono 164.849; in Bulgaria 15.035. E in Italia? Nel nostro paese non è semplice raccogliere dati precisi sui disturbi dello spettro in età adulta ma sicuramente si può arrivare ad affermare che ci sono più di 116 mila persone affette da DSA in età evolutiva. In tutta l’Unione Europea il tasso di disoccupazione delle persone affette da DSA è stimato essere superiore al 90%!
Nel regno Unito ci sono 332.600 persone in età lavorativa affette da un disturbo dello spettro autistico (DSA) e solo il 6% di loro ha un lavoro a tempo pieno; in Germania sono 164.849; in Bulgaria 15.035. E in Italia? Nel nostro paese non è semplice raccogliere dati precisi sui disturbi dello spettro in età adulta ma sicuramente si può arrivare ad affermare che ci sono più di 116 mila persone affette da DSA in età evolutiva. In tutta l’Unione Europea il tasso di disoccupazione delle persone affette da DSA è stimato essere superiore al 90%!
 L’incidenza di disturbi di tipo autistico tra i bambini italiani si aggira intorno ai 2-6 individui su mille. Le nuove e primissime linee guida nazionali, varate il mese scorso dal Ministero della Salute, rispondono finalmente all’esigenza espressa da molti familiari di questi bambini di essere aiutati nella scelta del trattamento più idoneo per i propri figli. E infatti ogni metodo, ogni percorso psico-educativo e ogni intervento farmacologico, sono stati analizzati con criticità per discriminare tra tutte le proposte ciò che si è dimostrato essere scientificamente valido da ciò che invece ha costituito, fino a prova contraria, una moda del momento.
L’incidenza di disturbi di tipo autistico tra i bambini italiani si aggira intorno ai 2-6 individui su mille. Le nuove e primissime linee guida nazionali, varate il mese scorso dal Ministero della Salute, rispondono finalmente all’esigenza espressa da molti familiari di questi bambini di essere aiutati nella scelta del trattamento più idoneo per i propri figli. E infatti ogni metodo, ogni percorso psico-educativo e ogni intervento farmacologico, sono stati analizzati con criticità per discriminare tra tutte le proposte ciò che si è dimostrato essere scientificamente valido da ciò che invece ha costituito, fino a prova contraria, una moda del momento.



 Non sempre ci rendiamo conto delle modalità e delle istanze che intervengono nel momento in cui dobbiamo prendere delle decisioni e valutare approssimativamente qualcosa di cui non abbiamo certezza. Sulla scia degli attuali trends scientifici inneggianti alla cosiddetta
Non sempre ci rendiamo conto delle modalità e delle istanze che intervengono nel momento in cui dobbiamo prendere delle decisioni e valutare approssimativamente qualcosa di cui non abbiamo certezza. Sulla scia degli attuali trends scientifici inneggianti alla cosiddetta 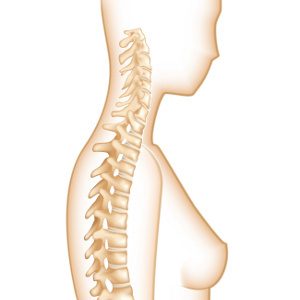
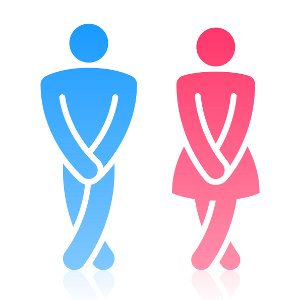
 Chi soffre di depressione ha la tendenza a pensare in modo astratto e a generalizzare pensieri negativi, questo rende la riflessione penosa, oltre che estremamente inefficace dal punto di vista del problem solving. Secondo un nuovo studio inglese condotto dal professor Edward Watkins è possibile, nell’arco di soli due mesi ridurre significativamnente la depressione con la
Chi soffre di depressione ha la tendenza a pensare in modo astratto e a generalizzare pensieri negativi, questo rende la riflessione penosa, oltre che estremamente inefficace dal punto di vista del problem solving. Secondo un nuovo studio inglese condotto dal professor Edward Watkins è possibile, nell’arco di soli due mesi ridurre significativamnente la depressione con la
 I comportamenti aggressivi dei bambini in età scolare, soprattutto nelle società occidentali, costituiscono un problema a più livelli, sia per la problematicità del comportamento stesso e della sua gestione, sia a lungo termine, per il fatto che i bambini “aggressivi” presentano più frequentemente difficoltà relative al rendimento scolastico (Rubin et al., 1998) e alle competenze sociali, con conseguenze che si ripercuotono negli anni, come lo sviluppo di comportamenti criminali, l’abuso di sostanze e comportamenti che mettono a rischio la propria salute e incolumità fisica.
I comportamenti aggressivi dei bambini in età scolare, soprattutto nelle società occidentali, costituiscono un problema a più livelli, sia per la problematicità del comportamento stesso e della sua gestione, sia a lungo termine, per il fatto che i bambini “aggressivi” presentano più frequentemente difficoltà relative al rendimento scolastico (Rubin et al., 1998) e alle competenze sociali, con conseguenze che si ripercuotono negli anni, come lo sviluppo di comportamenti criminali, l’abuso di sostanze e comportamenti che mettono a rischio la propria salute e incolumità fisica.