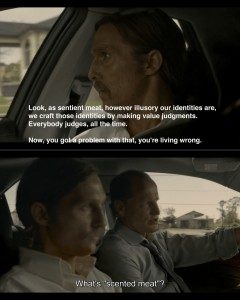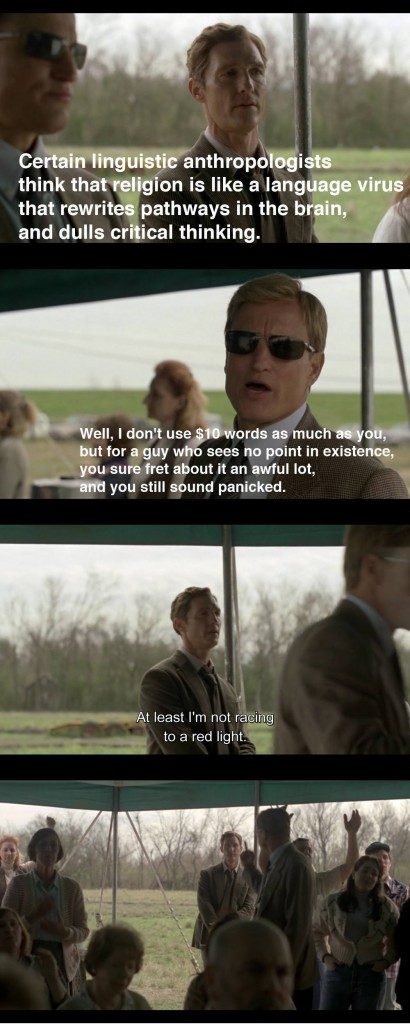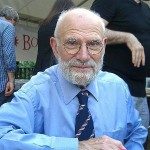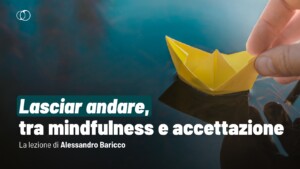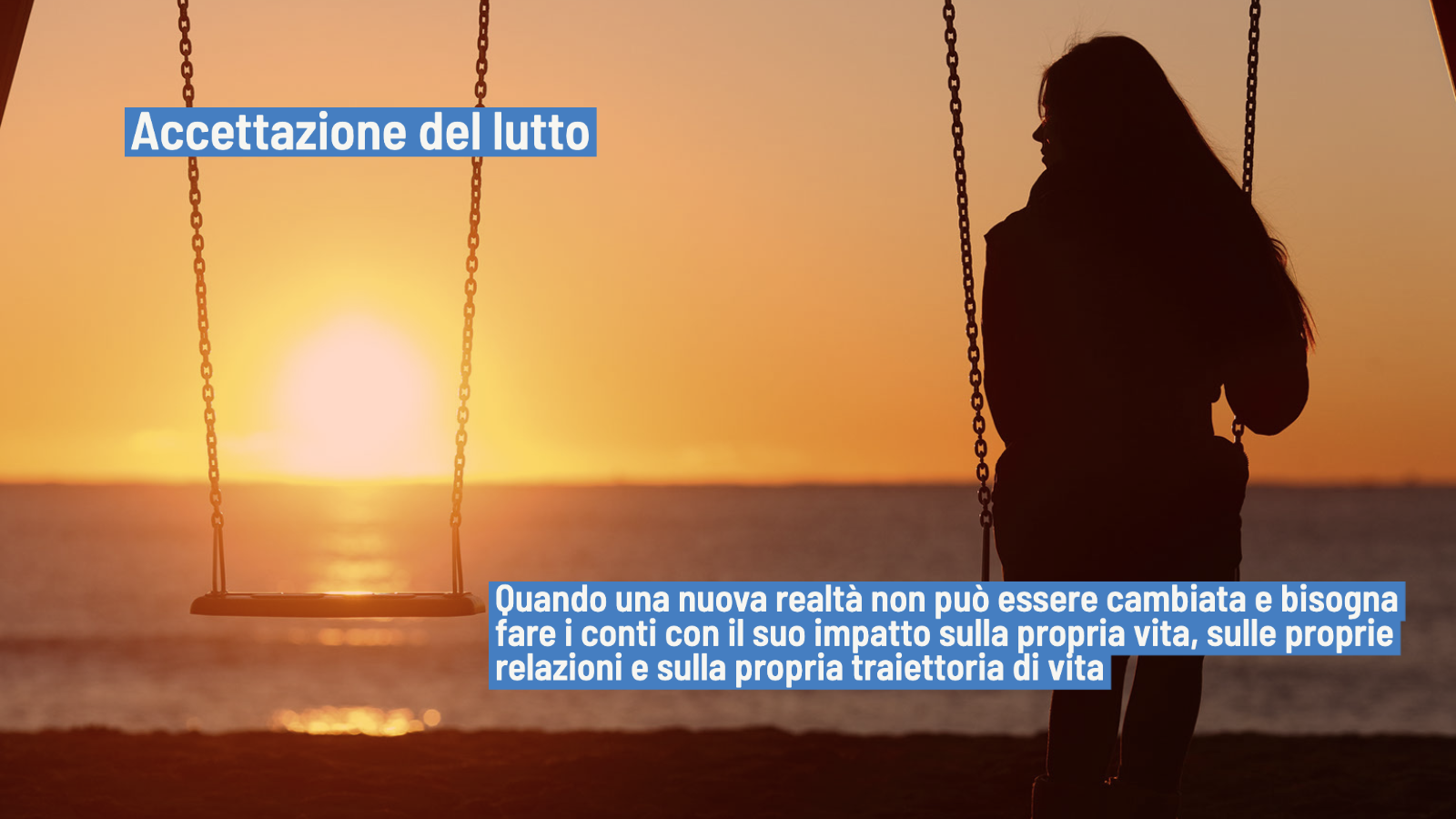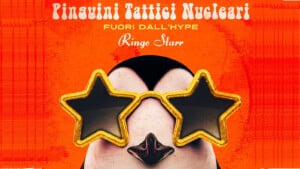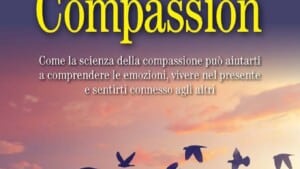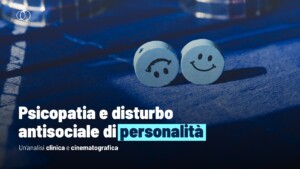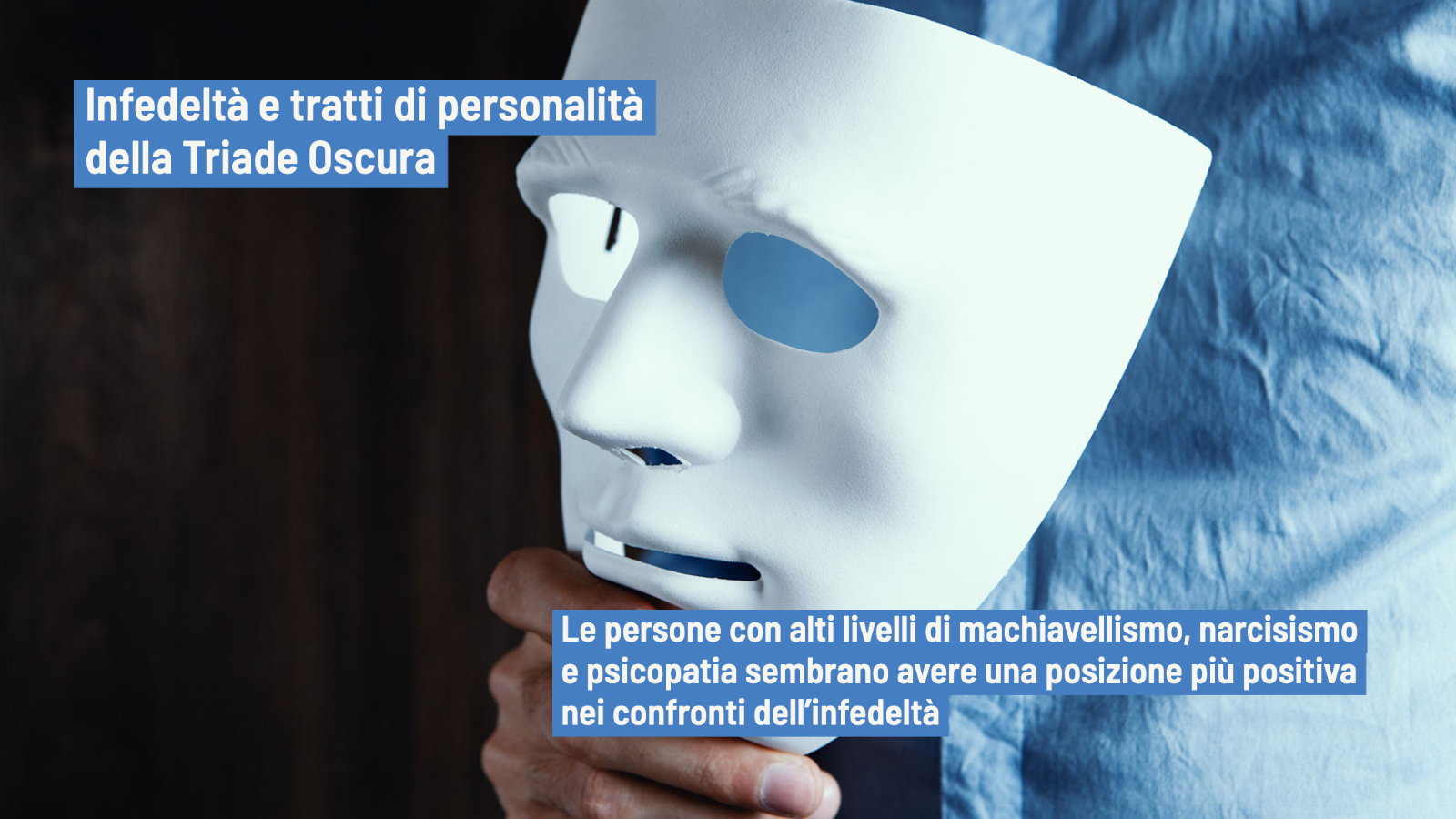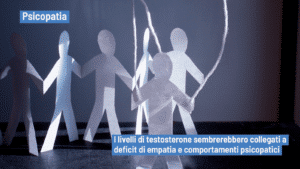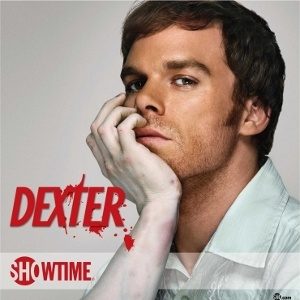Arti marziali & benessere psicologico – I Parte
Sul tatami, con i suoi fratelli di allenamento, vive per la prima volta nella sua vita un senso di appartenenza che trova la sua profonda radice nella corporeità. Condividere la fatica, il sacrificio, il divertimento governato da regole. Apprendere attraverso il proprio corpo, e attraverso il corpo dell’altro.
Alfredo (chiamiamolo così) ha diciannove anni. Dice di avere un corpo di legno. Gli sembra che i segmenti del suo corpo non riescano a evitare di litigare tra loro quando si tratta di intraprendere qualsiasi azione. Le gambe, per esempio, sempre a polemizzare con le braccia invece di collaborare con loro per creare un movimento coordinato. Che so, per camminare. Correre, poi, non se ne parla. Fare sport, un desiderio congelato, che ha smesso di nutrire da quando aveva otto anni. Che strano, però, a guardarlo da fuori Alfredo non sembra affatto il burattino di legno che descrive. Magro, è magro, ma di una magrezza vitale. Segaligna, ma in qualche modo pulsante, muscolare, bisognosa di esprimersi.
Me lo dice dopo i primi dieci minuti della prima seduta: ha letto da qualche parte sul web che insegno arti marziali. Di arti marziali, mi dice, non c’ha capito mai molto, ma – non sa perchè – quell’insolito connubio tra Freud e Bruce Lee lo ha incuriosito. Forse è il motivo principale per cui ha scelto me. Forse per i terapeuti vale la stessa cosa che si dice dei libri. Che non li scegliamo noi, ma sono loro a sceglierci.
Gli dico che fare arti marziali è il modo principale attraverso cui mi prendo cura di me stesso. Sembra colpito. Abbassa lo sguardo e mi dice che anche lui ha bisogno di un modo per prendersi cura di sè. Non è mai riuscito a farlo, dice.
La terapia prenderà forma plasmandosi ogni volta, ad ogni seduta, sull’immediatezza. Aiutarlo a fare un po’ salotto insieme va bene per sciogliere momentaneamente l’esoscheletro stratificato attorno alla sua esistenza. Potrà anche essere di legno ogni volta che entra nel mio studio, ma quando esce voglio che senta di essere fatto di carne viva. Almeno per un po’.
Capiremo insieme che da quando ha ricordo di sè, ha ricordo di una rigidità anche più interna rispetto a quella corporea. Momenti, sempre più frequenti fino a diventare un tono di fondo, in cui l’attenzione rivolta su di sè diventava opprimente. Osservarsi e vedersi vulnerabile, inadeguato, estraneo agli altri.
Comprendiamo cause, svisceriamo copioni interni, attribuiamo colpe a genitori che poi, insieme, perdoniamo. (Ovviamente, senza usare la parola colpa; in fondo la psicoterapia, tra le altre cose, è anche un po’ questo: dare colpe senza mai darne l’impressione). Confezioniamo cornici di significato che levighiamo con cura. Un giorno, Alfredo ha anche un’intuizione importante. Tutte le volte, numerose, che ha invidiato la forza fisica e la padronanza del corpo che mi ha attribuito nella sua immaginazione, forse ha esagerato. (Si sente fuori campo la voce dei miei menischi rotti che gli danno ragione). Capiamo che forse era solo un altro modo in cui si manifestava la sua percezione di sè come uno che nella vita passerà sempre inosservato.
Passa un anno. Alfredo si innamora. Questo gli era già successo molte volte. La novità è che stavolta la ragazza in questione ne viene informata. La terapia volge lentamente al termine. Ci interroghiamo però su perché, nonostante la strada fatta, ogni volta che una situazione, anche la più innocua, gli elicita quel senso di vulnerabilità ontologica, il corpo ritorni ad essere di legno. Una partita a bowling con la fidanzata e gli amici di lei. Ora sa osservare meglio sul nascere pensieri come “sono tutti migliori di me…più belli, più intelligenti, più spigliati…lei avrebbe potuto scegliere uno di loro, e probabilmente lo farà”. Sa anche metterlo in discussione. “Col dottore abbiamo visto tante volte quanto questo dipenda dal mio schema basato sul rifiuto subito”. Ma questo non basta ad arrestare quella trasformazione della carne in legno. Ad assistere alla perdita dell’immediatezza nello scambio che il corpo stabilisce con lo spazio. Infatti, nella partita a bowling non azzecca manco un tiro. La palla calamitata ogni volta dal canaletto a margine della pista. Quello messo lì apposta perché gli imbranati non facciano danni. Fa perdere la sua squadra tre volte di seguito. Attorno a sè, solo persone sorridenti, che vorrebbero scherzarci su, ma rimangono disarmate dal suo sguardo che diventa sempre più spento. La sua fidanzata vorrebbe abbracciarlo, ma sta imparando che in questi momenti è meglio lasciarlo stare. Ci sarà tempo dopo, quando saranno soli, per rassicurarlo. E a quel punto lui saprà leggere solo la fatica a cui, cronicamente, la costringe. “Sicuramente si stancherà di me”.
Secondo me tra un terapeuta e un maestro di arti marziali non c’è molta differenza, sempre che uno faccia il terapeuta e il maestro di arti marziali in un certo modo. Così mi confeziono la giustificazione della violazione del setting e del confine terapeutico che sto per commettere. Gli dico che la prossima seduta sarà in palestra. Una lezione privata con me e poi, se la roba che gli mostrerò gli piace, valuteremo la possibilità di inserirlo nella collettiva. Non sembra molto sorpreso. Come se si fosse sempre aspettato da me un’uscita del genere. L’occulta simmetria della relazione terapeutica. Tu conosci il paziente e non ti rendi conto che lui finisce per conoscere te.
Fatto sta che accetta, senza farmi molte domande. Solo, vuole sapere che tipo di arte marziale. Gli spiego che pratico due discipline complementari. Tai chi chuan e il jiu jitsu brasiliano. La differenza tra loro è che il secondo è esterno, il primo interno. Esterno vuol dire che studia come produrre ed emettere forza attraverso l’uso, sempre più economico, dei muscoli; interno vuol dire che persegue il medesimo obiettivo attraverso l’uso della respirazione.
Dopo tanti anni di pratica, però, questa distinzione perde senso. L’esterno diventa interno e viceversa. Un’altra differenza importante è che il tai chi chuan studia il combattimento in piedi, mentre il jiu jitsu brasiliano enfatizza il combattimento a terra. Portare l’avversario al suolo, per poi neutralizzarlo e indurlo a desistere dal combattimento, senza l’utilizzo di colpi. Gli dico che secondo me per lui è meglio il jiu jitsu.
Come introduzione teorica è un po’ essenziale. Come terapeuta sono logorroico, come insegnante di arti marziali l’esatto contrario. Comunque gli basta.
Ovviamente, quando sale sul tatami si sente di legno. Quando gli spiego le tecniche, gli parte un riflesso verbale. “Non ci posso riuscire”. Tanto che a un certo punto gli dico, ma con tono calmo – il che rende piuttosto efficace l’intervento terapeutico – che non deve rompere co’ sta storia, perchè è evidente che le cose le sta riuscendo a fare. Ride.
Poi lottiamo. Nel jiu jitsu brasiliano si lotta già nella prima lezione. Il messaggio che sta dietro questo è che la lotta a terra è una routine ancestrale che condividiamo con molte specie animali, ma che poi perdiamo. I neonati, e i bambini fino a circa quattro anni, compiono spontaneamente molti movimenti tecnici del jiu jitsu brasiliano. Non occorre molto tempo per recuperare questo retaggio motorio evoluzionisticamente fondato, basato sul gioco della lotta a terra come mezzo sicuro, tra fratelli, per acquisire destrezza nel combattimento ed aumentare le possibilità di sopravvivenza.
Un noto maestro disse:
[blockquote style=”1″]”Prendete due persone, insegnategli una tecnica di jiu jitsu ciascuno; poi metteteli su un’isola deserta con la consegna di lottare ogni giorno cercando di utilizzare quell’unica tecnica; tornate dopo tre mesi; troverete due lottatori di jiu jitsu”[/blockquote]
Mentre lotta, Alfredo sembra attraversare diversi stati emotivi. Si arrabbia, perchè ha quasi un quarto di secolo meno di me e ad avere il fiatone è lui (questo è inevitabile quando si lotta con un compagno di allenamento più esperto); gli viene da ridere quando lo faccio volare per poi riachiapparlo in aria e annullare l’impatto col tatami; si sente vulnerabile quando lo immobilizzo per qualche secondo per spiegargli che quello è l’obiettivo quando si lotta.
Sembra anche intuire che io non sto semplicemente insegnandogli, ma mi sto allenando con lui. E mi sto divertendo con lui. Che è molto molto diverso dal divertirsi alle sue spalle. Quella vitalità, che avevo intuito in lui già al nostro primo incontro, trova un canale espressivo. Lui sembra esserne spettatore stupito. Al termine della lotta è stremato.
Si iscrive al corso collettivo. La sua psicoterapia finisce, inizia la pratica marziale. Dopo tre mesi, è un lottatore di jiu jitsu. E si è dimenticato di essere di legno.
Sul tatami, con i suoi fratelli di allenamento, vive per la prima volta nella sua vita un senso di appartenenza che trova la sua profonda radice nella corporeità. Condividere la fatica, il sacrificio, il divertimento governato da regole. Apprendere attraverso il proprio corpo, e attraverso il corpo dell’altro.
Quel senso di appartenenza, è riuscito ad esportarlo anche fuori. Ora, in mezzo agli altri, la memoria somatica del suo corpo, forte, flessibile, fluido, rigido solo nei momenti giusti, immerso in quella via di mezzo tra gioco e combattimento, plasma una diversa percezione di sè. Si può essere vulnerabili, come quando si subisce un’immobilizzazione da un avversario più esperto, ma questo non significa soccombere. Non significa mai essere umiliati. E’ una posizione dell’animo che si può abitare, continuando a lottare-giocare con un altro che tante altre volte, anche lui, ha sperimentato quella stessa vulnerabilità. Chi lotta, nel jiu jitsu, lo fa sempre sentendosi vulnerabile.
Alfredo non rappresenta un caso eccezionale, secondo me. In fondo, uno schema sè/altro ha origine da esperienze radicate nella corporeità. Da stati emotivi somaticamente marcati vissuti in esperienze interpersonali prototipiche. Plausibile che uno schema si possa anche modificare funzionalmente attraverso un approccio sofisticato basato sulla corporeità. Insegnando al corpo a ripensare la mente.
Nella seconda parte approfondirò le basi empiriche su cui si basa questa ipotesi, descrivendo nel dettaglio i processi psicofisiologici che si attivano in alcune pratiche marziali.
CONTINUA DOMANI CON LA SECONDA PARTE
ARGOMENTO CORRELATO:
PSICOLOGIA DELLO SPORT
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Gennaro Gattuso: il calcio e il problema secondario – Psicoterapia