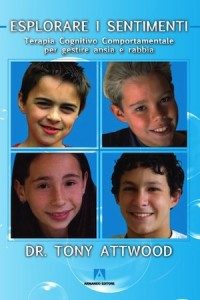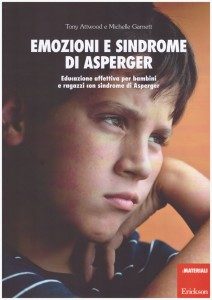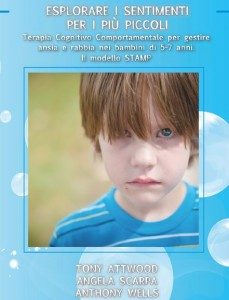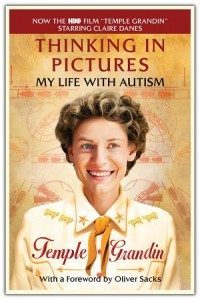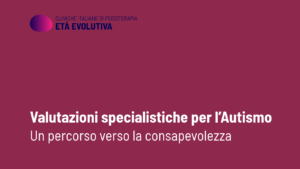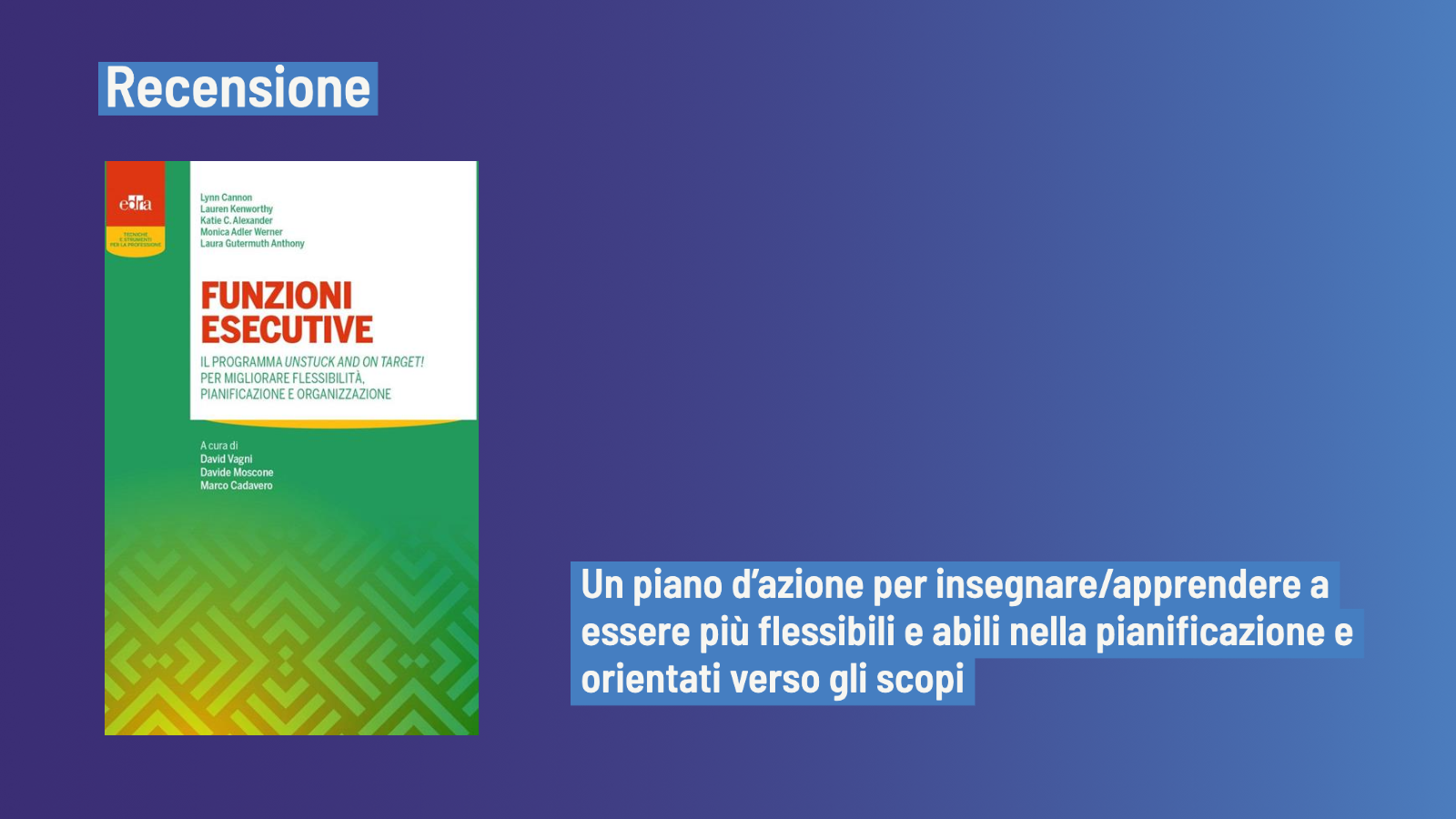La fantasia dei bambini: la capacità dei più piccoli di discriminare eventi reali e immaginari e relative implicazioni a livello clinico
I bambini si trovano quotidianamente costretti a distinguere la realtà dalla fantasia e devono comprendere che ciò che leggono nei libri o vedono in televisione potrebbe non riflettere la realtà, la ricerca ha preso in esame vari aspetti della fantasia dei bambini e della loro capacità di discriminare situazioni immaginarie da quelle reali.
Marika Di Egidio – OPEN SCHOOL Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto
I bambini si trovano quotidianamente costretti a distinguere la realtà dalla fantasia. Devono comprendere che ciò che leggono nei libri o vedono in televisione potrebbe non riflettere la realtà, che gli eventi di un gioco di finzione sono esclusivo frutto della fantasia e che le conversazioni di ogni giorno possono contenere informazioni reali o false.
La ricerca ha preso in esame vari aspetti della capacità dei bambini di discriminare le informazioni fantastiche da quelle reali, in particolare la distinzione tra entità reali o fiabesche (Skolnick & Bloom, 2006, 2009; Tullos & Wooley, 2009; Wooley & Cox, 2007), il credere in amici immaginari (Taylor, Shawber, & Mannering, 2009), la comprensione del concetto di magia (Browne & Wooley, 2004; Subbotsky & Slater, 2011), la capacità di differenziare eventi improbabili e impossibili (Cook & Sobel, 2011) evidenziando un incremento di tale abilità all’aumentare dell’età. In genere, la fantasia dei bambini in età prescolare è più vivida e fanno più fatica a discriminare con precisione e immediatezza la realtà dalla fantasia.
Nonostante le difficoltà dovute all’età, anche i bambini più piccoli sembrano comunque in grado di identificare a grandi linee il confine tra realtà ed eventi fantastici. Questo è vero soprattutto per informazioni che non hanno particolare valenza emotiva.
Fantasia dei bambini ed emozioni
Vari studi hanno infatti messo in luce come la competenza dei bambini nel discriminare la realtà dalla fantasia si riduca in presenza di informazioni capaci di evocare emozioni. Ad esempio, se a bambini dai 4 ai 7 anni viene chiesto di immaginare personaggi buoni o cattivi (es. pupazzi, mostri) all’interno di scatole vuote, essi preferiscono immaginare scatole contenenti entità positive piuttosto che negative. Questo dato suggerisce che la reazione emotiva dei bambini di fronte alla richiesta di immaginare personaggi buoni o cattivi favorisce la confusione tra realtà e fantasia dei bambini, rafforzando nei bimbi l’erronea convinzione che le entità immaginate possano essere reali (Harris, Brown, Marriot, Whittal, & Harmer, 1991).
Altre ricerche hanno evidenziato che bambini di età compresa tra 3 e 5 anni a cui è stato chiesto di discriminare tra eventi reali spaventosi ed eventi fantastici neutri sono stati in grado di riconoscere gli eventi fantastici come non reali (Sayfan & Lagattuta, 2009) ma sono stati inaccurati nella valutazione degli eventi reali spaventosi, categorizzati come non veri (Samuels & Taylor, 1994). Questi risultati suggeriscono che la paura contribuisce a ridurre la capacità del bambino di discriminare la realtà dalla fantasia.
Samuel e Taylor (1994) hanno presentato a bambini di 3-5 anni immagini spaventose ed immagini neutre, entrambe le immagini potevano riguardare eventi reali o immaginari. Ai soggetti è stato chiesto di valutare se tali immagini rappresentavano eventi che sarebbero potuti accadere nella vita reale. E’ interessante notare che i bambini erano accurati nella valutazione delle immagini neutre (reali e fantastiche), ma erano inclini a commettere errori nella valutazione delle immagini spaventose ritenendo che il verificarsi di eventi reali fonte di ansia e paura fosse piuttosto improbabile.
Inoltre, i bambini che si erano maggiormente spaventati alla presentazione delle immagini spaventose tendevano a dare giudizi più inaccurati rispetto ai compagni che avevano provato meno paura.
Nel complesso, questi studi sulla fantasia dei bambini rivelano come le emozioni influenzino le valutazioni dei bambini influenzando la loro capacità di distinguere informazioni reali da elementi fantastici.
Sono state proposte diverse spiegazioni per questi dati. Una possibile spiegazione prende in considerazione l’ipotesi che le risposte dei bambini riflettano il tentativo di regolare l’arousal emotivo e ridurre l’intensità delle emozioni negative. Negando il possibile verificarsi di eventi negativi il bambino si sgancia psicologicamente da tali avvenimenti, riducendo così l’ansia che essi provocano in lui.
Un’ulteriore spiegazione valuta la possibilità che le risposte dei bambini rappresentino l’espressione del loro desiderio che si verifichino esclusivamente eventi positivi.
Una terza ipotesi prende in considerazione l’eventualità che le valutazioni dei bambini riflettano la loro esperienza, le loro conoscenze e le loro aspettative. Considerato che generalmente i bambini non fanno esperienza di eventi negativi, potrebbero non possedere conoscenze e aspettative relative a questi eventi e pertanto ritenere più bassa la probabilità che tali eventi possano verificarsi.
Come l’ambiente influenza la fantasia dei bambini
Infine, la distinzione tra realtà e fantasia dei bambini potrebbe essere influenzata da fattori ambientali, quali tradizioni culturali e incoraggiamento da parte degli adulti. I genitori tipicamente proteggono i loro bambini dalle esperienze negative e potrebbero attivamente dissuaderli dal credere in entità negative, in modo da evitare che i propri figli provino ansia o altre emozioni negative. Al contrario, i genitori tendono a promuovere il fatto che i bambini credano all’esistenza di personaggi buoni, quali Babbo Natale o la Fatina dei denti.
E’ stato messo in luce che l’incoraggiamento da parte dei genitori a credere in entità fantastiche positive incrementa le credenze dei bambini circa queste entità. È quindi possibile che gli errori di valutazione dei bambini riflettano l’atteggiamento dei genitori, la cultura e l’educazione ricevuta (Zisenwine, 2013).
Fantasia dei bambini e processi cognitivi
Le ricerche hanno valutato anche la possibilità che determinati processi cognitivi possano influenzare l’abilità dei bambini di distinguere tra realtà e fantasia.
Secondo Wooley (1997), emozioni intense potrebbero influenzare il processo cognitivo alla base della distinzione tra realtà e immaginazione spingendo i bambini a credere che entità appartenenti al mondo della fantasia possano esistere anche nella realtà.
Un altro processo cognitivo che potrebbe far luce sulla capacità di distinguere tre realtà e fantasia dei bambini fa riferimento all’euristica della disponibilità di Kahneman e Tversky, per cui gli oggetti o gli eventi facilmente richiamabili alla mente tendono a essere valutati come più comuni e probabili.
Se si applica questo principio all’abilità dei bambini di discriminare la realtà dalla fantasia è possibile ipotizzare che immaginare qualcosa accresca la sua disponibilità cognitiva, incrementando la tendenza a considerare gli elementi immaginati come reali. Quindi, quando i bambini visualizzano stimoli spaventosi questi diventano accessibili e sono di conseguenza percepiti come reali (Zisenwine, 2013).
Discriminazione tra realtà e fantasia dei bambini: implicazioni cliniche
La capacità dei bambini di discriminare tra realtà e fantasia sembra avere importanti implicazioni anche a livello clinico.
Vari studi hanno messo in luce una relazione tra deficit nelle capacità di discriminazione realtà-fantasia e lo sviluppo di paure notturne e disturbi d’ansia correlati.
Le paure notturne sono in genere rappresentate dalla paura di separazioni notturne, da paura del buio, paura di dormire o di fare incubi.
Le paure notturne sono una normale parte dello sviluppo del bambino (Muris, Merckelbach, Olendick, King, & Bogie, 2001). Tuttavia, è stato stimato che il 20% dei bambini hanno severe paure notturne e problemi del sonno (Gordon, King, Gullone, Muris, & Ollendick, 2007). Se queste paure rimangono non trattate, potrebbero persistere e avere effetti negativi sullo sviluppo del bambino sfociando in disturbi d’ansia nella tarda infanzia e in adolescenza e correlandosi a difficoltà nel funzionamento quotidiano, difficoltà sociali e accademiche, bassi livelli di autostima, depressione e, in alcuni casi, abuso di droghe (Zisenwine, 2013).
Zisenwine et al. (2013) evidenziano che la capacità di discriminare tra realtà e fantasia dei bambini migliora con l’età. I bambini di 5 anni sono più confusi rispetto ai bambini al di sopra di tale sogli d’età. Come descritto da Piaget, sembra che i bambini più piccoli siano particolarmente suscettibili al pensiero magico a causa della loro immaturità cognitiva. Inoltre Zisenwine et al. (2013) mettono in luce un ritardo nello sviluppo delle abilità di discriminazione realtà-fantasia dei bambini con paure notturne. I bambini che soffrono di paure notturne tendono a fare maggiore confusione tra fantasia e realtà rispetto ai coetanei che non presentano tale problematica.
L’associazione tra paure notturne e deficit di discriminazione fantasia-realtà potrebbe avere diverse origini. È possibile, ad esempio, che uno sviluppo deficitario dell’abilità di distinguere la fantasia dalla realtà contribuisca all’emergere e al persistere della paure nei bambini. L’incertezza dei bambini rispetto all’esistenza di entità magiche come streghe, fantasmi e mostri potrebbe generare e mantenere le paure nei confronti di queste creature.
In alternativa, è plausibile che paure particolarmente intense intralcino lo sviluppo e l’esercizio delle abilità di discriminazione realtà-fantasia dei bambini. Wooley (1997) ritiene che le emozioni intense esperite dai bambini che soffrono di paure notturne o fobie influenzino negativamente la loro capacità di comprendere che gli eventi o le entità immaginate non sono reali, soprattutto se tali stimoli sono associati a emozioni negative.
I dati sulla bassa capacità di distinguere tra realtà e fantasia dei bambini con paure notturne hanno significative implicazioni cliniche. Una potenziale implicazione potrebbe essere che l’incremento delle abilità di discriminazione fantasia-realtà potrebbe essere uno degli obiettivi da perseguire nel trattamento di bambini con paure notturne.
Un’altra implicazione è relativa alla possibilità di utilizzare tecniche immaginative nel lavoro con i soggetti che presentano tale problematica. È stato dimostrato che i bambini tendono a usare l’immaginazione per affrontare le loro paure. Studi recenti hanno evidenziato che dare ai bambini una bambola di pezza raccontando loro una storia correlata a questa figura è in grado di aiutare i bimbi a fronteggiare eventi di vita stressanti, determinando una significativa riduzione delle paure notturne nei soggetti analizzati.
Percorsi terapeutici
La terapia cognitivo comportamentale è la prima linea di trattamento per i bambini con paure e disturbi d’ansia. Desensibilizzazione sistematica, esposizione in vivo, ristrutturazione cognitiva, rinforzo e modellaggio sono tutte tecniche efficaci per il trattamento dell’ansia (Davis & Ollendick, 2005).
Anche la biblioterapia è stata identificata come un approccio alternativo al trattamento di bambini e adolescenti con varie forme di pscicopatologia (Rickwood & Bradford, 2011).
La biblioterapia consiste nell’uso di libri come parte integrante della terapia per il trattamento dei disordini mentali. La teoria alla base dell’utilizzo della biblioterapia si fonda sull’assunto che la lettura di materiali relativi alle aree problematiche può produrre cambiamenti specifici e prevedibili (Lenkowsky, 1987), riducendo l’ansia e rafforzando le strategie di coping.
La biblioterapia richiede abilità di lettura e comprensione del testo, quindi nel caso di bambini in età prescolare che non hanno ancora tali capacità è tipicamente demandata ai genitori che saranno chiamati a narrare storie e racconti ai propri figli.
Lewis et al. (2015) hanno sottoposto un gruppo di bambini di età compresa tra 5 e 7 anni con paure notturne e ansia a un intervento di quattro settimane basato sull’utilizzo della biblioterapia. Ai genitori dei bambini partecipanti è stato chiesto di narrare ai propri figli una serie di storie appositamente selezionate dagli sperimentatori. Il confronto tra le valutazioni pre-trattamento e post-trattamento hanno messo in luce una significativa riduzione delle paure notturne e dei sintomi d’ansia manifestati dai bambini.
Questi dati sono incoraggianti, rappresentano un valido esempio di integrazione tra ricerca e pratica clinica evidenziando come i risultati derivati dalla letteratura che ha esaminato le competenze di discriminazione realtà-fantasia dei bambini possano essere un valido punto di partenza per integrare l’attività del clinico con nuovi obiettivi di lavoro raggiungibili attraverso il ricorso a tecniche cognitivo comportamentali classiche e alternative, quali la biblioterapia.