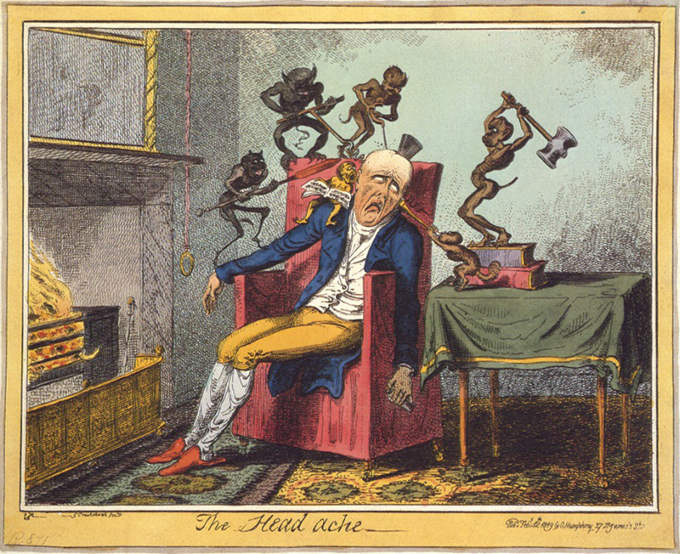La dipendenza da nicotina e possibili interventi terapeutici
Dipendenza da nicotina: Analizzando i pensieri dei soggetti dipendenti da nicotina così come da altre sostanze, è emerso come sia presente un particolare stile cognitivo, il “pensiero desiderante” che influenza il livello di craving esperito durante l’astinenza: nel pensiero desiderante si preconfigura l’oggetto del desiderio sottoforma di immagini e pensieri verbali determinando un aumento del craving.
Martina Lattanzi, OPEN SCHOOL STUDI COGNITIVI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
La diagnosi di dipendenza da nicotina
Nel DSM-5 i criteri diagnostici per il disturbo da uso di tabacco prevede un pattern di sintomi tali da determinare un distress e un danno significativo dal punto di vista clinico. Devono essere presenti almeno due dei seguenti sintomi per un periodo di 12 mesi (Cosci et al., 2014):
- Assunzione in quantità o in durata maggiori di quanto previsto;
- Desiderio persistente o incapacità di cessare;
- Una grande quantità di tempo viene spesa per procurarsi il tabacco;
- Presenza di craving;
- Uso di tabacco fa sì che non si riesca a funzionare in modo adeguato sul lavoro, a casa o a scuola;
- Uso del tabacco viene perpetrato nonostante provochi problemi sociali o interpersonali;
- Importanti attività sociali, lavorative o ricreative sono state cessate o ridotte a causa dell’uso del tabacco;
- Utilizzo ricorrente del tabacco in situazioni a rischio;
- Uso del tabacco viene perpetrato nonostante la consapevolezza che stia creando o esacerbando problemi fisici o psicologici;
- Presenza di tolleranza;
- Presenza di segni e sintomi astinenziali.
Inoltre bisogna sottolineare che nel DSM-5 tra i criteri diagnostici fondamentali per formulare la diagnosi di disturbo da uso di sostanze è stato finalmente introdotto anche il craving. Il craving infatti è uno degli aspetti centrali di tutte le dipendenze patologiche ed è descritto come un’esperienza soggettiva che motiva gli individui a cercare di raggiungere un oggetto o praticare un’attività allo scopo di ottenere effetti piacevoli (Marlatt, 1978). Il soggetto durante il craving vive sensazioni fisiche e psicologiche spiacevoli come tremore, agitazione, irritabilità, aumento di ansia e stress, che si differenziano per caratteristiche e intensità a seconda della sostanza utilizzata, ed è responsabile di quel desiderio irrefrenabile di riprendere l’uso della stessa rendendo il soggetto vulnerabile alla ricaduta.
I sintomi dell’astinenza da nicotina
Da un punto di vista fisiologico, alla base delle sensazioni negative descritte dalle persone al momento della cessazione del fumo, si ipotizza che vi sia una up-regulation dei recettori nicotinici, ovvero un aumento di tali recettori a causa della precedente desensibilizzazione, degli stessi. Di conseguenza per ottenere le stesse sensazioni piacevoli si verifica una compensazione, una eccessiva produzione di recettori, che si legano al neurotrasmettitore acetilcolina (responsabile delle sensazioni piacevoli di benessere, euforia, riduzione di tensione). Nel cervello dei fumatori infatti i recettori nicotinici sono da 100 a 300 volte più numerosi rispetto ai non fumatori (Perry et al., 1999). Sembra proprio che sia l’aumentata attività colinergica a indurre lo stato di malessere generalizzato, ansia, irritabilità, agitazione e disturbi del sonno che caratterizzano la sindrome da astinenza del fumatore (Hughes et al., 1990).
Questi sintomi comportano nel soggetto il desiderio irresistibile di riprendere a fumare per desensibilizzare di nuovo l’attività di alcuni recettori e ridurre così gli effetti negativi dell’aumentata attività colinergica (Watkins et al., 2000). Tra gli effetti dell’astinenza da nicotina vi è anche l’alterazione dell’umore, soprattutto nelle prime ore o giorni, causando, a volte, nel soggetto una vera e propria depressione (Glassman et al., 1990; Tylor et al., 2014). Si può verificare rabbia, umore depresso, aumento dell’appetito, difficoltà di concentrazione.
Dipendenza da nicotina: sia fisica che psicologica
Oltre alla dipendenza fisica la nicotina crea una dipendenza psicologica: fumare diventa un modo per alleviare lo stress quotidiano, per calmarsi, per ridurre l’ansia, abbassare il livello di attivazione delle emozioni, proprio grazie agli effetti positivi della nicotina sul nostro cervello. Se all’inizio infatti ciò che spinge a fumare può essere un modo per auto-medicarsi o auto-gratificarsi, dopo poco tempo insorge la dipendenza a mantenere il comportamento e subentra la difficoltà a controllare i propri impulsi (Goodwin et al., 2002).
Dipendenza da nicotina e vulnerabilità agli attacchi di panico
Diversi studi hanno dimostrato che il fumo di sigaretta e la conseguente dipendenza da nicotina aumentano il rischio di sviluppare un disturbo da attacchi di panico (Bakhshaie et al., 2016). Non è ancora ben chiaro quale sia il meccanismo che li lega, ma sono state formulate alcune ipotesi: nei soggetti ansiosi, particolarmente sensibili agli aspetti che riguardano la respirazione (“fame d’aria”, paura di soffocare), il fumo va a peggiorare la funzionalità respiratoria in quanto c’è un aumento di anidride carbonica nel sangue a scapito dell’ossigeno. La nicotina potrebbe quindi contribuire agli attacchi di panico proprio a causa di questo scambio tra anidride carbonica e ossigeno (Zvolensky et al., 2005a; Moylan et al., 2013).
Inoltre nella comprensione dei meccanismi che possono essere coinvolti nella maggiore vulnerabilità al panico potrebbero essere la presenza tra i fumatori di una maggiore tendenza ad aumentare le sensazioni corporee spiacevoli (Abrams et al., 2011). La “sensibilità all’ansia” ovvero una forte preoccupazione circa le conseguenze negative dei sintomi ansiosi. In particolare i fumatori con alta sensibilità all’ansia percepiscono la probabilità di smettere di fumare come un’esperienza difficile e pericolosa, probabilmente a causa della ipersensibilità alle sensazioni negative ed ai sintomi astinenziali (Zvolensky et al.,2004). Questo potrebbe far accrescere l’ansia e quindi incrementare la vulnerabilità al panico (Zvolensky et al., 2005b).
Dipendenza da nicotina e depressione
In letteratura sono presenti inoltre studi in cui emerge una relazione tra depressione e dipendenza da nicotina. La dopamina, la noradrenalina e la serotonina sono infatti neurotrasmettitori implicati nei disturbi dell’umore, così che l’interruzione della nicotina può portare a sviluppare sintomi depressivi, a causa dell’alterazione dei suddetti neurotrasmettitori. Inoltre alcuni studi hanno rilevato un maggior rischio di suicidio tra i fumatori rispetto ai non fumatori (Bifulco, 2016).
La maggior parte dei sintomi depressivi, legati alla sospensione della nicotina, scompaiono dopo circa un mese e il soggetto, nel lungo termine può beneficiare di una migliore qualità di vita.
Terapia della dipendenza dalla nicotina: le fasi
In uno studio di meta-analisi (Grucza et al., 2014) è stata valutata la salute mentale dei fumatori attraverso la somministrazione di questionari, prima e sei settimane dopo l’interruzione della dipendenza da sigarette; nello studio è stata valutata la presenza di condizioni di ansia, di depressione o entrambe, di emozioni positive, dello stress e della qualità della vita. Dallo studio emerge che smettere di fumare si accompagna ad una significativa e duratura riduzione di depressione, ansia e stress e ad un miglioramento dell’umore e della qualità della vita. Inoltre gli effetti benefici dell’interruzione del fumo non differiscono tra soggetti sani e soggetti già affetti da disturbi psichici (Grucza et al., 2014).
Nel fumatore spesso manca la volontà di smettere di fumare, nonostante ve ne sia la reale necessità per la propria salute fisica. La profonda convinzione di voler abbandonare una condotta nociva per la propria salute è una componente fondamentale nel momento in cui si decide di smettere di fumare e se la forte motivazione manca il fumatore si potrà ritrovare in una spirale di tentativi continui e continui fallimenti. Si deve avere una forte motivazione per resistere al craving piuttosto intenso delle prime ore e giorni dalla cessazione dal fumo perché è proprio questa la fase più delicata. Per comprendere il ruolo della motivazione al cambiamento può essere utilizzato, come riferimento, il modello transteoretico di Prochanska e Di Clemente (1994), così da capire in quale fase il tabagista si trova e regolare di conseguenza l’intervento di aiuto in modo adeguato.
Il soggetto si può trovare nella fase della pre-contemplazione dove ancora non è consapevole di avere un problema, non è preoccupato del proprio stato di salute e non ha alcuna intenzione di smettere di fumare. In questa fase può essere utile iniziare a ragionare insieme sui pro e i contro del fumare, cercando di insinuare nel soggetto delle incertezze rispetto alla convinzione, ancora presente, che fumare non faccia male (Tinghino, 2003). In questa fase i colloqui motivazionali sono sicuramente importanti per aiutare il soggetto a cambiare la propria visione della vita e innescare così un processo di cambiamento.
Nello stadio della contemplazione il soggetto inizia a pensare che in effetti ci possono essere dei vantaggi se smettesse di fumare, ma è ancora molto legato alle sensazioni piacevoli della sigaretta. In questo caso può essere utile fare un bilancio decisionale: riflettere sui vantaggi fisici, psicologici, relazionali, ambientali, economici che la cessazione del fumo può comportare, così come riflettere sui rischi per la salute e i danni effettivamente provocati aiuta ad avere una reale comprensione della propria situazione di dipendenza da nicotina. Può essere utile avvalersi di una tabella in cui scrivere analiticamente i vantaggi/svantaggi nel breve e lungo termine dello smettere di fumare.
Nella fase della preparazione il fumatore ha preso una decisione, si è convinto a voler cambiare e inizia a progettare dei piani; in questo momento è utile sostenere la sua motivazione, capire insieme i possibili ostacoli, definire gli obiettivi (Tinghino, 2003).
Nella fase dell’azione il fumatore mette in atto la cessazione delle sigarette e si confronta effettivamente con il cambiamento. Molto importante sarà il ruolo del terapeuta nel sostenere il soggetto in ogni minimo successo che vivrà in questa fase di forte vulnerabilità: il soggetto vivrà momenti di sconforto e momenti di euforia per cui un supporto psicologico è fondamentale (Tinghino, 2003).
Nella fase del mantenimento, quando ormai ci si può definire “ex fumatori” il terapeuta dovrà lavorare sul sostenere tale risultato positivo. Bisognerà anche affrontare il tema di una possibile ricaduta perché spesso può accadere che l’ex fumatore, dopo diverso tempo, ricada nella tentazione di fumare una sigaretta e in questi casi c’è la tendenza a considerare l’intero percorso un fallimento. Bisognerà discutere di questa eventualità e preparare il soggetto a reagire in maniera adattiva, ovvero non cadere nello sconforto totale e considerarsi un fallimento, autodenigrandosi (come spesso accade) ma affrontare la ricaduta come un singolo errore che si è commesso ma che non va a intaccare la riuscita dell’intero processo di cambiamento che ormai si è realizzato (Tinghino, 2003).
Ovviamente accanto ai trattamenti di natura psicoterapica è necessario affiancare una terapia farmacologica per aiutare il soggetto ad affrontare l’astinenza da nicotina.
Innovazioni nel processo terapeutico della dipendenza da nicotina: il craving
Accanto ai tradizionali protocolli di disassuefazione dal fumo, ormai in uso da diversi anni, recenti ricerche stanno apportando novità nella cura del tabagismo.
Analizzando i pensieri dei soggetti dipendenti da nicotina così come da altre sostanze, è emerso come sia presente un particolare stile cognitivo, il “pensiero desiderante” che influenza il livello di craving esperito durante l’astinenza: nel pensiero desiderante si preconfigura l’oggetto del desiderio sottoforma di immagini e pensieri verbali determinando un aumento del craving (Caselli et al., 2013). Inoltre tale stile cognitivo influenza i sintomi del craving, aumentandoli, in modo maggiore rispetto alla presenza di un temperamento caratterizzato dalla forte ricerca della novità, anch’essa presente nel soggetto dipendente.
Il pensiero desiderante può essere attivato e mantenuto da meta credenze positive e negative (Nikčević et al., 2010).
Il craving non sembra invece essere influenzato dal livello di stress percepito dal soggetto, e quest’ultimo risulta essere indipendente anche dal pensiero desiderante (Caselli et al., 2013).
Nella dipendenza da nicotina oltre alla presenza di un pensiero perseverante (pensiero desiderante) e di credenze meta cognitive maladattive, è stata riscontata anche la presenza della soppressione dei pensieri (comportamento autoregolativo maladattivo in cui si tenta di smettere di pensare a determinati contenuti mentali (Erskine et al., 2012).
La comprensione di tutti questi aspetti legati alla meta cognizione, agli stili di pensiero e alle strategie di coping che sono presenti nel fumatore, permetterà di avere una nuova prospettiva di cura della dipendenza da nicotina: si potranno attuare interventi con specifici obiettivi terapeutici modellati sul soggetto, intervenendo non più sugli impulsi e sul desiderio del fumatore ma sugli aspetti meta cognitivi, aumentando la consapevolezza dei propri pensieri e delle proprie strategie di controllo.