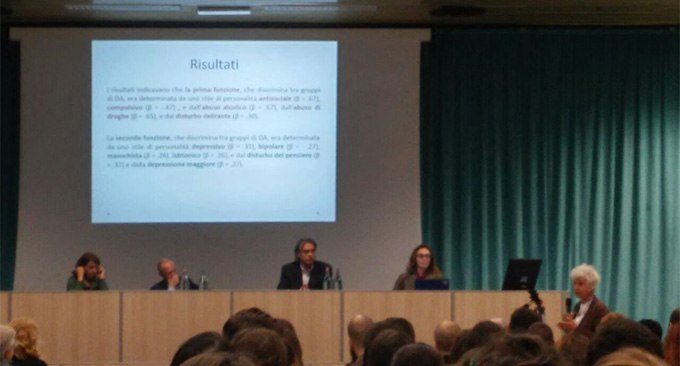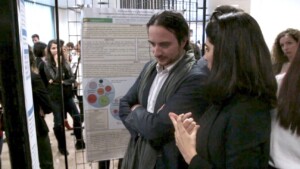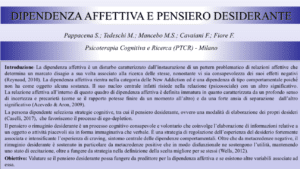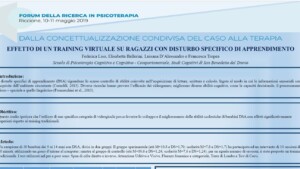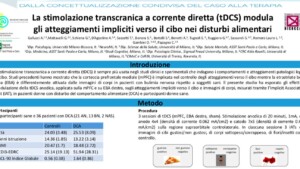La Ricaduta nell’ alcolismo: fattori predisponenti, craving e modelli di prevenzione
La ricaduta è un fenomeno che si presenta quando una persona, che ha un problema di dipendenza come l’ alcolismo, consuma nuovamente la sostanza dopo un periodo di astinenza.
Marta Bugari – OPEN SCHOOL Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto
La ricaduta nell’uso di sostanze da parte di soggetti detossificati è un evento comune, al punto che può essere considerata una componente costante nella storia naturale dei Disturbi da Uso di Sostanze (DUS) e del loro trattamento. I trattamenti di recupero tradizionali, concettualizzano la ricaduta come una sconfitta, un esito negativo equivalente al fallimento del trattamento.
Questa prospettiva considera il trattamento un processo dicotomico che può esitare solo o nell’astinenza completa o nella ricaduta. Al contrario diversi modelli basati su teorie sociali, cognitive e comportamentali interpretano la ricaduta come un processo transitorio, una serie di eventi che si dispiegano nel tempo. (M. E. Larimer, R.S. Palmer, G. A. Marlatt,, 1999)
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la Dipendenza come “disturbo cronico e recidivante” a sottolinearne la lunga durata ed il decorso caratterizzato da periodi di remissione totale o parziale e da periodi di riprese dei comportamenti “tossicomanici”. (M. Cibin, I. Hinnenthal, E. Levarta, E. Manera, M. Nardo, V. Zavan, 2001)
Alcolismo e ricaduta
Una delle poche aree di consenso nel trattamento dell’ alcolismo riguarda l’idea che l’ alcolismo sia una condizione cronica con alto rischio di ricaduta.
Gli studi hanno riportato un tasso del 80% o più di ricadute dopo 6 mesi dal trattamento, con esiti dei singoli pazienti che si sono rivelati altamente instabili nel corso del tempo.
Sebbene i risultati siano poveri, nel trattamento con gli alcolisti, ha avuto nel complesso un grande successo l’avvio del loro comportamento di cambiamento .
Infatti, le ricerche suggeriscono che gli i pazienti con alcolismo hanno difficoltà nell’intraprendere un cambiamento per conto proprio e che il problema centrale, come in altri problemi di dipendenza, è mantenere il cambiamento nel tempo. (H.M Annis, 1986. pp. 407–408)
Nel percorso che porta l’alcolista inattivo alla ricaduta, egli compie una serie di “atti apparentemente insignificanti” che progressivamente lo avvicinano all’alcol cosi che la ricaduta inizia prima del primo uso di alcol e continua dopo l’uso iniziale.
Gli stimoli ambientali hanno un importantissimo ruolo nell’innescare e mantenere questa condizione e tuttavia una forte variabilità individuale nella risposta agli stimoli.
L’utente tende a riferire la ricaduta come “casuale” o determinata dalle pressioni sociali: “… mi sono trovato di fronte al solito bar…”, “…ho incontrato un vecchio amico e non ho resistito”. Spesso la responsabilità del comportamento è attribuita al caso o ad altre persone e questo può essere un tentativo di attenuare i sensi di colpa e di impotenza.
I motivi che portano alla ricaduta
Numerosi studi hanno dimostrato come la ricaduta abbia una sua storia, dei correlati psicologici, biologici e che non sia quasi mai un evento puntiforme.
Anche situazioni di malessere psicologico possono innescare il processo di ricaduta come pure situazioni stressanti non correlate alle sostanze d’abuso. (M. Cibin, I. Hinnenthal, E. Levarta, E. Manera, M. Nardo, V. Zavan, 2001)
In uno studio su pazienti con alcolismo sono stati studiati i predittori del desiderio di bere e la relazione tra il desiderio e il bere immediatamente dopo il trattamento.
La ricerca è stata condotta su 26 uomini con problemi di alcolismo, trattati in una struttura ospedaliera o un programma ambulatoriale intensivo e sottoposti a due sessioni di laboratorio prima di essere dimessi.
Dopo la dimissione i partecipanti hanno manifestato il desiderio di bere otto volte al giorno per 21 giorni. Coloro che hanno segnalato impulsi sul campo avrebbero una maggiore dipendenza dall’ alcol con punteggi più elevati di rabbia e ansia di tratto rispetto a chi non ha riportato questo desiderio.
Inoltre questo studio condotto in laboratorio e sul campo, ha riportato che il desiderio di assumere alcol è correlato con il bere subito dopo il trattamento ed è più probabile sia presente in coloro che hanno una più grave dipendenza e un maggiore disturbo dell’umore. Questi individui possono beneficiare maggiormente di interventi per far fronte al desiderio di assumere la sostanza dopo il trattamento. (M.D. Litt, N.L. Cooney, P. Morse,, 2002)
Spiegare la ricaduta: il modello Relapse Prevention
Marlatt & Gordon nel 1985 pubblicarono un testo rimasto basilare nella comprensione dei processi psicologici sottendenti la ricaduta.
Il loro modello RP “Relapse Prevention“ è basato su teorie di psicologia sociale e cognitiva e comprende anche una serie di strategie cognitive e comportamentali per prevenire o limitare gli episodi di ricaduta. (M. E. Larimer, R. S. Palmer, G. A. Marlatt, 1999)
Un aspetto centrale del modello è la classificazione di fattori o situazioni che posso verificarsi o contribuire all’episodio di ricaduta. In generale il modello RP postula che tali fattori si dividono in due categorie: “fattori determinanti di ricaduta” e “fattori preparatori per la ricaduta”.
Il modello RP postula che le situazioni ad alto rischio, possono rappresentare una minaccia al livello di autocontrollo della persona ed essere precipitatori immediati di uso di alcol iniziale dopo l’astinenza. Secondo il modello, una persona che ha avviato un cambiamento del comportamento, come l’astinenza da alcol, dovrebbe iniziare a sperimentare un maggiore senso di autoefficacia o padronanza del suo comportamento che dovrebbe rafforzarsi a mano a mano che il cambiamento del comportamento si realizza. (M. E. Larimer, R.S. Palmer, G. A. Marlatt, 1999)
Nel modello i fattori determinanti di ricaduta sono:
- Situazioni ad “Alto rischio”, ovvero tutte quelle situazioni che sono state identificate dai pazienti come fattore principale di ricaduta e che in ordine di importanza possono essere categorizzate come: stati emotivi negativi (rabbia, ansia, depressione, frustrazione, noia) situazioni interpersonali (in special modo di conflitto) pressione sociale (ad esempio essere con altre persone che stanno bevendo) o perfino stati emotivi positivi (desiderio di mettere alla prova la propria forza di volontà).
- La capacità di coping personale, nella misura in cui un paziente è esposto ad una situazione ad “alto rischio” come quelle categorizzate sopra, l’esito o meno verso una ricaduta dipende dalla risposta del paziente alla situazione, che a sua volta è determinata dalla sua capacità di coping, ovvero la capacità di far fronte con strategie comportamentali o cognitive alla situazione di esposizione.
- Le aspettative sugli effetti positivi dell’ alcol nel far fronte a situazioni di malessere intra o interpersonale; maggiore è questa aspettativa, maggiore è il rischio di ricaduta.
- L’effetto “violazione dell’ astinenza” ovvero l’attribuzione di significato che il paziente da alla prima violazione dell’astinenza. Un’ attribuzione legata a vissuti di fallimento personale e inadeguatezza anziché ad una non ancora completa abilità nell’affrontare situazioni ad “alto rischio”, porta più facilmente ad una seconda violazione e all’abbandono del trattamento. (M. E. Larimer, R.S. Palmer, G. Alan Marlatt, 1999)
Il ruolo del craving
Vi sono però anche una serie di fattori meno evidenti che hanno effetto sul processo di ricaduta in caso di alcolismo; i fattori preparatori ad una esposizione a situazione ad alto rischio:
- Variabili esistenziali in termini di livelli di stress (lavoro, famiglia, ecc.)
- I fattori cognitivi che possono ripristinare le condizioni che determinano la ricaduta, come la razionalizzazione, la negazione e il desiderio di gratificazione immediata o craving.
Questi fattori possono aumentare la vulnerabilità di una persona alla ricaduta sia aumentando la sua esposizione a situazioni ad alto rischio sia diminuendo la motivazione a resistere di bere in situazioni ad alto rischio. (M.E. Larimer, R.S. Palmer, G. A. Marlatt, 1999)
Il craving è il desiderio impulsivo per una sostanza psicoattiva, per un cibo o per qualunque altro oggetto-comportamento gratificante che sostiene il comportamento “addittivo” e la compulsione finalizzati a fruire dell’oggetto di desiderio.
Nell’ alcolismo, il craving, può essere definito “urgenza di bere”, cioè la tensione a consumare la sostanza, il pensiero ossessivo ricorrente del bere, sino alla perdita del controllo dei propri impulsi nei confronti delle bevande alcoliche.
Secondo Meyer (2000) il craving sarebbe prontamente stimolato da fattori previamente associati con la sostanza, elementi capaci di svolgere un ruolo “trigger” (grilletto) che innescano con un meccanismo di condizionamento e, per associazione di idee, il desiderio della gratificazione ottenuta chimicamente. (G. Gerra, A. Zaimovic, 2002)
Nelle dipendenze da sostanza, il ripetersi dello stimolo “artificiale” fa si che quest’ultimo prenda progressivamente il posto di quelli naturali: da qui la perdita di interesse per le normali attività della vita, il pensiero concentrato sull’alcol, l’incapacità di conservare un sia pur precario equilibrio psichico in assenza della sostanza. Gli effetti della sostanza prendono così il posto di funzioni mentali fondamentali e la gratificazione indotta dalla sostanza diviene parte del funzionamento mentale, modificandolo. (M. Cibin, M. Mazzi, L. Rampazzo, G. Serpelloni, 2001)
Mentre la semplice assunzione delle sostanze psicoattive che segue i ritmi e le modalità del comportamento addittivo è regolata da un processo automatico, il craving comporta l’attivazione di un meccanismo cognitivo che non corrisponde ad un processo automatico. L’urgenza di utilizzare la sostanza, è connessa piuttosto con un conflitto nell’ambito cognitivo tra la motivazione all’assunzione dell’alcol o della droga e la consapevolezza del rischio che ne deriva: in quest’ottica dunque il craving diviene funzione di diversi fattori che interagiscono in un mutevole equilibrio con il mondo intrapsichico e con le interferenze ambientali.
Petrakis, (1999) distingue due forme di craving dal punto di vista delle aspettative del paziente: da un lato la preoccupazione di assumere la sostanza per evitare l’astinenza che viene definita “craving negativo”, dall’altro la compulsione nei confronti della sostanza sostenuta dall’aspettativa di una incentivazione, di una gratificazione. In questo caso la ricerca di un “reward” produrrebbe un “craving positivo”. (G. Gerra, A. Zaimovic, 2002)
Recenti ricerche (De Bruijn et al. 2005, Gordon et al. 2006) hanno confermato che craving è il predittore del risultato del trattamento.
Inoltre alcuni autori (Drummond et al., 2000, Shiffman 2000) hanno differenziato due modalità di desiderio: il craving base e il craving episodico.
Il craving base è sperimentato tonicamente, caratterizzato dallo stato di equilibrio stabile durante il giorno è endogeno, né provocato né modificato da stimoli ambientali esterni. Il craving episodico indica la comparsa di attacchi sporadici intensi di desiderio per l’alcol, generato e modulato da diversi stimoli ambientali o stati affettivi specifici. Gli attacchi di desiderio episodico sono considerati precursori diretti di ricaduta. ( O. Vuković, T. Cvetic, M. Zebić, N. Marić, A. Damjanović, M. Jašović-Gašić , 2008)
Secondo Szegedi (2000), il desiderio della sostanza è sostenuto dall’esposizione a stimoli condizionanti (cue), dallo stress e da condizioni a rischio del tono dell’umore (trigger mood) che mantiene elevati livelli di craving e insieme dalla capacità di adattamento legata ai tratti temperamentali, alle caratteristiche psicologiche e ai disturbi psichiatrici, nonché la consapevolezza del rischio connessa invece con la storia individuale, i fattori culturali, ambientali e relazionali. (G. Gerra, A. Zaimovic, 2002)
Da alcune ricerche è emerso che stimoli esterocettivi come la vista e l’odore di bevande alcoliche non sono sempre sufficienti per suscitare il desiderio di alcol. È stato suggerito che spunti enterocettivi, come ad esempio gli stati di umore, possono anche svolgere un ruolo nel provocare il desiderio di alcol. Per verificare ciò, otto soggetti con alcolismo sono stati indotti a sperimentare stati d’animo negativi o neutri in quattro giorni separati, quindi esposti alla vista e l’odore della loro bevanda alcolica preferita e ad uno stimolo neutro (acqua). I risultati di questo lavoro indicano che l’esposizione ai segnali di alcool non ha avuto effetti sul desiderio per l’alcol mentre i soggetti erano in uno stato rilassato umore neutro e che la presenza di stati emotivi negativi sembrava essere sufficiente per provocare il desiderio dell’ alcol in alcuni soggetti, indipendentemente dal fatto che venga presentato alcol o acqua. Questi dati sostengono che gli stati d’animo negativi possono determinare il desiderio di alcol indipendentemente da altri stimoli. (M.D. Litt, N.L. Cooney, R.M. Kadden, L. Gaupp ,1990)
Inoltre è stato trovato che il craving nelle prime due settimane di astinenza correla positivamente con ricaduta tra 3 e 12 settimane e che la voglia di alcol indotta da umore negativo è un predittore di recidiva. (O. Vuković, T. Cvetic, M. Zebić, N. Marić, A. Damjanović, M. Jašović-Gašić , 2008)
Il fallimento del processo di fronteggiamento delle “Situazioni ad Alto Rischio”, fa si che il paziente con alcolismo inattivo assuma la prima dose di alcol innescando l’“effetto di violazione dell’astinenza” (“effetto primo bicchiere”), cui seguono sentimenti di fallimento e di incontrollabilità della situazione, e, quasi inesorabilmente la ricaduta completa. Può apparire stupefacente che le condizioni emotive e i conflitti interpersonali siano situazioni a rischio più frequenti che le occasioni o le pressioni sociali.
In realtà queste ultime sono spesso portate dai pazienti perché più facili da spiegare, rispetto a movimenti psichici di cui hanno talora poca dimestichezza, e quasi sempre grande pudore: il rafforzamento della capacità di gestire le situazioni emotive e i conflitti interpersonali devono far parte integrante di un processo di counseling rivolto a questi pazienti. (M. Cibin, I. Hinnenthal, E. Levarta, E. Manera, M. Nardo, V. Zavan, 2001)
Obiettivi del modello Relapse Prevention
Il modello Relapse Prevention di Marlatt e Gordon (1985) ha come obiettivo aumentare la capacità di fronteggiamento (Coping Skills) rispetto al processo di ricaduta in particolare alle “Situazioni ad alto rischio” e all’“Effetto di violazione dell’astinenza”.
Acquisite informazioni sulle abitudini alcoliche e di vita del paziente e sulle “costanti” della ricaduta, la prima parte questo percorso prevede il sostegno al paziente rispetto alla ricaduta ed ai sentimenti negativi che la accompagnano, quindi la ricostruzione del “processo” che ha portato alla ricaduta, riconoscendone le varie tappe, gli eventi scatenanti, la dipendenza da stimoli ambientali, gli stati d’animo ed il livello di consapevolezza che le hanno caratterizzate.
In seguito si individuano insieme al paziente le cause delle difficoltà e le modalità per fronteggiarle. Tali cause possono riguardare sia il processo di ricaduta in sé, e quindi prevedere tecniche di evitamento o fronteggiamento (una classica tecnica è quella della telefonata all’amico sobrio), o il training per lo sviluppo delle capacità assertive e della autoefficacia.
In altri casi è necessario affrontare situazioni emotive o interpersonali che il paziente non riesce a gestire, spesso originatesi all’interno della famiglia, situazioni di scarsa motivazione o “apparente motivazione” e modalità efficaci per fronteggiarle. Queste ultime possono essere le più varie: dall’evitamento, alla richiesta di aiuto esterno, alla decisione di intraprendere una farmacoterapia di supporto. (M. Cibin, I. Hinnenthal, E. Levarta, E. Manera, M. Nardo, V. Zavan, 2001)
Il processo di prevenzione della ricaduta in casi di alcolismo si salda fortemente da un lato sulla motivazione dall’altro sullo stato psichico dell’utente. Secondo la Teoria della Motivazione infatti, l’attitudine al cambiamento non è data una volta per tutte, ma richiede ripetuti e numerosi passaggi attraverso fasi di “non cambiamento “ o di “ambivalenza”, che si ripetono prima di ogni nuova “azione”.
Anche in una situazione quale la prevenzione della ricaduta, che abitualmente si colloca in una fase relativamente avanzata del trattamento e in cui il paziente ha già intrapreso svariate “azioni” di “riduzione del danno”, presa di coscienza del problema con le sostanze, di disintossicazione o di stabilizzazione farmacologica, è necessario non trascurare l’ attitudine di “azione” rispetto al problema specifico. Può infatti accadere che il paziente non sia cosciente di comportamenti a rischio (fase di precontemplazione), oppure che pur essendo cosciente di questi problemi, non intenda in questo momento cambiarli (fase di contemplazione).
Ancora, il paziente può avere una percezione della propria capacità di affrontare tali situazioni (autoefficacia) irrealisticamente alta, o al contrario così bassa da essere “sconfitto” in partenza.
In tutti questi casi, gli elementi di prevenzione della ricaduta vanno proposti in una veste “motivazionale”. (M. Cibin, I. Hinnenthal, E. Levarta, E. Manera, M. Nardo, V. Zavan, 2001)
Il colloquio di motivazione è considerato oggi una delle abilità irrinunciabili per chi si occupa di problemi con le sostanze perché aiuta il paziente a trovare le proprie motivazioni, secondo i suoi tempi e le sue attitudini.
Per intraprendere interventi di prevenzione della ricaduta è necessario dunque procedere in primo luogo ad una diagnosi motivazionale, valutando cosa il paziente è effettivamente disposto a fare ai fini di evitare la ricaduta. (M. Cibin, I. Hinnenthal, E. Levarta, E. Manera, M. Nardo, V. Zavan, 2001)