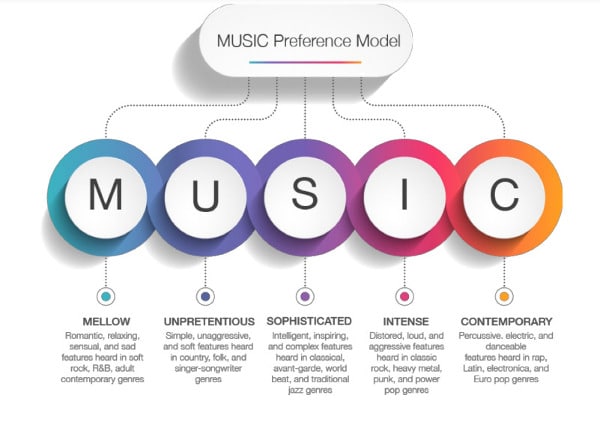Essere un talento in azienda? Si, se ti trovi nel posto giusto al momento giusto
Ci riferiamo ad un talento quando parliamo di una persona che, messa nelle giuste condizioni, in una data azienda e in un dato momento storico, ha una performance superiore alla media, rispetto al business nel quale è coinvolto, e ha una buona espressione dei comportamenti ritenuti chiave dall’azienda nella quale si trova, in un dato momento.
Silvia Mancuso – OPEN SCHOOL, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca Bolzano
La psicologia del lavoro fa risalire la gestione aziendale dei talenti al 1998, quando il termine talento viene coniato da David Watkins di Softscape e pubblicato in un suo articolo. Potete quindi immaginare quanto sia breve la sua storia, la quale inizia a prendere piede nei contesti organizzativi solo negli anni ’90.
La gestione del talento è un processo che cominciò ad essere adottato dal momento che molte organizzazioni si resero conto che i loro migliori lavoratori, con le loro abilità, potevano portare successo al loro business aumentandone i profitti. Prima di allora era possibile accedere ad una crescita aziendale soprattutto grazie agli anni di esperienza ma raramente vi era un diverso sistema di valutazione del potenziale. Si pensava poi che la leva, che più di tutti riusciva ad ingaggiare il personale, fosse la garanzia di una crescita economica e di livello contrattuale. Questo sprint era però a termine e non garantiva un coinvolgimento futuribile.
In questa prospettiva si decideva di puntare su un singolo dipendente, pagando la demotivazione dei più che si ritrovavano a dover accettare che il loro sistema non li considerasse profili di potenziale. Nell’ultimo periodo le aziende hanno smesso di guardare agli anni di esperienza e decidono di puntare su profili con attitudini particolari. La modalità è economica: aspettando che questi emergano dal contesto, rispetto ad altri dipendenti, scegliendo di investire su coloro che faranno la differenza e che potrebbero portare valore al business.
Il talento
Quando si parla di talento si intende una predisposizione innata che si può manifestare in una o più aree della vita di una persona, presente in ognuno di noi. È possibile vedere una persona talentuosa eseguire un compito ottenendo risultati migliori, se confrontanti con quelli di altri con le stesse possibilità e che si trovano in una medesima situazione.
I talenti capaci di alte prestazioni possono dimostrare abilità intellettuali, oppure attitudini creative e/o accademiche, leadership oppure spirito di squadra: qualsivoglia compito o gestione di una situazione che permette loro di avere eccellenti risultati rispetto quelli di altri, nelle medesime condizioni.
Affinché si ottengano risultati elevati, non è necessario avere un talento. A volte si tratta di una predisposizione verso una certa attività, o verso dinamiche interpersonali. Una capacità naturalmente posseduta, ancora più profonda di una attitudine.
Molte persone ne possiedono uno, o più di uno, ma non hanno mai avuto modo di realizzarlo poiché sono il contesto e gli aspetti motivazionali che ne permettono la realizzazione.
Tale caratteristica talentuosa può essere presente in ognuno di noi e può essere scoperta solo in un dato contesto e momento storico.
Il talento in azienda
Un’azienda che prende consapevolezza di quanto detto potrà percepire tutti i lavoratori come una risorsa centrale per il proprio business. In questi casi si ha a che fare con una sofisticata cultura aziendale che punta sull’evoluzione della vita organizzativa e sul rapporto tra motivazione e contesto.
Per poter riconoscere un talento è necessario avere consapevolezza della sua esistenza e creare degli strumenti basati sulla valutazione e sviluppo del personale. In tale scenario è possibile dare spazio ad ogni dipendente usando un approccio basato su un tipo di relazione che metta al centro le loro emozioni, pensieri e comportamenti portando alla luce il prodotto di credenze funzionali e disfunzionali che creano per lui motivazione e sofferenza nel tempo, a causa di aspettative disattese. Il dipendente deve quindi sentire di avere la possibilità, e l’opportunità, di portare fuori queste idee e queste emozioni affinché possano prendere un corretto senso, ottenere una spiegazione semplice che spesso coincide con il recupero del senso comune basato su una visione e su valori aziendali condivisi e reali (non solo dichiarati).
Secondo la teoria cognitivo-comportamentale è possibile notare delle distorsioni cognitive e delle rappresentazioni soggettive della realtà che generano malessere nell’individuo: non sono gli eventi a creare e mantenere sofferenza quanto l’influenza della struttura e della costruzione cognitiva dell’individuo (assunto di base di Epitteto).
Per ottenere dal singolo, o dal gruppo, il massimo livello delle proprie capacità prestazionali, è necessario operare in un contesto con una comunicazione orientata verso il senso di appartenenza e un allineamento tra i manager che operano un comportamento basato sui valori aziendali dichiarati. Sentirsi responsabili della creazione di un contesto e di un clima positivo è il primo presupposto per mettere i talenti nelle condizioni di lavorare bene e di potersi esprimere.
Il compito del leader è di motivare le persone a compiere sforzi extra, non contenere la loro creatività (Buratti, 2000). La fiducia da parte del proprio responsabile è determinante perché una persona ispirata possa avere successo. Ciò che serve maggiormente all’impresa innovatrice è la capacità di risolvere i problemi, caratteristiche che la tenacia e l’entusiasmo del leader possono contribuire a sviluppare.
Un responsabile che vede in un profilo di potenziale una minaccia, che non stima i propri collaboratori e le loro doti, che non dimostra di avere i valori aziendali non darà modo al sistema di riconoscere le proprie risorse. Lo stesso vale per un sistema che decide di investire solo su un determinato tipo di profilazione basato su un range di età, sesso e provenienza geografica.
Allo stesso modo penso delle tecniche di recruitment marketing, talent acquisition ed employer branding: è necessario che l’immagine che si decide di comunicare corrisponda ad una cultura reale.
Come riconoscere un talento
L’ufficio recruitment, come l’intero dipartimento risorse umane, in passato erano visti come l’area meno attendibile e prevedibile in termini di performance, soprattutto dagli uffici tecnici che avevano quantità di dati facilmente sottoponibili ad analisi. Negli ultimi anni l’uso di strumenti di valutazione standardizzati, all’interno del dipartimento HR, ha permesso di aumentare l’attendibilità ricercata, riuscendo a notare comportamenti predittivi circa l’ingaggio e il futuro percorso aziendale dei candidati e dei dipendenti. All’interno di un’organizzazione i metodi di ricerca e selezione di un talento rimangono spesso quelli classici ovvero, semplificando il processo: definizione delle caratteristiche ricercate, apertura di un processo di selezione e valutazione per ricercarne le caratteristiche ideali, un tipo di processo orientato verso l’esterno.
La prospettiva che vede il talento quasi fosse una star aziendale è un approccio obsoleto che genera un sistema di riconoscimento che sviluppa una cultura aziendale individualista e competitiva. Responsabilizza la selezione del personale perché si focalizza sulla ricerca spasmodica verso l’esterno sminuendo l’attenzione verso i dipendenti provocando un calo della motivazione e aumentando il tournover. In questo tipo di dinamica la formazione e lo sviluppo sono riservati solo a pochi mentre il prescelto è caricato della responsabilità di dover garantire sempre performance ad alto livello.
Tale visione statica delle capacità individuali non considera o promuove l’apprendimento e l’ottimizzazione delle competenze, ponendo un’eccessiva enfasi sulle persone senza considerare il sistema nel quale si vive.
L’approccio che preferisco considerare vede come talenti tutti i dipendenti e i futuri dipendenti di un’azienda. Questa visione presuppone una gestione del talento già presente in azienda, non una ricerca rivolta verso l’esterno. Questa visione si oppone alle teorie d’élite che valorizzano solo un gruppo di prescelti verso cui l’azienda decide di investire tramite formazione e percorsi di sviluppo.
In questo scenario i percorsi di sviluppo e di formazione dovrebbero essere garantiti a tutti i dipendenti tramite una strategia che li valorizzi, attenzionando la loro creatività (Vicari, S., Troilo, G.,1999) e offrendo all’azienda la certezza di avere dei lavoratori consapevoli delle loro competenze, delle loro doti e delle loro aree di miglioramento.
Nella guerra ai talenti è necessario considerare anche tali aspetti se si ha l’intenzione di non perderli in fase di reclutamento a causa di una cattiva reputation.
La gestione del talento
Riuscire a reperire profili di potenziale è sempre più difficile, ma lo è ancora di più trattenerli. Molte aziende stanno rispondendo a questa esigenza valorizzando il posto di lavoro, inserendo componenti attrattive, spesso dando più importanza all’apparenza rispetto che alla sostanza. Intendo dire che sicuramente un dipendente sarà attratto dal campo da basket, dalla mensa gratuita e dalla possibilità di fare smart working ma questo non basta se il contesto nel quale questi aspetti sono inseriti non permettono di essere messi nelle condizioni di poter lavorare a proprio agio.
Una volta trovato il profilo di potenziale bisogna quindi trattenerlo immaginando una quotidianità gestita da un sistema che vede nel reparto risorse umane un ente volto alla creazione di una collaborazione continua fra reparti. La collaborazione tra le parti contribuisce ad aumentare l’attendibilità delle competenze individuate in fase di selezione o in fase di valutazione del potenziale.
Per potersi esprimere nel migliore dei modi è necessario trovarsi in un contesto facilitante. Per tale motivo la collaborazione fra reparti diventa sempre più cruciale affinché si possa considerare la relazione professionale anche un modo per creare dei progetti non solo di business ma anche di crescita personale e professionale. Consapevole che non è ipotizzabile creare dei percorsi di sviluppo personalizzati perché non sarebbe efficiente in termini di costi, nasce comunque la necessità di realizzare programmi di gestione e di sviluppo differenziati e innovativi, al fine di motivare i lavoratori e trattenerli nell’organizzazione.
Stimolare la creatività in azienda
Se consideriamo la terapia cognitivo-comportamentale, le emozioni e i comportamenti delle persone vengono influenzati dalla loro percezione degli eventi. Non è la situazione in sé a determinare ciò che le persone provano, ma è piuttosto il modo in cui la interpretano.
Nella gestione del personale diventa cruciale capire qual è il modo distorto di pensare che influenza negativamente l’umore e il comportamento del singolo nel gruppo.
Mettendo in luce una valutazione realistica delle situazioni e il cambiamento che ogni persona vive nel suo percorso di vita sarà possibile ottenere un miglioramento dell’umore e del comportamento. Per ottenere un risultato a lungo termine è necessario modificare le credenze disfunzionali sottostanti attraverso l’addestramento a questo modo di pensare di tutto il personale aziendale.
La gestione del personale da parte dell’impresa dovrebbe quindi privilegiare la considerazione delle variabili umane osservando i dipendenti in relazione alla loro caratteristica primaria dell’essere persone e, quindi, come uomini e donne, dotati di intelligenze, sentimenti e caratteri, prima ancora che in relazione alla loro posizione organizzativa o contrattuale nei confronti dell’impresa e quindi funzionalistica al business. Così facendo si ha la possibilità di ottenere il meglio dalla forza lavoro.
In questo scenario la formazione e lo sviluppo dei dipendenti offre l’occasione di sviluppare non solo la consapevolezza di sé e dei propri pensieri ma stimola la creatività, offrendo tematiche di crescita, ad esempio su nuovi modi di porsi davanti una situazione lavorativa in base alla loro personalità e al personale modo di leggere le situazioni vissute.
La generazione di nuove idee fa parte della prospettiva cognitivista che vuole l’innovazione di un pensiero positivo contro i pensieri veloci che nascono da credenze personali (Buratti, 2020).
L’idea di base è che sia possibile fornire degli strumenti di valore ai dipendenti che diano loro maggiore consapevolezza di sé, dei loro pensieri veloci e di quelli non funzionali che generano atteggiamenti non adattivi. Nella relazione è possibile imparare a riconoscerli per sostituirli con pensieri e atteggiamenti più funzionali. Questo permetterà non solo una crescita personale, un aumento della creatività e della resilienza ma anche un senso di maggiore senso di empowerment (Piccardo, 1992; Dellacasa, Moncini, 2002; Nacamulli,1992; Ippolito, 2000; Conti, De Risi, 2001)
Il pensiero creativo (Plsek, 1997; Goldenberg, Mazursky, 2002) non si attua attraverso lo sprigionamento di energie creative disperse all’interno dell’impresa, ma è un semplice processo mentale mirato a generare nuove idee all’interno di una relazione di valore, rispetto a uno scopo preciso, ad un compito o una situazione più o meno ricorrente quale può essere il proprio lavoro.
Questo tipo di atteggiamento è presente nelle logiche proposte dal pensiero creativo, (Plsek, 1997; Goldenberg, Mazursky, 2002) dall’intelligenza emotiva (Goleman, 1997) o dal vecchio, ma sempre attuale, concetto di problem solving i quali producono innovazione.
La vecchia cultura ha sempre cercato di trovare dei metodi per evitare di stimolare la creatività dei dipendenti perché la generazione di nuove idee poteva essere sovversiva rispetto alle regole che sembravano governare un’organizzazione. Le possibili nuove proposte e le soluzioni innovative potevano minare il delicato equilibrio, figlio di una mentalità statica.
Molti studi dimostrano invece come il livello e le performance creative dell’intera impresa scaturiscono dall’interazione tra soggetti, anche non creativi, ed attiene alle modalità di rielaborazione ed utilizzo delle esperienze disponibili presso i singoli componenti dell’organizzazione attraverso l’incontro e lo scambio, sia formale che informale.
Vicari (Vicari, 1992) definisce imprese di successo quelle caratterizzate da elevati livelli di creatività individuale ed elevati livelli di creatività organizzative. Tali imprese sono quelle che fondano la propria strategia sull’innovazione e sulla capacità di fronteggiare il cambiamento, che riescono a stimolare la creatività dei singoli e a coniugarla con quella organizzativa. Lo sviluppo di pratiche finalizzate alla stimolazione della creatività all’interno dell’impresa risulta connesso con lo sviluppo di azioni organizzative mirate a far emergere i talenti e a valorizzarli. Una politica manageriale orientata alla creatività, infatti, consente di usufruire di tutta l’energia creativa disponibile presso l’impresa e di focalizzarsi sulla percezione dei segnali deboli presenti nelle potenzialità inespresse.
Le leve di intervento nello sviluppo del potenziale in azienda
Le leve d’intervento che le aziende dovrebbero utilizzare per dotarsi e sviluppare personale talentuoso sono tre: la selezione, la formazione e la ricompensa.
La selezione e le modalità di reclutamento variano in base alle posizioni aziendali da occupare e la politica aziendale dovrebbe partire sempre dal reclutare il personale interno puntando sul loro sviluppo. Tale processo di selezione è possibile se l’azienda annualmente si preoccuperà di sottoporre tutti i dipendenti ad una valutazione delle conoscenze, capacità/abilità e competenze, il cui esito è registrato in un gestionale che ne tenga traccia. A seconda delle necessità questo sistema garantirà la tracciatura di quelle competenze richieste e ricercate. Sarà ipotizzabile la possibilità di colmare eventuali lacune con la formazione.
La formazione sarà impartita sia nelle fasi di inserimento che negli stadi più avanzati. Non sarà centrata solo sul ruolo di destinazione. Come sostiene Bauman (2003) ci troviamo in una società liquida in continuo cambiamento e non possiamo pensare che i ruoli pensati per un’azienda in un dato perioda debbano rimanere tali.Si rende necessaria una visione del sistema azienda che agevola itinerari di sviluppo tramite job-rotation interfunzionali sia per offrire al dipendente una visione sistemica dell’azienda ma anche per rafforzare l’integrazione tra le diverse funzioni, inoltrela formazionie lo sviluppo delle soft skills quali ad esempio la comunicazione, la negoziazione o la gestione dei conflitti dovrebbe essere continua.
La ricompensa infine contribuisce a motivare e incentivare i dipendenti.
L’attenzione alla persona, alle sue capacità e l’offerta di un orientamento verso le scelte e le possibilità di sviluppo professionale permette un senso di coinvolgimento.
Non sarà più necessario parlare solo di ricompense economiche e di livello ma lo sviluppo personale, anche in una diversa funzione aziendale, sarà letto come occasione di sviluppo all’interno di un programma personale di miglioramento continuo che si prefigge di innalzare i propri livelli personali e ottenere un maggiore senso di empowerment (Piccardo, 1992; Dellacasa, Moncini, 2002; Nacamulli,1992; Ippolito, 2000; Conti, De Risi, 2001).
Queste leve dovrebbero essere inquadrate in un processo di comunicazione continua che dovrà coinvolgere il personale e soprattutto ascoltare la loro voce per ottimizzare il tiro. I dipendenti devono sempre essere aggiornati sulle strategie aziendali e non avere la percezione di trovarsi in un’ambiente statico e impersonale.
Il personale deve percepirsi come la risorsa di maggiore importanza perché creatore di valore che alimenta il successo dell’azienda, con la consapevolezza che il successo della loro organizzazione è anche di loro responsabilità. Favorire l’ingaggio, il senso di appartenenza e lo sviluppo dell’individuo vuol dire favorire anche il suo senso di responsabilità.
Conclusioni
Possiamo quindi dire che ci riferiamo ad un talento quando parliamo di una persona che, messa nelle giuste condizioni, in una data azienda e in un dato momento storico, ha una performance superiore alla media, rispetto il business nel quale è coinvolto, e ha una buona espressione dei comportamenti ritenuti chiave dall’azienda nella quale si trova, in un dato momento. La stessa persona, in un’altra azienda o in un diverso momento storico, potrà non essere considerata un talento.
Tutti quindi possiamo essere considerati profili di potenziale, con la giusta dose di fortuna nel trovarci nel posto giusto al momento giusto.