Pietro Rizzi.

Allora, il tentativo di organizzare e (se c’è stato piacere) di conservare la trama di azione/percezione cui abbiamo assistito, ci induce a parlare. Non sempre, e non solo, per riprendere un controllo razionale sul mondo di eventi complicati che ci ha catturato nei rituali 120’, ma proprio per l’impulso primitivo ad “agire insieme” con gli altri, il nostro compagno o compagna, il nostro gruppo di riferimento. In essi ci rispecchiamo, parlando (qualche volta in modo un po’ sconnesso) come i nostri antenati commentavano episodi di caccia, di raccolta e anche, ahimé, di guerra e saccheggio cui avevano partecipato.
Poco più in là, c’è il piacere di raccontare… il racconto. Piacere da sera accanto al fuoco, mentre fuori è notte: solo che qui usciamo dalla notte artificiale del cinema, per entrare spesso nell’altra notte luminosa e colorata delle città notturne. Ma se seguite, di soppiatto, una coppia che in una sera particolarmente tarda rientra a casa parlando di un film, vi accorgerete di quanto questa vicenda primaria (parlarsi di notte) risorga con tutta la sua forza rassicurante: e se il film era un giallo o un horror il dialogo, forse, continuerà a letto, prima o dopo aver spento la luce; mentre se il film era sentimentale, allora forse succederà dell’altro…almeno speriamo.
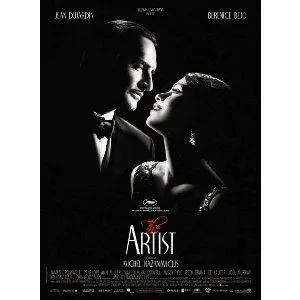
Insomma, discutiamo di come eravamo: il cinema ci trascina sempre, in qualche modo, nel passato. Attraverso il passato individuale profondo attivato dalle identificazioni e proiezioni (e identificazioni proiettive) con cui il film ha lavorato dentro ciascuno, si attiva un passato ancor più primitivo che in termini un po’ aulici potremmo chiamare il passato psichico e storico della specie. Vedere, per credere, il ciclo de “Il pianeta delle scimmie” e il suo straordinario finale (per ora) ad opera di Tim Burton.
Ma se questa è la forma fenomenica del nostro discutere di cinema, che cosa troviamo alla sua base, nella sua sostanza?
Per lo psicoanalista, la risposta è in apparenza obbligata. Ci sono i fantasmi: noi non vediamo, ha detto qualcuno, non vediamo davvero altro che i nostri fantasmi. Soprattuttto oggi, i fantasmi proiettati sulla superficie ininterrotta delle immagini che ci scorrono davanti quotidianamente.
Non si parla forse di “scena fantasmatica”? Certo, sono le emozioni quello che ci sembra di catturare a parole: emozioni talora così intense che, come ben sa chi vuole condurre un dibattito al cineforum, producono dapprima una forma di afasia tale che è necessario un certo periodo di tempo per potervisi svincolare. Ma i veri protagonisti sono i fantasmi: la ghirlanda di fantasie inconsce che ciascuno si porta dietro e che la scena fantastica vista sullo schermo non può fare a meno di attivare. I fantasmi traspaiono dai discorsi, si fanno visibili da quella quota di “invisibile” che il film porta con sé e sta “dietro” la superficie del film: la fantasia comune (si veda “La rosa purpurea del Cairo” di Woody Allen) che dietro lo schermo si trovi un intero mondo infinito, di un’enorme ricchezza, ne è precisa testimonianza. Il linguaggio con il quale parliamo, che ci sembra spesso di coniare ad hoc per quel particolare film, è infiltrato da questo mondo fantasmatico tanto, che il fatto di poterlo condividere con altri ci rassicura profondamente: meno angoscia e quasi un sollievo, un piacere, di potersene liberare con poca fatica.

E infine: quando discutiamo di cinema parliamo di qualcosa che non smette mai di abitarci e di inquietarci, anche quando è fonte di piacere. Parliamo, inconsapevolmente, del nostro corpo. Proprio del corpo: nostro inquilino/proprietario, che nel corso della visione del film ci è potuto sembrare assente o silente, soprattutto se siamo stati comodi e a nostro agio. Ma è proprio lui che è stato stimolato a dare risposte, a reagire, a com-muoversi: perché il film, come il nostro corpo, è un’ unità psicofisica o meglio psicosomatica, fatto di ben altro oltre che di immagini: di percezioni diverse, suoni, colori, gesti, azioni, oggetti animati e inanimati. Ognuno di questi elementi, e questi elementi tutti insieme, “fanno” l’unità psicosomatica del film. E, se è vero che il legame psichico con quanto avviene sullo schermo è prodotto dalla catena delle identificazioni, è pur vero che non può non esserci, in profondità, l’attivazione di una sorgente psichica primitiva, connessa con le esperienze più antiche della coesione intima di sé: appunto quell’unità psicosomatica che, lo sappiamo da Winnicott, è fondamentalmente legata all’esperienza di creatività. E’ una risonanza psicosomatica profonda, ciò che si attiva durante il film, mediata dal piacere cenestetico che un film promette, spesso fornisce, talvolta invece nega crudelmente. Quante volte si esce da un film con un senso di malessere, una sofferenza senza causa apparente che ci testimonia il cattivo incontro; quante volte, al contrario, si esce sollevati, leggeri, anche quando il film non è stato necessariamente altrettanto leggero? Non abbiamo forse sperimentato una quasi-felicità quando abbiamo visto un film ricco di vitalità, di humour, di arguzia: ciò che rende indimenticabile, per citarne solo uno, Chaplin/Charlot?
La parola, allora, è il tentativo (inevitabilmente riuscito solo a metà) di dire queste sofferenze o questa felicità, risuonando ancora, retrospettivamente, con il corpo del film e risuonando attualmente con il corpo dei nostri compagni e delle nostre compagne. La parola riscopre allora la sua stessa natura di unità psicofisica, di forma prima di tutto musicale, che ricompone il corpo al suo interno, e il corpo proprio con il grande corpo della realtà esterna, del mondo: è il momento magico nel quale la singolarità di ciascuno, il gruppo umano, la natura sembrano per un momento privi dei confini e delle trincee che li circondano, invece, nella vita di tutti i giorni. E’ un momento di profonda integrità e di libertà.
Così, continuiamo e continueremo a discutere, uscendo dal cinema. Da soli, in un soliloquio che in realtà è un dialogo tra i nostri sé; in compagnia, in un tentativo che per un momento non sarà del tutto illusorio, di essere insieme: insieme come in un piccolo Eden (era questo il nome di molte sale cinematografiche, un tempo); un Eden non più perduto, ma vivo come per magia, anche se solo per quel breve, effimero istante in cui muoviamo i primi passi fuori dalla sala, nella notte amica che ci attende.


