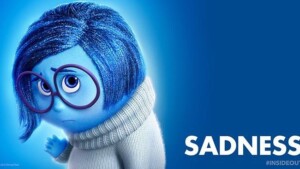Inside Out 2: non solo un film d’animazione per bambini
Solitamente non guardo i film più di una volta, se non a distanze temporali degne d’oblio, tuttavia, Inside Out 1 è stata una eccezione: negli anni l’ho rivisto, ripensato, utilizzato e discusso abbondantemente in diversi interventi di psicoeducazione. Potrebbe sembrare un film d’animazione per bambini ma, a mio parere, non è questo il suo (primario) intento.
Tutte le volte che mi trovavo a guardare il primo capitolo di Inside Out – in maniera analoga a quanto accadutomi con il sequel – mi trovavo a ripetere tra me e me: “Perché non farne oggetto di cineforum ed approfondimenti universitari?”. Il modello della mente proposto nel film si dimostra in linea con le moderne intuizioni delle neuroscienze affettive, con il taglio teorico cognitivo-evoluzionista ed il concetto di Sistemi Motivazionali Interpersonali, accordandosi con gli interventi focalizzati sulle emozioni e con i recenti contributi sulla embodied cognition (Farina & Liotti, 2018; Liotti & Cortina, 2009; Liotti, Fassone & Monticelli, 2017; Onofri, 2018; Panksepp, 1998; ad es. Jhonson & Campbell, 2021;). In Inside Out 2 ci ho visto molto altro, persino un riferimento esplicito al FACS e alle microespressioni facciali tanto care a Paul Ekman – ma andiamo per gradi (Ekman & Friesen, 1978;).
In questa edizione, c’è dell’altro che bolle in pentola, e questo altro, come in un thriller mozzafiato, mi ha ipnotizzato, divertito, meravigliato e commosso, tenendomi incollato sulla poltrona del cinema; il mio motto interiore – pressoché costante – era un po’: WOW (Keltner, 2015;); era come rivedere Art Attack, per quanto mi riguarda, un vero e proprio salto indietro nel tempo, in perfetto stile regressivo.
Gli affetti, l’embodied cognition e la coerenza del senso di sé in Inside Out
Anzitutto, in Inside Out 2 si esplicita – a scanso di equivoci – come le emozioni, tutte, abbiano un ruolo funzionale ed uno scopo adattivo; è un po’ come se, durante la visione, ci si sentisse validati nella propria esperienza soggettiva. Mi sono ritrovato a pensare incessantemente alle teorie di Allan Schore (2000; 2009) e di Daniel Hill (2015), in particolare circa il ruolo del corpo-mente nella regolazione degli affetti e delle emozioni (Ardovini, 2005). La visione delle emozioni, qui proposta, permette di comprendere bene come l’intento del corpo sia quello di marcare somaticamente, momento per momento, il nostro ambiente interno ed esterno (Damasio, 1996; Stern, 1985; 2005). D’altronde, già Freud (1922), scriveva che “L’Io è innanzitutto un’entità corporea”.
Sin dai primi minuti del film viene introdotto poi il concetto del sistema di credenze, cristallizzate nella mente di Riley, la protagonista; esse vengono presentate come una sorta di convinzioni innervate e profonde, intrecciate con il sistema dei valori, dette isole della personalità.
A partire dal concetto di core beliefs emergerebbe il senso di sé, proposto allo spettatore come una struttura nucleare, fondante la personalità e dotata di un gradiente dinamico, plastico – che offre un margine di apprendimento e, potenzialmente, di (costoso) cambiamento.
Il senso di sé, di cui si parla essendo di matrice interpersonale, emerge nel soggetto sotto forma di pensieri taciti, procedurali, preverbali, che parlano un linguaggio edonico – di pancia diremmo oggi; solo talvolta essi acquisiscono forme preconsce e verbalizzabili, alla stregua di pensieri automatici e di aspettative, ad es. “sono una brava persona”. (Beck 1976; Stern, ibidem; Beebe & Lachmann, 2014; Bowlby, 1989; Liotti, 2005; Ginot, 2015; Neisser, 1978; Weiss, 1998;).
Il film tratteggia bene la duplice prospettiva sulla natura umana (La Rosa & Onofri, 2018;). Quella bottom-up (più cara alle recenti teorie di terza ondata ed alle dinamiche, gestaltiche ed umanistiche) e quella top-down (associata soprattutto alle prime ondate delle correnti cognitive e comportamentali).
Per la prima volta i personaggi di Inside Out 2 – percorrendo il flusso di coscienza – giungono nelle segrete dell’inconscio e utilizzano espressamente il termine “negazione” riferendosi alla esclusione difensiva di contenuti cognitivo-affettivi (ad es. di natura erotica), resi inaccessibili per la coerenza e la salvaguardia del sé. Non a caso, a vigilare e censurare incessantemente l’ordine della mente vi sono i corpi di polizia mentale. Tra gli altri sistemi di difesa mentali ad es. emerge lo humor che, talvolta, con l’ausilio di Noia assume i tratti di un dirompente sarcasmo (Lingiardi, 2006).
Teoria della Mente, Mentalizzazione e Metacognizione in Inside Out
Assume rilievo, ancora, il tema della famiglia che incarna le costanti della base sicura sufficientemente buona (Bowlby, ibidem; Winnicott, 2004;); in particolare, all’interno del secondo episodio, la funzione familiare pare settata più sul polo esplorativo, promuovendo l’autodeterminazione di Riley.
Puntualmente gli scenari proposti paiono rimandare al costrutto di Teoria della Mente, facendo sì che lo spettatore riesca ad afferrare l’idea che ogni essere umano possegga un impianto altrettanto simile e complesso a quello della mente di Riley (ad es. il focus sulla mente di sua madre e di suo padre). Il concetto che gli autori paiono evidenziare è che una miriade di altrettante emozioni, desideri, scopi e conflitti si agitino in ogni vivente, rendendo di fatto tangibile la complessità relazionale entro cui – in quanto esseri umani – siamo innestati (Baron-Cohen, 1997; Farina & Liotti, ibidem).
La madre di Riley, ora, deve essere in grado di distanziarsi progressivamente dalla sua prospettiva, incontrando la mente della figlia (Fonagy & Allison, 2013); per farlo, è necessario che ricorra alle proprie capacità metacognitive, monitorandosi, autoregolandosi e smussando alcuni moti di iperprotettività (Semerari, 2015; Dimaggio, 2019).
Un cenno, insomma, al concetto di mentalizzazione e alla universalità delle emozioni, quale linguaggio comunicativo innato (Fonagy, ibidem; Ekman, ibidem; Semerari, ibidem; De Luca, Mazza & Gazzillo, 2017).
La resistenza al cambiamento e le emozioni secondarie in Inside Out
Con l’arrivo della pubertà, i piccoli protagonisti colorati che personificano le emozioni – in preda allo scompenso – si contendono la coscienza di Riley, simbolicamente rappresentata da una console. Il comando di quest’ultima diviene motivo di caotici conflitti e improvvisi dirottamenti. Lo scopo è sempre lo stesso: la protezione, il mantenimento della safety adattiva di Riley nei confronti dei cambiamenti. L’esito di ciò conduce a una rigida e ostinata resistenza al cambiamento, che lentamente pone Riley in scacco matto (Florita, 2011; Podolan & Gelo, 2023; Gazzillo, Leonardi & Bush, 2021;).
I nuovi alters emotivi, introdotti in questa edizione, sono Imbarazzo, Noia, Invidia e Ansia. Nel loro animarsi si nota come ad es. Invidia spinga Riley verso un sano narcisismo, portandola a desiderare stima e ad ambire autoaffermazione. In maniera altrettanto accurata, viene introdotta Ansia che, tra le emozioni menzionate, è forse quella maggiormente caratterizzata ed esplorata; mettendo bene in evidenza come, di concerto ai processi cognitivi (ad es. la pianificazione), essa sia necessaria nei processi di decision-making e durante le prestazioni di Riley. Una rappresentazione dell’ansia a tutto tondo e non come ingenuamente patogena. All’ansia dunque – un po’ come avveniva per Tristezza nella precedente edizione – viene riconosciuto il suo ruolo adattivo, a patto che essa sia gestita entro certi limiti – a conferma della nota curva a campana proposta da Yerkes e Dodson (1908); limiti che nella parte finale del film vengono superati, impattando negativamente su Riley e sul suo senso di sé, che ne risulta disorientato, disregolato e paralizzato, in preda al turbine di dubbi e insicurezze, innescate da Ansia, la quale, in maniera opprimente, monopolizza mente e corpo di Riley, isolandola dalla restante esperienza emotiva.
Via via Emozioni e Pensieri s’agitano, riverberando tra loro, in una forza centrifuga dalla quale svincolarsi diviene compito arduo. Il panico e la confusione crescono. La protagonista, allora, accettando di farsi attraversare da queste sensazioni implosive e parossistiche, pare dilatare spazio e tempo di manovra, trovando nel proprio respirare un’ancora di salvezza all’interno della tempesta – analogamente a quanto accade nelle tecniche basate sulla mindfulness e, più in particolare, nell’ACT (Hayes, 1999; Semerari, ibidem).
A questo movimento interiore di accettazione, vale a dire, alla difficile scelta di mollare il controllo corrisponde un globale movimento di flessibilità e di apertura al cambiamento; le emozioni, infatti, negli ultimi minuti del film, simbolicamente si alleano, rinunciando al potere e alla competizione e perseguendo una sorta di scopo cooperativo, che apre a un senso di sé armonico ed integrato, portando alla luce la compassione e l’empatia (Gilbert, 2019; Jhonson & Campbell, ibidem).
La gamma emotiva di Riley ne risulta espansa, al contempo, il nucleo della personalità, prima rigido e in continuo pericolo, ora, ne risulta più sfaccettato e flessibile. All’unisono gli alters emotivi asseriscono: “Amiamo tutto della nostra ragazza, ogni caotica meravigliosa parte di lei”.
Infine, molto altro vi sarebbe da scrivere, ad es. sul tema della (meta)vergogna, sul rapporto tra emozioni e pensieri, sul terreno in comune tra cognitivismo e psicoanalisi, sulla riscrittura mnemonica relazionale-implicita, sulle psicoterapie corporee ed esperienziali – a testimonianza del grande potenziale che movimenta questa opera (ad es. Bucci, 1997; Migone & Liotti, 2018; Dimaggio, ibidem; Ginot, ibidem; Van Der Kolk, 2020;).
Inside Out e il cambiamento che (per)turba
Se il vero protagonista di Inside Out 2 sono le emozioni, a mio parere, a farne il ruolo di antagonista è invece il tema del cambiamento – inteso come crescita. L’apparente stabilità che rassicura, il mutamento che (per)turba (ad es. Verdesca 2018a; 2018b; 2022).
Il film rimarca la sfida della autodeterminazione e, nel farlo, narra di una fase evolutiva fisiologicamente rivoluzionaria, quella della pubertà.
In essa, le emozioni e il corpo, loro teatro e mezzo d’azione, scrivono storie segrete, che assomigliano ai moti del mare. Quieti e tempeste, luci e ombre, superfici e profondità si reggono su un equilibrio dinamico, a prima vista alieno.
Inside Out 2, parla di tutte queste cose e, nel farlo, abbraccia una narrazione di stampo allegorico, che assume sembianze oniriche; un sogno che è possibile decifrare, ma dal quale destarsi risulta impossibile perché quel sogno – come una macchia di Rorschach – parla di te.