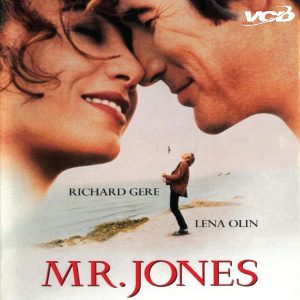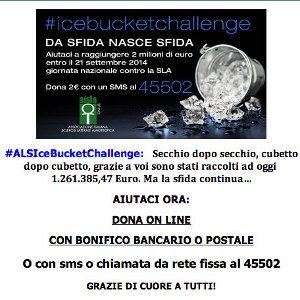Intervista a Dolores Mosquera: Elogio alla lentezza nel dialogo clinico
Dolores Mosquera è una psicologa e psicoterapeuta e nel panorama europeo è delle principali esperte e formatrici sul tema del trauma complesso e della dissociazione in pazienti con disturbi di personalità e disturbi dissociativi.
Vive e lavora in Spagna in numerosi centri clinici ed è autrice di importanti volumi sul tema del trauma complesso e dei trattamenti più efficaci presenti nel panorama scientifico attuale. Il suo lavoro terapeutico è il risultato dell’integrazione tra diversi approcci e tecniche, quali l’EMDR e la terapia sensomotoria, con importanti risultati di efficacia nel trattamento di patologie anche molto complesse come il Disturbo Dissociativo dell’Identità.
La cornice di riferimento è quella della teoria della Dissociazione Strutturale di Van der Hart, già discussa in precedenti contributi sull’argomento, in cui il funzionamento della personalità viene compreso individuando diverse parti del sé, in grado di rispondere a differenti situazioni e stimoli ambientali. Nell’approfondimento del funzionamento generale del paziente, questa cornice prevede l’individuazione di parti del sé più adulte e sviluppate sul profilo cognitivo, emotivo e comportamentale, che permettono cioè alla persona di portare avanti la propria vita in modo abbastanza efficace e soddisfacente, e di parti bambine e meno sviluppate dal punto di vista cognitivo, che portano cioè la persona a sentire le proprie emozioni in modo dirompente e a manifestarle con comportamenti spesso dannosi, per sé o per gli altri, o comunque poco efficaci nel soddisfare i bisogni affettivi che le generano.
In questo quadro generale, l’aspetto innovativo del lavoro di Dolores Mosquera, e della sua collega Annabel Gonzalez, è l’utilizzo del dialogo tra le parti accedendo al funzionamento del paziente attraverso la/e parti adulte e promuovendo il dialogo tra queste e le parti più piccole ed emotive; il terapeuta ha dunque innanzitutto il ruolo di moderatore tra le istanze di tutte le parti – in un lavoro terapeutico paragonabile a quello di una terapia di gruppo – e soprattutto di osservatore attento, in grado di cogliere l’ingresso di una o più parti all’interno del dialogo in corso. Questo secondo aspetto può essere di più facile interpretazione quando nel dialogo clinico emergono parti più attive e reattive, legate cioè ad un intenso iper-arousal (es: parti arrabbiate, parti spaventate, parti ansiose,..), mentre può diventare più difficile individuare l’ingresso di parti meno reattive (ipo-arousal), ma altrettanto profondamente sofferenti (es: parti bloccate nel trauma, parti sole, parti abbandonate, parti distaccate, parti che non sentono il corpo,..).
Il lavoro clinico presentato in occasione del Corso Internazionale Nuove Frontiere nella cura del Trauma tenutosi a Venezia lo scorso Giugno, si è concentrato proprio su tecniche specifiche da utilizzare nel portare avanti questo dialogo, ponendo molta attenzione soprattutto ai messaggi che arrivano dalle parti meno riconoscibili, ma che lavorano dietro le quinte, generando situazioni di conflitto talora intensissime e spesso non riconosciute, né esplicitate dal paziente.
In particolare ci si è concentrati sul riconoscimento dei segnali più subdoli e meno evidenti, osservando con estremo dettaglio le reazioni legate a reazioni di ipo-arousal di origine dissociativa: reazioni di blocco, di assorbimento, di assenza, di riduzione dello stato di coscienza o di alterata percezione del corpo. Questi segnali possono allarmarci meno, come terapeuti, rispetto a comportamenti più esplosivi o semplicemente risultare meno visibili, ma sono in ogni caso il sintomo di un grave fallimento integrativo, in genere scatenato dal dialogo in corso e dunque fondamentale da cogliere nel nostro lavoro.
I principali accorgimenti da seguire, secondo la Dott.ssa Mosquera, per lavorare in sicurezza con pazienti gravemente traumatizzati sono:
- riconoscere il ruolo di ogni parte e validare la sua importanza,
- capire i motivi del perché ogni parte ha bisogno di restare separata,
- parlare attraverso la parte più adulta e con più risorse,
- parlare a tutto il sistema includendo sempre tutte le parti,
- le parti non sono persone diverse, ma parti diverse della stessa persona e nessuna va ignorata,
- accettare l’esperienza del paziente, anche se non si è d’accordo,
- enfatizzare sentimenti di empatia interna tra le parti, di negoziazione e di cooperazione,
- partire sempre dalle risorse disponibili, anche se poche e molto primitive
- proporre soluzioni di gestione dei conflitti interni, che siano accettate da tutte le parti coinvolte,
- guadagnare, prima di ogni intervento, la fiducia di ogni singola parte.
E infine, raccomandazione importantissima, la velocità del lavoro terapeutico è sempre dettata dalla parte che procede più lentamente, senza la quale non si può e non si deve andare avanti!
Il lavoro presentato a Venezia ha dato l’occasione di acquisire strumenti utili per osservare e riconoscere tutte le parti presenti nella personalità dei pazienti, per raccogliere le più importanti situazioni trigger che generano conflitto tra le parti e per promuovere il dialogo tra esse in cerca di una soluzione più integrata, alla quale tutte devono necessariamente contribuire, dalla più piccola a quella più adulta.
Nell’intervista che segue la Dott.ssa Mosquera ci offre spunti clinici importanti e tecniche di emergenza da utilizzare in momenti particolari della terapia, in attesa della pubblicazione del suo nuovo libro su Trastorno Límite de la Personalidad y EMDR di prossima traduzione in inglese ed in italiano.
Quali sono le funzioni principali svolte dalle parti ostili, che di fatto ostacolano il processo terapeutico?

Tutte le parti, collaborative o distruttive, hanno avuto e hanno tutt’ora un ruolo adattivo fondamentale per la vita del paziente e questo ruolo va capito e condiviso con lui/lei, prima di qualunque intervento di modifica. Le funzioni principale che l’individuo delega alle parti ostili sono in genere:
- mantenere le difese dissociative utilizzate per isolare e contenere ricordi traumatici o per proteggere la personalità principale dalla rivelazione di segreti non condivisibili all’esterno;
- contenere sentimenti come la rabbia che il paziente non può tollerare o che non ha potuto esprimere, as es., per timore delle rappressaglie dell’abusatore;
- controllare il dolore infliggendolo alla personalità principale adulta, al posto di subirlo senza alcun controllo. Questo favorisce l’identificazione con l’aggressore e così la persona smette di sentirsi vulnerabile e vittima;
- proteggere la personalità principale generando sospetti verso persone che potrebbero abusare di loro oppure punendola per controllare una condotta che potrebbe esporla al rischio di un abuso;
- fornire la possibilità di mantenere un attaccamento con un caregiver che a volte è abusatore e a volte è affettuoso. Dissociando in parti distinte e separate gli aspetti buoni e cattivi del caregiver, il bambino può preservare il vincolo con il caregiver buono.
Tutte sono funzioni importantissime per la sopravvivenza fisica ed emotiva della persona e non possiamo pensare di modificare una parte ostile, di attaccarla o di ignorarla senza generare un conflitto intensissimo. Con tutte abbiamo bisogno di stabilire un contatto e una relazione di fiducia e collaborazione.
Come riconoscere, nel dialogo clinico, quando le parti ostili lavorano “dietro le quinte”?
Generalmente dò molta attenzione soprattutto al linguaggio del corpo. Il linguaggio dissociativo ci dice molto di più di quello che il paziente riesce a comunicare attraverso le parole. Qualche volta è possibile notare come alcune parti stiano comunicando internamente proprio davanti a noi e lo si può osservare ad esempio, attraverso cambi di postura, cambiamenti nello sguardo, atteggiamenti di ascolto interno. Ognuno di questi cambiamenti può indicarci che il paziente è bloccato. A volte questi segnali possono essere molto subdoli e perciò di solito cerco di comunicare con il paziente in modo tale che l’intero sistema ne sia informato e che non si senta minacciato. Ad esempio mi capita di dire E’ importante che tutte le parti della mente ora ascoltino ciò che diremo riguardo il trattamento, C’è qualcosa che possiamo dire a questa parte spaventata per rassicurarla?, Chiedile se possiamo fare qualcosa perché non si senta minacciata in questo momento.., Se comunichiamo solo alla parte adulta più funzionale o ci alleiamo con lei, il conflitto è garantito!
Quali sono i segnali di ipo-arousal dissociativo più frequenti?
I segnali di ipo-arousal sono molto importanti, ma tuttavia più difficili da identificare rispetto a quelli di iper-arousal. Ci dicono in generale che in quel momento per il paziente il nostro lavoro è troppo intenso. Quando i nostri pazienti non riescono a dire stop, il corpo e la mente lo fanno al loro posto. In uno stato di ipo-arousal possiamo notare ad esempio che il paziente non è più lì presente con noi o che non è connesso emotivamente a quello che racconta. Alcuni segnali tipici che precedono l’ipo-arousal possono essere il mal di testa, le vertigini, un senso di ottundimento, confusione, il paziente inizia a parlare molto più lentamente o a sentire una crescente sensazione di stanchezza.
Un ipo-arousal positivo, legato ad esempio ad uno stato di profondo rilassamento, permette alla persona di essere presente e consapevole nella situazione in cui è, di essere connessa con il proprio corpo e con le proprie emozioni. Di restare in contatto con la realtà.
Quali sono gli interventi principali da utilizzare in questi casi?
E’ fondamentale innanzitutto identificare l’ipo-arousal come stato emotivo, proprio perché il paziente tende a disconnettersi abbiamo bisogno di insegnargli a riconoscerlo in tempo. Altra cosa importante è individuare le situazioni trigger che lo causano, perché ci danno informazioni utili rispetto a quali aree della sua storia sono ancora inaccessibili per lui/lei e dunque per noi. L’idea generale che guida il mio lavoro è di tenere il paziente sempre consapevole e presente in ogni momento per evitare questo tipo di reazioni. Quando tuttavia succede, gli esercizi da fare per uscire dall’ipo-arousal possono essere: ricercare attivamente il contatto oculare con noi (sistema di coinvolgimento sociale), modificare la distanza in cui siamo seduti chiedendo feedback su questo (si sente meglio se mi siedo qui? Dove posso mettermi perché si senta più a suo agio?); in genere è utile aiutare il paziente ad orientarsi nel presente (ora è qui con me, siamo nel 2014, non si trova più lì, è riuscito a scappare e ora è al sicuro), si può chiedere di portare l’attenzione ad alcuni oggetti nella stanza e di provare a descriverli. In questa fase sono molto utili anche esercizi di grounding per recuperare il contatto con il proprio corpo e con sensazioni più piacevoli.
Quali esperimenti tipici della terapia sensomotoria risultano di solito efficaci in questi casi?
Alcuni esperimenti corporei della terapia sensomotoria, come ci insegna Pat Ogden, principale referente internazionale per questo metodo, possono essere molto efficaci. Un esempio è il mirroring , in cui il terapeuta può mettere in atto un comportamento che richiami sensazioni di calma e sicurezza di fronte al paziente, invitandolo a fare lo stesso (es: prendere un cuscino e tenerlo tra le braccia), oppure risulta molto utile talora invitare il paziente a notare la propria postura e proporre piccoli cambiamenti (es: se notiamo che la spina dorsale tende ad assumere una posizione accasciata, si può proporre di sedersi più dritti e notare la differenza); permettere sempre al paziente di scegliere cosa fare può essere di per sé un’esperienza ripartiva importantissima, poiché il vissuto di impotenza nel trauma può essere così intenso da diventare pervasivo (es: dare la possibilità al paziente di cambiare la sua posizione nella stanza o sulla sedia e invitarlo ad osservare come si sente). Invitare il paziente a completare alcuni gesti solo accennati durante il racconto di un evento significativo e fargli notare come si sente mentre lo compie (es: stringere un pugno se c’è un’emozione di rabbia, stendere le mani in avanti per ‘mettere distanza’ dall’aggressore). In generale gli esercizi di automonitoraggio in terapia sensomotoria insegnano ad osservare l’esperienza interna rintracciandone emozioni e sensazioni corporee, mentre gli esperimenti possono aiutare a sviluppare nuovi pattern di comportamenti utili ad incrementare, ad esempio, il proprio senso di sicurezza o anche solo la possibilità di ottenere sensazioni più confortevoli dal proprio corpo, esperienza spesso gravemente compromessa nei pazienti traumatizzati.
Quali segnali ci dicono invece che possiamo andare avanti nel processo terapeutico?
In generale sappiamo che l’integrazione sta procedendo bene se notiamo la comparsa di sentimenti di empatia tra le parti in conflitto, se c’è consapevolezza di quello che è accaduto di traumatico nel passato e di quello che le parti hanno dovuto fare per superarlo, se cambiano le credenze nucleari per la persona (Sono stata fragile e impotente nel passato, ma ora sono diversa, posso scegliere!), se le parti dissociate vengono riconosciute come parti di sé (Quella bambina sono io!), se la rabbia viene sentita e riconosciuta dal paziente e non più dissociata, se viene mantenuta la consapevolezza di essere nel presente e di avere risorse e possibilità nuove (il passato è passato, posso evitare che influenzi il mio presente!).
ARTICOLO CONSIGLIATO:
L’eco della violenza: l’ EMDR per il trattamento di vittima e aggressore
EMDR