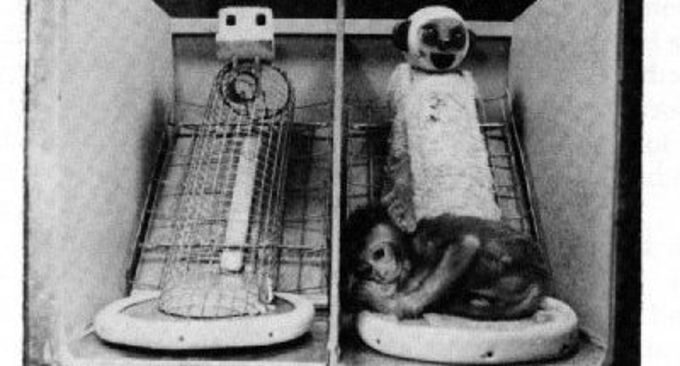I tentativi di suicidio in adolescenza: fattori di rischio e vulnerabilità psicologiche associate
Suicidio in adolescenza: Le particolari caratteristiche dell’adolescenza fanno sì che questo periodo della vita, connotato da una peculiare vulnerabilità psicologica, sia particolarmente a rischio di disturbi psichici ma anche di profonde sofferenze e turbamenti emotivi. Tutto ciò provoca un’elevata incidenza di tentativi di suicidio in adolescenza, alcuni dei quali purtroppo ad esito fatale, senza neppure la possibilità d’identificarne motivi plausibili. E’ certo comunque che si rintracciano nel loro determinismo fattori psicologici, individuali e contestuali, più o meno tra loro connessi, i quali supportano momenti predisponenti e scatenanti.
Michela Grandori, OPEN SCHOOL STUDI COGNITIVI
Aspetti epidemiologici dei tentativi di suicidio in adolescenza
L’argomento relativo ai tentativi di suicidio in adolescenza è quanto mai complesso e controverso. Sebbene tra i principali obiettivi della ricerca sul suicidio in adolescenza vi sia quello di individuare una stima attendibile del fenomeno, tale rilevazione risulta assai problematica data la tendenza a sottostimare l’incidenza del suicidio dovuta, da un lato, ad un atteggiamento di negazione e minimizzazione del problema, dall’altro, a differenze nelle procedure di registrazione dei suicidi nei diversi presidi sanitari: frequentemente, infatti, i tentati suicidi vengono registrati come incidenti ma capita anche che all’interno di molti casi di morte violenta risulti assai difficile discriminare la volontarietà dall’accidentalità del fatto. Per tale motivo i dati epidemiologici in merito all’aumento e alla diffusione del fenomeno negli ultimi anni sono contrastanti. Ci si trova di fronte ad un quadro caleidoscopico e frammentario con un incremento significativo negli ultimi anni, nelle classi di età più basse, tanto da poter collocare il suicidio come terza causa di morte per la popolazione fra i 15 e i 24 anni (Maggiolini et al., 2013; Schwarzenberg, 2002; Vanni, 2009).
Le particolari caratteristiche dell’adolescenza fanno sì che questo periodo della vita, connotato da una peculiare vulnerabilità psicologica, sia particolarmente a rischio di disturbi psichici ma anche di profonde sofferenze e turbamenti emotivi. Tutto ciò provoca un’elevata incidenza di tentativi di suicidio in adolescenza, alcuni dei quali purtroppo ad esito fatale, senza neppure la possibilità d’identificarne motivi plausibili. E’ certo comunque che si rintracciano nel loro determinismo fattori psicologici, individuali e contestuali, più o meno tra loro connessi, i quali supportano momenti predisponenti e scatenanti. Il passaggio all’atto può assumere significati del tutto diversi, la cui conoscenza può permettere di prevenire eventuali recidive, soprattutto se la presa in carico del giovane che tenta il suicidio è adeguata, paziente ed attenta e consente di fargli superare le difficoltà, le conflittualità e i disagi psicologici che compromettono quell’esistenza da cui vuole scappare (Pandolfi, 2000; Senise, 1989).
Fattori di rischio del suicidio in adolescenza
I fattori di rischio individuali che hanno mostrato la correlazione più alta con il suicidio in adolescenza sono:
1- Una storia pregressa di comportamento suicidale o parasuicidale.
Il tentativo di suicidio, generalmente, giunge al termine di un percorso lineare: in un primo momento si struttura un’ideazione di morte in cui il pensiero è rivolto frequentemente alla morte che è spesso ritenuta come l’unica possibile soluzione per affrontare l’impasse in cui il soggetto si trova; in un secondo momento può strutturarsi un’intenzionalità suicidaria, cioè l’adolescente può iniziare ad immaginare di darsi la morte che desidera; infine, il pensiero di morte e l’ideazione suicidale si possono associare alla costruzione di un vero e proprio progetto suicidale, quando viene definito un modo di agire per procurarsi la morte: vengono decisi gli strumenti, i tempi e le modalità. Il gesto suicidale segue la fase della progettazione e ne rappresenta il superamento ma solo un ristretto numero di adolescenti con ideazione e progettualità suicidale passa realmente a mettere in atto un progetto suicidale. Questa sottocategoria di soggetti è ad altissimo rischio di ripetizione di un tale comportamento: la possibilità che il passaggio all’atto venga ripetuto è decisamente elevata, fino al 50% nei successivi 2 anni. Un tentativo di suicidio, quindi, deve essere preso estremamente sul serio perché presenta un elevato rischio di ripetizione (Maggiolini et al., 2013; Vanni, 2009).
2- La presenza di disturbi psichici non riconosciuti o non trattati.
Per quanto riguarda i disturbi psichici, la depressione ha un ruolo significativo nel tentativo di suicidio in adolescenza: i dati empirici rilevano un’associazione tra alcuni sintomi depressivi, quali l’instabilità emotiva, il ritiro e la perdita della speranza, e l’emergere di comportamenti suicidari.
Tuttavia, sebbene la depressione sia lo stato affettivo che più si accompagna alla messa in atto di gesti suicidari, non tutti gli adolescenti che mettono in atto tentativi di suicidio sono depressi. Inoltre, tra i disturbi psichici emerge una relazione significativa anche tra l’abuso di sostanze e il suicidio in adolescenza: gli adolescenti che portano a termine un tentativo di suicidio dichiarano un utilizzo di alcol, droghe o un mix di entrambi più frequentemente, di almeno 4 volte, rispetto agli adolescenti che mettono in atto tentativi di suicidio non letali. Il contemporaneo consumo di alcool e droghe possono aumentare l’impulsività e l’aggressività e distorcere la percezione della realtà (Maggiolini et al., 2013; Vanni, 2009).
Si ritiene, comunque, che non sempre dietro un tentato suicidio in adolescenza siano presenti disturbi psichici conclamati quanto, piuttosto, organizzazioni sub-patologiche di personalità con difficoltà di mentalizzazione, tendenza all’impulsività, disperazione, insufficiente controllo, disregolazione affettiva, strategie di coping inefficaci e scarsa capacità di problem solving, elevati livelli di rabbia e tendenza al perfezionismo (Blumenthal et al., 1990; Boergers et al., 1998; Dori et al., 1999; Kashden et al., 1993; Witte et al., 2007).
Per quanto riguarda i fattori di rischio ambientali, bassi livelli di coesione, elevata conflittualità ed insoddisfazione all’interno della relazione genitori-adolescente sono elementi riscontrati frequentemente nelle famiglie degli adolescenti che tentano o completano il suicidio. La disarmonia e la disintegrazione familiare giocano un ruolo estremamente importante perché rendono l’adolescente privo di un contesto di riferimento solido e significativo che gli è ancora necessario. Anche i life events sono associati al rischio giovanile: in particolare, la morte di un genitore o una perdita significativa all’interno di una famiglia aumentano notevolmente il rischio di comportamenti suicidari. Stress di tipo interpersonale legati all’ambito familiare per i soggetti più giovani o a relazioni affettive significative per gli adolescenti più grandi, sono frequentemente riscontrati nei soggetti che compiono suicidio in adolescenza (Maggiolini et al., 2013; Vanni, 2009).
Le diverse condotte suicidarie in adolescenza
Se il suicidio e il tentativo di suicidio hanno, come eventi, una fisionomia ben definita ed un significato univoco – quello di togliersi la vita – essi sono, invece, dal punto di vista psicologico, eventi assai complessi sia nella fenomenologia che nelle dinamiche. E’ quindi più corretto parlare di condotte suicidarie.
Da un punto di vista fenomenologico, possiamo distinguere varie condotte suicidarie:
– Il suicidio riuscito che non pone evidentemente problemi semiologici né terapeutici; rimane invece del tutto aperto il problema dei veri motivi che lo hanno determinato, motivi che possono essere inferiti solo a posteriori e in via del tutto ipotetica, ripercorrendo le vicende e i processi che possono essere stati alla base ed utilizzando come fonte informativa le persone più o meno significative dell’ambiente e/o coloro che vi hanno assistito o che lo hanno scoperto. Sull’attendibilità di tali fonti bisogna, peraltro, andare molto cauti in quanto i processi di negazione e di trasformazione del significato e dei motivi dell’atto suicidario in sé e degli eventi e dei processi affettivi e relazionali che lo hanno preceduto, sono spesso estremamente imponenti.
– Il tentativo di suicidio che è un suicidio mancato perché, nonostante fosse presente un’effettiva volontà suicidaria, esso non si è concluso con la morte per una serie di motivi solo in parte casuali. Vale la pena di ricordare che la differenza tra il suicidio e il tentativo di suicidio può, dal punto di vista psicologico, essere molto sfumata in quanto molti tentativi di suicidio restano tali e non diventano suicidi riusciti, vuoi per l’alea del caso – alea in cui giocano peraltro anche dinamiche sia del soggetto che dell’ambiente – vuoi per l’attuale grande diffusione e perfezionamento dei mezzi di rianimazione.
– Le velleità suicidarie che sono tentativi di suicidio appena abbozzati, come il taglio superficiale delle vene, l’assunzione di farmaci in qualità e quantità sicuramente non mortale, certi comportamenti autolesivi sempre sul piano fisico, etc… Tali condotte vengono spesso confuse con i tentativi di suicidio veri e propri ma possono essere anche sottovalutati e non considerati nel loro significato di segnali di pericolo, talora con confusione protettiva nei confronti di un vero e proprio suicidio o tentato suicidio.
– I tentativi di suicidio reiterati, che finiscono con il configurare delle condotte suicidarie croniche e che diventano, per certi aspetti “uno stile di vita”, stile che inizia spesso nell’adolescenza o post-adolescenza.
– I cosiddetti equivalenti suicidari, nella forma di incidenti gravi e ripetuti, esposizione frequente a rischi importanti, particolari condotte in cui la posta in gioco è la vita e nelle quali è sempre presente e determinante una sfida onnipotente; infine, l’assunzione di droghe pesanti in quantità e con modalità tali da comportare un rilevante e immediato rischio di morte (Senise, 1989).
L’idea di potersi o volersi suicidare è un’esperienza emotiva assai frequente, soprattutto in certe fasi della vita segnate da importanti crisi evolutive. Tale esperienza costituisce un elemento rappresentazionale ed affettivo probabilmente connaturato ad una larga quota di esseri umani ed è connesso alla capacità di accettare l’idea dell’ineluttabilità della propria futura morte. Tale capacità costituisce un momento evolutivo importante nel corso del processo adolescenziale in quanto segnala, da un lato, l’affrancamento dalle infantili fantasie di onnipotenza e di immortalità (e quindi l’accettazione dei limiti posti dalla realtà della vita, in primo luogo quelli temporali), ma costituisce anche, dall’altro lato, l’affermazione del proprio Sé in quanto sede unica delle proprie libertà decisionali ed una genuina e attiva accettazione della vita attraverso la rappresentazione mentale della possibilità del suo contrario (Pandolfi, 2000; Senise; 1989).
Il suicidio in adolescenza come evento processuale
Il tentativo di suicidio, pur nella sua assai differente fenomenologia e gravità, è sempre l’ultima fase e l’atto conclusivo e manifesto di un complesso insieme di processi, fantasie, desideri e vissuti tra loro differenti ed anche contraddittori, comunque esistenti e in azione già da tempo, sia pure con differenti livelli di consapevolezza. Cosicché quella che spesso viene definita come un’azione improvvisa, incomprensibile ed inconsulta, è tale solo in apparenza o, meglio, per quanto concerne la messa in atto; ma ha, invece, in quanto processo, una sua storia più o meno lunga e tortuosa i cui percorsi si celano nella soggettività dell’adolescente che tenta il suicidio.
Il tentato suicidio, dunque, non è mai un evento puntiforme nell’esistenza di una persona, ma un evento processuale con un “prima” e un “dopo”, determinato sia dalla realtà psichica interna, sia dalle vicende relazionali esterne della micro e macro società in cui l’adolescente vive (Pandolfi, 2000; Senise, 1989).
L’adolescente è di per sé vulnerabile sul piano psicologico, in particolare per quanto concerne l’integrazione dei vari aspetti del Sé, la regolazione dell’autostima, la tolleranza alla frustrazione, la capacità di mediare gli impulsi e di avere una realistica rappresentazione delle conseguenze delle proprie azioni. Non deve, dunque, stupire che l’adolescenza costituisca un periodo di minore resistenza di fronte ad eventi relazionali e sociali di per sé magari non gravi o, addirittura, banali. Tali eventi, infatti, assumono per alcuni di questi soggetti valenze e significati nettamente ed intollerabilmente traumatici, soprattutto se si vanno a sommare gli uni agli altri in un lasso di tempo troppo breve e/o in un ambiente che non ne facilita la corretta metabolizzazione emotiva. Questo tipo di considerazione spiega i non infrequenti errori di comprensione e di valutazione, cui seguono ovviamente errori nell’approccio terapeutico e nella profilassi delle recidive, di quei casi di tentato suicidio in adolescenza nei quali la causa sociale o relazionale più prossima o immediata, quale può essere un insuccesso scolastico o sentimentale, viene presa per la “causa”, unica e vera responsabile dell’evento, invece di essere considerata nel suo giusto valore di causa scatenante ultima, in quanto ha agito su di un soggetto la cui coesione e solidità psico-affettiva erano già in condizione di notevole, anche se misconosciuta, precarietà.
Queste considerazioni valgono per le condotte suicidarie di tutte le età, ma in modo del tutto particolare per quelle che si verificano in età adolescenziale. E’ probabile che questi errori di valutazione siano anche determinati dall’inconsapevole desiderio dell’ambiente, soprattutto familiare, di restare ad un livello di spiegazione superficiale che esima dal prendere atto di condizioni di problematicità, sofferenza e difficoltà personali e relazionali fino ad allora presenti ma ignorate. Se questo tipo di reazione e di condotta è comprensibile, anche se certamente negativa, da parte dell’ambiente familiare, non lo è per quanto concerne le figure professionali che a qualsiasi titolo sono chiamate ad occuparsi del suicidio in adolescenza (Pandolfi, 2000; Senise, 1989).
Le vulnerabilità psicologiche dell’adolescente
Abbiamo parlato della generale vulnerabilità psicologica dell’adolescente la quale, quando supera certi livelli, lo espone tra le altre forme di psicopatologia anche al rischio suicidario. Le tre caratteristiche dell’adolescente che meritano un’attenzione particolare sono:
1- La difficoltà per certi adolescenti, e per taluni l’impossibilità, di tollerare i sentimenti di solitudine e di “separatedness” che accompagnano il processo di separazione dalle figure parentali e di individuazione della propria nuova identità.
Tale processo, considerato l’asse portante dell’iter adolescenziale, è sempre problematico ma per alcuni soggetti si rivela particolarmente ostico e doloroso in quanto è prevalentemente impregnato dal sentimento di perdita desolante dell’identità infantile e dell’appoggio delle figure significative del passato, senza che tale vissuto sia sufficientemente controbilanciato dal sentimento di acquisizione della propria nuova identità e libertà, delle proprie personali capacità e responsabilità. La depressione che accompagna il processo di sviluppo adolescenziale aumenta in certi casi a dismisura, soprattutto per quanto concerne il sentimento di scarsa stima di Sé, il vissuto di inadeguatezza ai nuovi compiti, la sensazione di essere fatalmente perdente rispetto agli altri, adulti e coetanei; relativamente a questi ultimi l’adolescente potenziale suicida ha spesso la sensazione di essere rimasto irrimediabilmente indietro. Si trova così isolato in un mondo vissuto come inospitale, estraneo o addirittura minaccioso, impossibilitato a tornare al proprio passato ed incapace di approdare ad un futuro nel quale si sente, per motivi interni ed esterni, respinto; si sente incapace, soprattutto, di integrare le rappresentazioni di Sé nel passato, nel presente e nel futuro (Pandolfi, 2000; Senise, 1989).
2- Il fisiologico bisogno di sfidare, che è anche una difesa dalla depressività di cui si è detto sopra.
Si tratta di un bisogno accompagnato dalla tendenza ad agire impulsivamente senza considerare le conseguenze delle proprie azioni. Questa seconda importante caratteristica concorre ad esporre l’adolescente al rischio suicidario, come confermato anche da un interessante studio condotto da Witte e collaboratori su un campione di oltre 10.000 adolescenti. Lo studio ha confermato, infatti, che un adolescente che si suicida è caratterizzato da elevati livelli di impulsività, sia che tale atto abbia evidenti caratteristiche di impulsività (il cosiddetto tentativo di suicidio “impulsivo”), sia che compia tale gesto dopo una lunga pianificazione e senza quelle caratteristiche che lo farebbero ritenere impulsivo, quali l’azione sotto forte stress e la mancanza di premeditazione (Migliarese et al., 2012; Pandolfi, 2000; Senise, 1989; Witte et al., 2007).
3- L’attacco distruttivo al proprio corpo, che è la terza caratteristica che ha un particolare rilievo nei tentativi di suicidio in adolescenza.
Il rapporto dell’adolescente con il proprio corpo è notoriamente problematico per una serie di motivi di cui i più significativi sembrano i seguenti: il corpo con le sue trasformazioni è per l’adolescente la prova più evidente dell’inevitabilità del cambiamento cui egli è soggetto; il corpo, inoltre, è la fonte di nuovi stimoli e di appetenze sessuali la cui intensità, imperiosità ed incontrollabilità erano fino ad allora sconosciute. Per questi motivi il proprio corpo è spesso vissuto dall’adolescente a tratti come un corpo estraneo, sconosciuto, incontrollabile, non veramente appartenente al proprio Sé psichico, nucleo fondante dell’identità. E’ noto, infatti, quanto spesso gli adolescenti provino preoccupazione per il proprio corpo, ma anche insoddisfazione e vergogna, sentimenti la cui drammaticità è spesso misconosciuta agli adulti. Nel suicidio, il corpo diventa contemporaneamente il nemico o la vergogna da eliminare, la vittima da sacrificare, l’impaccio di cui liberarsi e l’esecuzione della sentenza di morte (Pandolfi, 2000; Senise, 1989).
Nell’ambito della paradossale contraddittorietà di molte condotte suicidarie va in primo luogo considerato che queste, nonostante abbiano lo scopo di spezzare ogni legame del soggetto con l’ambiente, contengono anche delle profonde valenze relazionali. Il suicidio, atto solitario per eccellenza, è però sempre anche rivolto mentalmente a qualcuno in particolare o “agli altri” in generale. Può trattarsi di un messaggio di stampo aggressivo che contiene protesta, ribellione, vendetta, ricatto; può essere un grido di aiuto, un tentativo illusorio di riunirsi a una persona amata e perduta, un mezzo altrettanto illusorio per restare sempre nella mente di qualcuno, spesso come fonte di colpa e di rimpianto. Queste idee, questi scopi, sono per lo più compresenti e compenetrati tra loro ad un livello emotivo profondo, anche se ciascuno di essi può agire con differente intensità. Cosicché la pretesa di cogliere il motivo unico di un tentato suicidio è destinata a fallire perché non tiene conto della complessità ed ambiguità della natura umana, mentre pare più corretto parlare di una motivazione privilegiata rispetto alle altre.
Va inoltre aggiunto che, nonostante la condotta suicidaria sia caratterizzata da una grande distruttività, spesso chi tenta il suicidio lo fa perché rifiuta questa vita attuale che gli appare insoddisfacente in grado estremo, o addirittura intollerabile, ma non rigetta la vita in generale; anzi, più o meno consapevolmente, aspira e confida in una vita migliore o perfetta, esente da difficoltà, conflitti e perdite. Infatti, una fantasia molto importante nel promuovere il suicidio è quella per cui la morte così ottenuta non è volta tanto alla distruzione di se stessi, quanto alla speranza, se non alla certezza inconscia, di poter per questa via trovare o ritrovare una condizione di pace e di quiete durature e perfette. Accanto a questa fantasia vediamo però spesso in opera anche un altro desiderio altrettanto illusorio, e cioè che mediante la morte si realizzi un momento di magica onnipotenza e il trionfo di Sé sulle necessarie limitazioni della vita e della realtà. Relativamente vicina a queste fantasie vi è quella secondo cui la morte ottenuta con il suicidio ha lo scopo di preservare la parte migliore di Sé.
Un altro importante meccanismo presente in molti casi di suicidio è il bisogno di trasformare in azione attiva ciò che dovrà essere subìto passivamente, anche se in un futuro lontano, vale a dire la morte stessa.
Altra importante e complessa fantasia, che merita di essere citata in quanto presente in molti processi suicidari adolescenziali, è quella di essere comunque salvati dalla morte. Questa aspettativa magica ed onnipotente, frequente molto più di quanto non si pensi, è qualcosa di diverso dal suicidio come estremo grido di aiuto e mezzo per essere finalmente percepiti nella propria sofferenza, disperazione ed abbandono. Si tratta di un paradosso spesso testimoniato dal fatto che l’adolescente lancia segnali premonitori del suo intento, segnali utilizzati come mezzo comunicativo ma distruttivo per manifestare la propria sofferenza e il proprio dolore. Questi comportamenti presentano una valenza relazionale da non trascurare. E’ fondamentale che l’ambiente relazionale sia empatico e non sottovaluti e annulli, con il disconoscimento e la negazione, il grido d’aiuto sotteso a tali messaggi, ma cerchi di decifrarne il senso e di comportarsi di conseguenza.
Come si vede è assai pericoloso sul piano clinico definire sbrigativamente certi suicidi come “dimostrativi”, definizione che comporta spesso una negazione banalizzante della condotta suicidaria, percepita solo nella sua dimensione falsa e ricattatoria. Basta riflettere sul fatto che se un adolescente deve ricorrere a questo tipo di dimostrazione per riuscire a comunicare la propria sofferenza/aggressività ciò già significa che non è in grado di utilizzare mezzi più evoluti e meno distruttivi (Pandolfi, 2000; Senise, 1989).
La prevenzione del suicidio in adolescenza
Da quanto si è detto relativamente al carattere processuale delle vicende che portano un adolescente a tentare il suicidio, si deduce che è possibile effettuare una certa prevenzione del medesimo.
Una prima misura è sicuramente quella di prendere sul serio i propositi suicidari espressi dagli adolescenti invece che annullarli con il disconoscimento della sofferenza e disperazione che li sottende, ovvero mediante la banalizzazione o, peggio ancora, la ridicolizzazione. Queste reazioni sono per lo più determinate dal sentimento di impotenza e di inadeguatezza, di rabbia e di paura che gli adulti provano di fronte ad un adolescente che tenta il suicidio. Ma, come si può comprendere, si tratta di una reazione del tutto disfunzionale. Prendere sul serio il proposito suicidario di un adolescente, però, non significa nemmeno drammatizzare la situazione oltre misura cadendo in una condizione di continuo allarme o permettendo che si instauri un clima più o meno ricattatorio. Quanto più un adolescente sente di essere capito e rispettato nella sua difficoltà e nel suo proposito suicidario, quanto più sente di poter parlare sul serio di sé e della sua sensazione di trovarsi in un vicolo cieco, tanto più è possibile che non metta in atto il suo proposito ed accetti di essere aiutato a cercare e trovare in sé e nell’ambiente risorse e soluzioni alternative e soprattutto non distruttive.
Una seconda misura, in termini di prevenzione del suicidio e tentato suicidio in adolescenza, è quella di rendersi conto di quando e quanto un adolescente cominci a sentirsi e a rendersi via via sempre più isolato dai propri coetanei e dall’ambiente, ad abbandonare in modo progressivo interessi, progetti e speranze, ad avere di sé un’immagine insoddisfacente e deteriorata, a subire frustrazioni, perdite ed insuccessi senza essere in grado di reagirvi attivamente (Pandolfi, 2000; Senise, 1989).
La terapia dopo il tentativo il suicidio in adolescenza
Per quanto riguarda il trattamento dell’adolescente che ha tentato il suicidio, è necessario sottolineare che le cure mediche devono essere considerate solo il primo passo. Non basta, infatti, far tornare a vivere una persona che ha cercato di morire, ma è necessario metterla in condizione di desiderare di vivere anziché di morire. Diventa pertanto essenziale effettuare una serie di colloqui psicologici con l’adolescente, i quali devono essere condotti con una tecnica idonea e soprattutto con una posizione emotiva da parte del professionista che escluda, da un lato, attitudini pietistiche e consolatorio-rassicuranti e, dall’altro, atteggiamenti recriminatori ed accusatori. E’ sempre auspicabile poter parlare con l’adolescente in modo aperto e diretto del suo atto, non colludendo con i frequenti tentativi di negazione e di banalizzazione del significato dell’evento. Anche qui, prendere sul serio non significa drammatizzare ma, piuttosto, aiutare il giovane che ha cercato di morire a rendersi conto dei desideri più o meno inconsapevoli che lo hanno spinto a compiere il tentativo e dell’illusorietà di tali desideri, diventando capace di quell’esame di realtà che gli ha fatto clamorosamente difetto nell’esecuzione del suo tentativo. Si tratta, inoltre, di metterlo in condizione di cercare mezzi meno fallimentari per far fronte alle sue difficoltà interne ed esterne e trovare possibilità comunicative e relazionali con se stesso e con l’ambiente più sane ed efficaci in termini di attivo ed intelligente adattamento alla vita (Senise, 1989).
La terapia cognitivo-comportamentale (CBT) presenta alcune caratteristiche che la rendono particolarmente utile nel trattamento degli adolescenti che hanno tentato il suicidio. In primo luogo, la parte cognitiva della CBT comprende molte tecniche per affrontare le cognizioni negative come la hopelessness, che si riferisce alla convinzione dell’individuo di non avere speranza e di non poterne avere in futuro: gli eventi sono assolutamente negativi ed egli non è in grado di fare nulla per modificare la situazione e per risolvere i propri problemi. In secondo luogo, la componente comportamentale della CBT comprende alcune tecniche che possono essere impiegate per aiutare l’adolescente a superare le problematiche sociali e personali che di solito si associano all’autolesionismo in questi gruppi di età. Tecniche quali il problem solving interpersonale e la facilitazione della comunicazione sono parte integrante di molti programmi CBT. In terzo luogo, le terapie cognitivo-comportamentali costituiscono un trattamento efficace per quei disturbi psichiatrici che sono strettamente associati con l’autolesionismo deliberato, quali la depressione.
Tuttavia, nonostante la terapia cognitivo-comportamentale rappresenti una forma molto promettente di intervento, sono necessari trial randomizzati più ampi per stabilire se questo intervento riduca effettivamente il rischio di recidive (Harrington et al., 2002; Oliverio Ferraris et al., 2009; Rainone et al., 2004).