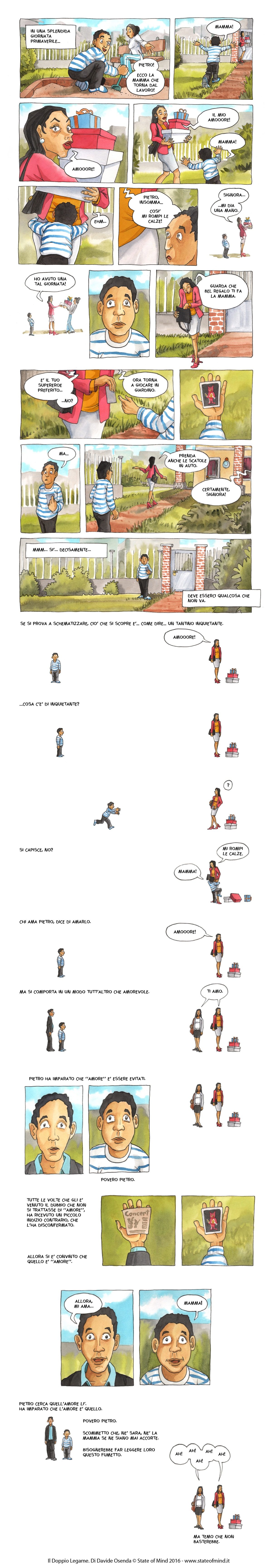L’idealizzazione amorosa in Les amours imaginaires (2010) – Cinema & Psicologia
Diretto da Xavier Dolan Les amours imaginaires (2010) è un film sull’infatuazione, sul concetto di amore spesso fuorviato e idealizzato che nel legame tra i tre protagonisti, Francis, Marie e Nicolas, si evidenzia nella fretta ad interpretare erroneamente i segnali ambigui, a perdersi nella fantasia e, infine, a sottostimare gli altri rapporti, potenzialmente intimi e soddisfacenti.
Les amours imaginaires: la trama
Marie e Francis sono amici stretti, entrambi infatuati del bellissimo, ambiguo e sconosciuto Nicolas, che si diverte a tirare il sasso e nascondere la mano, a provocare per poi ritrarsi: non si capisce bene, in sostanza, dove si posi il suo interesse, ammesso che ci sia un reale interesse per qualcuno di loro. In questa confusione, i due giovani mal interpretano i comportamenti, si autoconvincono di essere i prediletti e si ritrovano, inevitabilmente, a scontrarsi per ottenere le attenzioni del loro amato.
Le inquadrature riavvicinate, la scelta azzeccata della colonna sonora, e le scene a rallentatore rivelano le emozioni dei personaggi che nelle varie fasi del film attraversano diverse tappe. La percezione di Nicolas cambia a seconda di queste; nelle prime battute è un ragazzo bellissimo, solare e popolare, appena trasferito a Montreal, ma già noto alla cerchia di amici, poi diventa l’amico stretto, coinvolgente e spiritoso, successivamente si trasforma nell’oggetto desiderato che mantiene l’aplomb, anche quando il gioco si fa duro, per poi rivestire, alla fine, il ruolo di raggiratore respinto dai protagonisti, che da acerrimi nemici, litigatori seriali, ritornano ad essere buoni amici e migliori alleati.
In effetti Nicolas non si definisce mai; qualche volta adotta atteggiamenti espliciti, con chiari avvicinamenti fisici e frasi d’impatto, ma quando è il momento di accogliere o respingere le chiare avances di entrambi, resta neutrale. Il silenzio e il ritiro diventano le strategie predilette quando Francis e Marie lo mettono con le spalle al muro, ammettendo i sentimenti per lui. Nicolas sembra adottare di proposito un atteggiamento vago e sfuggente, probabilmente per mantenere viva l’attenzione su di lui; infatti, nell’indefinitezza, Francis e Marie sono tenuti sulle spine, continuano ad affrontare l’ambivalenza tra allontanamenti e avvicinamenti, mentre il tempo passa e la possibilità di coltivare un rapporto basato su una reale conoscenza si affievolisce.
L’ARTICOLO CONTINUA DOPO IL TRAILER:
https://www.youtube.com/watch?v=OAGZz7Jgr8I
Non mancano gli incontri con altri individui che si rivelano, tuttavia, partner occasionali continuamente respinti: l’ossessione per Nicolas prende così il sopravvento, impedendo di analizzare la situazione con lucidità e di investire affettivamente su altre figure. Eppure Nicolas, implicitamente o meno, rivela in qualche modo le sue intenzioni; non dichiara apertamente e sinceramente i pensieri, le emozioni e le decisioni, in più, corteggia l’amica di Francis e un’altra ragazza alla sua festa di compleanno. Nel complesso non si sbilancia mai, mantiene una posizione immutabile che lascia la sensazione di indifferenza e neutralità. Con la strategia del “mi definisco ma non troppo” accresce il desiderio di Marie e Francis che credono di essere perdutamente innamorate e, in realtà, non conoscono nemmeno la vera personalità del loro oggetto del desiderio, bensì una strategia relazionale ricercata.
Sullo sfondo, le narrazioni sentimentali di altri personaggi, sconosciuti che raccontano le avventure amorose basate sull’idealizzazione del partner: il punto di ritorno è l’attaccamento morboso, la dipendenza patologica verso l’idea della persona, e non la persona in sé, che resta vivida anche quando il rapporto si conclude e lascia la scia dell’amaro in bocca. Lo stesso gioco delle parti, dove uno inganna e l’altro si lascia ingannare, diventa un elemento centrale insieme alla tendenza a ritenere significative e lancinanti le relazioni nelle quali l’altro mantiene l’ambiguità e il mistero, che, se svelati, spengono la scintilla e l’interesse svanisce del tutto.
Les amours imaginaires: i temi psicologici trattati
All’origine di questi fenomeni si trovano timori di vario genere, relativi all’abbandono e alle possibili delusioni; in altre parole chi resta vago può agire in tal senso per paura di deludere mostrando il vero carattere, mentre chi s’infatua di un soggetto “misterioso”, le cui intenzioni non sembrano chiare, senza riuscire a staccarsi, può nascondere la paura di costruire un legame intimo, di coinvolgersi in una conoscenza approfondita in cui si è portati a definirsi in qualità di partner. Per capire meglio le dinamiche è opportuno osservare i meccanismi di mantenimento e rottura della relazione; Nicolas sparisce interrompendo la frequentazione quando è messo alle strette, e quindi nel momento in cui è chiamato, implicitamente, a smettere di giocare e a prendere una decisione definitiva sul tipo di rapporto da instaurare con entrambi. Marie e Francis, al contrario, restano delusi dalla rivelazione, seppur implicita dell’amico: ritirandosi e ignorando le dichiarazioni aperte degli amici, Nicolas ha lasciato intendere, ancora una volta subdolamente, il rifiuto, svelando inconsciamente, il reale interesse: la disputa che divide gli amici intimi e nutre le attenzioni su di sé. La posizione di Nicolas sancisce la fine dell’ambivalenza e l’inizio della rassegnazione e del disinteresse di Marie e Francis. Il mistero finisce, ma gli amici non riflettono sulle dinamiche avvenute e quando compare un altro personaggio, simile a Nicolas, bellissimo e affascinante ma anche molto ambiguo, i protagonisti ne sono attratti nuovamente come calamite. Il regista termina il film con una scena emblematica che lascia intendere l’inevitabile circolo vizioso amoroso dei protagonisti, incapaci di amare, bensì eterne vittime di amori immaginari, irreali e fittizi, che non conosceranno mai, né approfondiranno, ma che nutriranno le fantasie dell’amore perfetto, privo di imperfezioni, platonico e irraggiungibile.
Les amours imaginaires: conclusioni
Les amours imaginaires pone l’inevitabile riflessione sul significato dell’amore immaginario, frutto dell’infatuazione nel quale l’oggetto del desiderio non è conosciuto e apprezzato in quanto tale, ma ammirato per la sua ambivalenza. Da questa vicenda tragicomica si possono trarre alcuni interessanti spunti, come l’importanza di distinguere i segnali ambigui, spesso mal interpretati, da quelli chiari, l’interesse per la persona da quello per il tipo di relazione, e infine l’ossessione per l’apparenza dal desiderio di scoprire una conoscenza intima. Necessaria è la riflessione sulle dinamiche intrapsichiche che ostacolano un rapporto soddisfacente e approfondito al fine di interrompere il circolo vizioso degli innamoramenti fittizi, dove l’immaginazione si sostituisce alla realtà. Senza una sana autocritica e una buona riflessione sulle motivazioni inconsce che portano a prediligere un tipo di rapporto all’altro, i meccanismi tenderanno a ripetersi continuamente impedendo l’apprendimento dall’esperienza che agevola il raggiungimento del benessere individuale e di coppia.