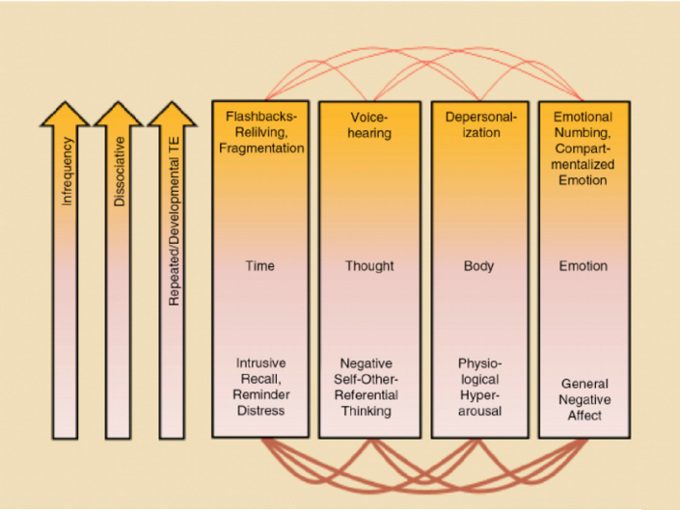Disprassia evolutiva: criteri clinici e principi di trattamento riabilitativo
La disprassia evolutiva rappresenta per la riabilitazione pediatrica un ambito emergente e di grande interesse: l’incapacità di compiere gesti, siano essi simbolici o di adeguato utilizzo degli oggetti, in assenza di deficit motori, confligge con un normale sviluppo delle funzioni cognitive così come di quelle adattive.
Daniela Voza – OPEN SCHOOL Psicoterapia Cognitiva e Ricerca
“…non solo i bambini ma anche gli esseri umani di tutte le età sono oltremodo felici e in grado di estrinsecare le loro capacità con il maggior vantaggio possibile quando sono sicuri che dietro di loro ci sono una o più persone che li possono aiutare in caso di difficoltà. La persona fidata fornisce una base sicura su cui appoggiarsi per potere agire” (J. Bowlby, 1973).
La disprassia evolutiva rappresenta per la riabilitazione pediatrica un ambito emergente e di grande interesse: l’incapacità di compiere gesti, siano essi simbolici o di adeguato utilizzo degli oggetti, in assenza di deficit motori di tipo piramidale, cerebellare o di disordini del movimento, confligge con un normale sviluppo delle funzioni cognitive così come di quelle adattive. Tuttavia, tra i disordini neuro evolutivi la disprassia è l’entità forse ancor oggi più disattesa o sottostimata o misconosciuta.
Anche in ambito clinico rappresenta una tematica controversa e dibattuta a partire addirittura dalla sua definizione: mentre nel mondo anglosassone continua ad essere ancora chiamata “disprassia evolutiva“, prevale oggi la dizione di “Disturbi della Coordinazione Motoria” in accordo con la scuola canadese (Progetto formativo, Don C. Gnocchi, 2015).
Definzione di Disprassia Evolutiva
La patologia che colpisce la prassia è l’Aprassia, intesa come assenza della funzione da perdita o da mancanza e si riferisce all’adulto, mentre in età evolutiva si preferisce il termine Disprassia, intesa come malfunzionamento, anomalia della funzione da disfunzione.
I primi lavori in ambito evolutivo sono quelli di Orton (1937), che identifica la “goffaggine” come uno dei più comuni disordini dello sviluppo; riconosce inoltre differenti tipologie nell’ambito dei disturbi motori e sottolinea che esistono diversi tipi di “disordini motori”.
Trent’anni più tardi Walton, Ellis e Court (1962) e Gubbay et al. (1965) descrivono dettagliatamente i bambini “goffi”, ovvero i cosiddetti clumsy children. I criteri usati per definire la diagnosi di questi bambini sono: la mancanza di destrezza, l’impaccio motorio, l’assenza di abilità, che coincidono clinicamente con la presenza di “varie forme di aprassia e di agnosia”; il criterio “per esclusione” prevede che tale disturbo debba essere attribuito all’aprassia e all’agnosia, dopo aver escluso deficit neurologici e neuropsicologici classici: l’esame neurologico deve risultare negativo, devono risultare nella norma l’energia dei movimenti, le funzioni sensoriali e l’intelligenza.
Lo sviluppo delle abilità prassiche coincide con la nascita dell’intenzione, intesa come capacità da parte di ogni individuo, già in epoca neonatale, di regolare i propri processi cognitivi per organizzare risposte adattive. La disprassia già molti anni fa è stata definita come disturbo dell’integrazione neurosensoriale, in particolare negli aspetti visivi e tattili, interpretabile in tal senso come possibile componente eziologica (Ayres, 1972, Dewey e Kaplan,1994; Dunn et al, 1986). I bambini risultano molto sensibili al tatto, alla luce, a rumori e spesso presentano difficoltà alimentari ovvero sono molto selettivi nel tipo di alimentazione. Si deve inoltre considerare la difficoltà a livello gestuale: gesti transitivi (uso finalizzato degli oggetti) ed intransitivi (gesti simbolici).
La Disprassia si può definire in generale come un disturbo dell’esecuzione di un qualsiasi gesto o azione volontaria, è la difficoltà a programmare, coordinare e controllare gli atti motori necessari a raggiungere uno scopo, da distinguere dal concetto di capacità motorie in senso stretto (Sabbadini, 2013).
I soggetti colpiti da questi disturbi hanno bisogno di pensare alla pianificazione dei movimenti che hanno difficoltà ad automatizzare. Le difficoltà gestuali sono spesso correlate a difficoltà nel separare ed utilizzare adeguatamente le dita delle mani. E’ inoltre presente nella maggioranza dei casi ipotonia degli arti superiori, che risulta particolarmente marcata a questo livello, rispetto all’ipotonia generalizzata degli arti inferiori.
I primi lavori sulla
disprassia evolutiva fanno riferimento ad una visione adulto – metrica che conduce a una definizione della stessa in termini di esclusione. Ma è proprio questa modalità di approccio al problema, che è stata utilizzata per l’età evolutiva fino ad un’epoca recente, che ha creato confusione e poca chiarezza rispetto al termine
disprassia, che va inteso come incapacità di eseguire atti motori finalizzati e intenzionali e che pertanto va distinto dalla goffaggine e dal disturbo del movimento.
L’esecuzione di un atto intenzionale presuppone l’integrità delle strutture che rendono possibile l’azione. Sabbadini (1994) individua due livelli di controllo: le funzioni di base o strutture processanti (percezione, azione, memoria), che consentono di acquisire le informazioni; e i processi di controllo, che organizzano le funzioni cognitive di base. In un bambino disprattico entrambe le tipologie di strutture sono compromesse; ne deriva un ritardo nell’acquisizione di funzioni e/o la presenza di strategie stereotipate e poco flessibili, che rendono difficile l’apprendimento di compiti nuovi.
Disprassia evolutiva ed Embodied cognition
La disprassia evolutiva assume così le caratteristiche di un disturbo multisistemico in cui si rileva la presenza di difficoltà di coordinazione motoria generale e fine, oltre a deficit percettivi, che si traducono in difficoltà nelle autonomie della vita quotidiana e nell’apprendimento, in accordo con il modello della embodied cognition (Thelen, 1995). Secondo l’embodied cognition lo sviluppo cognitivo dipende, infatti, dall’avere un corpo competente dal punto di vista motorio e percettivo, oltre che dalle esperienze che esso può compiere. La conoscenza deriva dalla possibilità di percepire gli stimoli e dall’agire in conseguenza degli stessi.
Nelle ricerche degli ultimi anni basate sulle teorie dell’embodied cognition (Thelen,1995; Iverson e Thelen, 1999; Thelen e Iverson, 2001) si ribadisce sempre più l’ipotesi che le esperienze ricavate dal corpo giocano un ruolo essenziale per lo sviluppo della mente, ovvero per lo sviluppo cognitivo. Secondo questa nuova prospettiva, quindi, rispetto all’emergere di nuovi apprendimenti, viene enfatizzato lo stretto legame percezione-azione-cognizione. La cognizione dipende dal fatto di avere un corpo “capace” in termini di funzioni percettive e motorie e soprattutto dal tipo di esperienze che tale corpo ha avuto possibilità di compiere (Iverson e Thelen, 1999).
In particolare va considerata la recettività sensoriale, i cinque sensi che, sin da subito, mettono l’individuo in relazione con il mondo circostante. La sensazione di poter utilizzare al meglio il proprio corpo, incide inoltre sugli aspetti emotivi e sul personale livello di autostima.
Lo sviluppo va dunque inteso come capacità di tenere insieme vari sistemi percettivi e motori, in grado di attivare quello che il cervello pensa, quello che l’ambiente offre come stimolo e quello che l’interazione tra l’organismo e l’ambiente richiede.
Esso è frutto della capacità di usare i vari sistemi con flessibilità, per l’esecuzione di differenti azioni, che sottendono sempre l’aggregazione di più funzioni e l’attivazione dell’attenzione condivisa.
Diagnosi della Disprassia Evolutiva
Nel DSM – IV – TR (APA, 2000) si parla di Disturbo di Sviluppo della Coordinazione. I criteri diagnostici indicati sono:
- A. Le prestazioni nelle attività quotidiane che richiedono coordinazione motoria sono sostanzialmente inferiori rispetto a quanto previsto in base all’età cronologica del soggetto e alla valutazione psicometrica della sua intelligenza. Questo può manifestarsi con un notevole ritardo nel raggiungimento delle tappe motorie fondamentali (per es., camminare, gattonare, star seduti), col far cadere gli oggetti, con goffaggine, con scadenti prestazioni sportive, o con calligrafia deficitaria.
- B. L’anomalia descritta al punto A interferisce in modo significativo con l’apprendimento scolastico o con le attività della vita quotidiana.
- C. L’anomalia non è dovuta ad una condizione medica generale (per es., paralisi cerebrale, emiplegia, o distrofia muscolare) e non soddisfa i criteri per un Disturbo Pervasivo dello Sviluppo.
- D. Se è presente Ritardo Mentale, le difficoltà motorie vanno al di là di quelle di solito associate con esso.
Nella definizione del DSM-IV-TR la disprassia viene inserita all’interno del Developmental Coordination Disorder (DCD) termine ormai usato e adottato a livello internazionale, che tradotto alla lettera in italiano diventa disordine o disturbo della coordinazione motoria (DCM) e che genera ancora delle ambiguità (Sabbadini, 2013). Nel termine coordinazione è implicito il concetto di programmazione e pianificazione e quindi può essere incluso il concetto di atto motorio finalizzato; questo concetto va oltre quello di movimento, ma manca in questo termine il concetto di azione, troppo spesso poco considerato.
Nella Classificazione dell’ICD – 10 (OMS, 1992) si parla invece di Disturbo evolutivo specifico della Funzione Motoria (F 82).
È abituale che l’impaccio motorio si associ ad una certa compromissione della prestazione nei compiti cognitivi visuospaziali. Il quadro è caratterizzato da:
- difficoltà di coordinazione, presenti sin dalle prime fasi di sviluppo, e non dipendenti da deficit neurosensoriali o neuromotori;
- entità della compromissione variabile e modificabile in funzione dell’età;
- ritardo (non costante) di acquisizione delle tappe di sviluppo neuromotorio (livelli più complessi), a volte accompagnato da ritardo di sviluppo del linguaggio (componenti articolatorie);
- goffaggine nei movimenti;
- ritardo nell’organizzazione del gioco e del disegno (tipo deficit costruttivo);
- presenza (non costante) di segni neurologici sfumati privi di sicuro significato localizzatorio;
- presenza (non costante) di difficoltà scolastiche e di problemi socio-emotivo-comportamentali.
Disprassia Evolutiva: eziologia del disturbo
Nella pratica clinica, attraverso un’accurata raccolta anamnestica, si riscontrano bambini disprattici, che possono avere genitori che hanno avuto gli stessi problemi (familiarità, fattori genetici).
Nel 50% dei casi si sono avuti problemi durante la gravidanza o il parto, quali anche lievi anossie perinatali, senza quindi segni conclamati di patologia, spesso non considerati né riportati nella cartella clinica (Dunn et al., 1986; Gubbay, 1985). La disprassia evolutiva è spesso presente nei bambini prematuri, ma anche postmaturi (41-42° settimana); in particolare la grossa incidenza riguarda gli immaturi a basso peso. In questi casi è spesso presente ipersensibilità o iposensibilità a stimoli sensoriali.
Indagini diagnostiche (TAC, RMf, PET) hanno in alcuni casi messo in evidenza una ecodensità periventricolare della sostanza bianca; si è inoltre riscontrata presenza di microlesioni e assottigliamento della parte posteriore del corpo calloso. Spesso non emerge nulla di significativo dalle RMf a cui vengono sottoposti bambini con disprassia evolutiva.
Nella clinica troviamo soggetti disprattici puri, senza segni neurologici evidenti o sintomi associati, inquadrabili nella disprassia evolutiva “specifica”. L’ipotesi è che nel bambino disprattico alcune aree del SNC non siano sufficientemente mature da permettergli di pianificare, programmare ed eseguire un’azione finalizzata. Sembrerebbe quindi che ci sia un’interruzione nella rete sinaptica e che il processo venga sfalsato per lentezza di trasmissione (Portwood, 1996).
E’ evidente nella clinica che il bambino disprattico, anche quando ha imparato ad eseguire determinate azioni, necessita di tempi più lunghi e manifesta lentezza esecutiva sia in attività della vita quotidiana che nelle attività scolastiche.
Nei casi di disprassia “pura” il livello cognitivo è nella norma e spesso il carico di frustrazione, rispetto alla consapevolezza del proprio deficit, è tale da portare questi soggetti verso disturbi comportamentali o della condotta. Importante quindi un tempestivo riconoscimento del problema e la presa in carico in terapia più precocemente possibile. Tali difficoltà fanno sì che il bambino sperimenti insuccessi e fallimenti che inevitabilmente hanno un impatto sulla vita scolastica, nel rapporto con i pari e sull’autostima e ciò può generare nel piccolo paziente stati di ansia e/o depressione.
Aree cerebrali coinvolte nella Disprassia Evolutiva
Il controllo del sistema motorio è deputato a sette aree cerebrali: le aree F1-2-3-4-5, parieto-dipendenti e le aree F6-7, pre-fronto-dipendenti. Nelle aree premotorie esistono singoli neuroni che controllano classi di azioni, come un microchip che si attiva per eseguire azioni multiple con un elevato livello di precisione e velocità (ad es., afferramento con una mano di un oggetto).
Nell’area F5, analoga all’area 44 di Brodman, ossia alla parte posteriore dell’area di Broca, si registra una scarica sia quando si inizia l’azione di afferramento, sia quando la si vede eseguire. La classe di neuroni F5 codifica l’intenzione dell’azione, e non solo la sua esecuzione. Da questa osservazione è nata la teoria dei
Neuroni Specchio: il semplice osservare un’azione attiva lo stesso schema motorio attivato da chi la sta eseguendo; l’osservazione di un’azione si traduce in un programma motorio equivalente nella mente dell’osservatore (Rizzolatti, Fogassi e Gallese, 2001).
Le informazioni che partono dal sistema visivo primario sono collegate alle aree premotorie: il sistema dorsale trasmette le informazioni del movimento; il sistema ventrale trasmette un’informazione semantica sul tipo di oggetto. L’analisi visiva è inoltre frazionata: vi è una prima analisi dell’oggetto, per stabilire se è familiare o no, per coglierne il colore e la forma; quindi c’è un’attivazione parietale e motoria in cui vengono codificate le diverse parti dell’oggetto in relazione alle azioni che posso compiere con quell’oggetto. Sono proprio i Neuroni Specchio che agevolano la costruzione di risposte motorie di fronte agli oggetti. E’ dimostrata una diversa attivazione neuronale a seconda dell’intenzione del movimento e lo stesso vale nel momento in cui si osserva l’azione svolta da un altro.
Tipologie di disprassia
Nella pratica clinica si riscontrano: la disprassia primaria o pura che non è associata ad altra patologia e che non presenta segni neurologici evidenti e la disprassia secondaria associata invece ad altre patologie e sindromi: PCI, Sindrome di Williams, Sindrome di Down, Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, ADD, ADHD ossia Disturbi dell’Attenzione con o senza Iperattività. La disprassia evolutiva comprende un’eterogenea classe di deficit all’interno dei disturbi dello sviluppo (Sabbadini, 1995; 2005; Sabbadini et al., 1993). Possiamo trovare un disturbo della coordinazione generale associato o no ad un deficit più specifico di una funzione prassica.
Accanto alla forma generalizzata di disprassia evolutiva vi sono disturbi più focali ad essa strettamente correlati, può infatti succedere che nello stesso bambino si riscontrino uno o più tipi di disprassia, di cui una tipologia è preminente rispetto ad altri segnali più sfumati. Possiamo evidenziare varie forme di disprassia evolutiva (Sabbadini, 1995) che possono essere così classificate:
- Disprassia generalizzata;
- Disprassia dello sguardo;
- Disprassia degli arti superiori;
- Disprassia del disegno;
- Disgrafia;
- Disprassia costruttiva;
- Disprassia verbale (con o senza disprassia orale).
La valutazione in casi di Disprassia Evolutiva
La valutazione viene fatta da un’equipe costituita da vari esperti: neuropsichiatra infantile, logopedisti, terapisti della neuropsicomotricità, terapisti occupazionali, che insieme collaborano per mettere a punto un profilo funzionale del soggetto ai fini sia della diagnosi che di un progetto di terapia mirato. Importante l’apporto del pediatra per un’ipotesi diagnostica ed un tempestivo invio a chi di competenza.
Attraverso colloqui con i genitori e con un’attenta osservazione il pediatra può monitorare l’evoluzione del bambino ed aiutare i genitori ad individuare eventuali segnali di disprassia evolutiva. Può essere utile dare ai genitori e poi rivedere insieme il questionario accluso al protocollo APCM (Sabbadini L. et al., 2005).
Anche dal questionario Mc Arthur si possono ricavare preziose informazioni soprattutto rispetto all’emergere del gesto e dell’espressione verbale.
La raccolta dei dati anamnestici ha un significato orientativo, ma diventa importante considerare la correlazione tra diversi elementi che, se isolati, non assumono significato di patologia, mentre possono costituire segnali di rischio qualora risultino combinati.
Le funzioni principali da indagare per consentire un inquadramento delle competenze implicate possono essere:
- Competenze vusuospaziali: assetto visuopercettivo, memoria visiva e visuospaziale, integrazione intersensoriale delle afferenze;
- Assetto visuocostruttivo: disegno spontaneo e su copia, costruzioni bi e tridimensionali;
- Prassie transitive e intransitive;
- Livello intellettivo (profilo);
- Memoria procedurale;
- Processi elaborativi e inferenze (assetto componenti frontali).
Tra i test costruiti per la valutazione dell’input visuopercettivo e l’integrazione visuomotoria il TVPS e il TPV rispondono a questo tipo di costrutto.
Il TVPS (Gardner, 1982) esplora componenti dell’ambito percettivo, chiedendo risposte su indicazione (non verbale) e con item che richiedono livelli di integrazione differente; a prove più strettamente percettive (riconoscimento visivo, figura/sfondo, closure visivo, costanza della forma) si affiancano due item di memoria (visiva e visuospaziale) e uno centrato sull’analisi delle relazioni visuospaziali.
Il TVP (Hammil, Pearson e Voress, 1993) è invece centrato sia sulle componenti percettive che su quelle visuomotorie: coordinazione occhio/mano, posizione nello spazio, copiatura/riproduzione, figura/sfondo, rapporti spaziali, completamento figura, velocità visuomotoria, costanza della forma, richiedendo quindi in maggior misura un atto motorio. Altri test sono utilizzati per valutare più precisamente l’orientamento spaziale (Benton, Varney e Hamsher 1992).
Tra le prove più utilizzate per valutare le capacità visuocostruttive basate su richieste di copia grafica da modello, a livello diverso di complessità, sono il VMI (Beery, 1997), il Santucci Bender, la figura di Rey.
La Valutazione della qualità grafica avviene attraverso prove di dettato e prove di copia: “illeggibile”, “quasi illeggibile”, “appena leggibile”, “leggibile”.
Gli stumenti attualmente in uso in Italia sono:
- BHK: scala sintetica per la valutazione della scrittura in età evolutiva (adattamento italiano dell’originale olandese di Hamstra-Bletz, De Bie e Den Brinker, a cura di Di Brina e Rossini, 2011)
- DGM-P: test per la valutazione delle difficoltà grafo-motorie e posturali della scrittura (Borean, Paciulli, Bravar e Zoia, 2012), consiste nel far copiare una frase prima nel modo migliore e poi nel modo più veloce (accuratezza, rapidità, leggibilità)
- BVSCO-2: batteria per la valutazione della scrittura e della competenza ortografica-2 (Tressoldi, Cornoldi e Re, 2013), stima le competenze del bambino nei tre aspetti della scrittura: grafismo, competenza ortografica e produzione del testo scritto.
La valutazione delle competenze intellettive generali è da prevedere in ogni valutazione neuropsicologica. L’analisi dei risultati ottenuti permette di individuare punti di forza che risulteranno fondamentali nell’ impostazione del trattamento riabilitativo e nell’individuazione delle strategie di compenso da facilitare.
Le componenti funzionali possono essere ad es. le strategie e i compensi utilizzati, il tipo di errore, la faticabilità e quindi la tenuta attentiva sul compito, la capacità o meno di sfruttare le facilitazioni e così via. La motivazione, la possibilità di mobilizzare risorse sia personali che ambientali, la disponibilità nei confronti delle proposte e, al contrario, la scarsa autostima, la reiterazione del fallimento e la tendenza ad eludere il compito perché frustrante e mai appagante, costituiscono alcune delle molte altre variabili che possono influenzare sia la valutazione che il percorso riabilitativo in ogni occasione.
Il trattamento riabilitativo della Disprassia Evolutiva
Alla luce dei dati relativi all’organizzazione cerebrale, laddove si individui un problema specifico è utile iniziare a porre le basi per un intervento almeno di facilitazione. Considerata la fascia di età, è necessaria una particolare attenzione alle modalità:
- Sinergie con altri interventi già in atto;
- Controlli periodici con indicazioni ai genitori nel corso di un follow-up mirato;
- Individuazione della tipologia degli stimoli che devono essere utilizzati (distanze, dimensioni, colore, multi o monomodalità, numerosità, ecc.) nelle differenti proposte al fine di consentire una più razionale pianificazione degli obiettivi. E’ necessario l’uso di materiale vario, gradito al bambino, e di situazioni piacevoli come facilitazione per il processo individuato;
- Attenzione alla modalità di presentazione degli stimoli individuati.
Tra gli obiettivi principali di un’attività svolta in età prescolare possono essere esemplificati:
- Facilitazione di inseguimento e fissazione: oggetti “interessanti” che devono essere raggiungibili dal bambino dopo l’attività di inseguimento visivo;
- Localizzazione nello spazio: attività di ricerca sia nello spazio prossimo che in quello più lontano, il gioco del “dov’è” spesso si può unire a quello del “cosa è”;
- Facilitazioni per le condotte anticipatorie: consentono l’attivazione di strategie flessibili e adattive;
- Indicazioni e facilitazioni per assetto posturale, presa e manipolazione.
Nella fascia di età successiva, diventa possibile perseguire obiettivi specifici, con differenziazione in funzione della patologia di base e del profilo neuropsicologico.
Gli obiettivi del trattamento dipenderanno strettamente da quanto individuato nella valutazione. A titolo esemplificativo:
- Miglioramento e funzionalizzazione dell’esplorazione visiva;
- Facilitazioni per l’integrazione spaziale degli stimoli;
- Integrazione intersensoriale delle afferenze: individuazione di strategie di compenso;
- Facilitazione per l’organizzazione prassica: consolidamento di procedure e guida alla sequenzializzazione delle attività; miglioramento delle capacità di programmazione; attivazione di processi di verifica sull’operato e di strategie di compenso; facilitazione all’utilizzazione del modello; ampliamento dell’autonomia nell’operatività; uso del compenso/guida verbale;
- Individuazione, impostazione e avvio all’utilizzazione di ausili (informatici e non) che facilitano ma non sostituiscono la fase di programmazione delle attività.
Conclusioni
La riabilitazione è per definizione un evento limitato nel tempo del bambino, e la possibilità di ottenere risultati significativi è legata all’effetto eco, ovvero alla possibilità che nei diversi contesti esistenziali vengano adottate in modo sinergico strategie facilitanti. Pertanto fa strettamente parte del progetto riabilitativo la modalità di raccordo e di interfaccia con i vari contesti esistenziali (famiglia, scuola e ogni altro contesto significativo).
L’obiettivo finale di ogni intervento terapeutico può essere individuato nel miglioramento dello stato di benessere del piccolo paziente, consentendo di estrinsecare le proprie potenzialità e rimuovendo, se possibile, i fattori sfavorevoli o, in alternativa, riducendone ai minimi termini l’impatto.
L’acquisizione di autonomie operative consentirà a ciascun bambino di percorrere la sua strada evolutiva, facendo i conti con l’esistenza di limiti e vincoli, ma avendo appreso che l’esistenza di ostacoli su un percorso non impedisce, di per sé, di raggiungere la meta.









 Sulla stessa falsariga ha proseguito Giuseppe Nicolò, nella sua doppia veste di psicoterapeuta privato presso il III Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma che di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma 5 e Direttore dell’SPDC Colleferro. Giuseppe ha offerto il suo punto di vista unico sulle diverse caratteristiche che assume l’applicazione della psicoterapia cognitiva nel servizio pubblico e nel privato. Giuseppe ha particolarmente insistito sulla necessità di attenersi a linee guide che si rifacciano a prove di fatto. A differenza di Riccardo, ha maggiormente sottolineato la necessità di linee guida realistiche piuttosto che di veri e propri protocolli, strumenti al momento troppo complessi da eseguire in ambiente pubblico. Tuttavia ha anche sottolineato la necessità di avvicinarsi il più possibile a pratiche cliniche supportate da prove di fatto.
Sulla stessa falsariga ha proseguito Giuseppe Nicolò, nella sua doppia veste di psicoterapeuta privato presso il III Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma che di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma 5 e Direttore dell’SPDC Colleferro. Giuseppe ha offerto il suo punto di vista unico sulle diverse caratteristiche che assume l’applicazione della psicoterapia cognitiva nel servizio pubblico e nel privato. Giuseppe ha particolarmente insistito sulla necessità di attenersi a linee guide che si rifacciano a prove di fatto. A differenza di Riccardo, ha maggiormente sottolineato la necessità di linee guida realistiche piuttosto che di veri e propri protocolli, strumenti al momento troppo complessi da eseguire in ambiente pubblico. Tuttavia ha anche sottolineato la necessità di avvicinarsi il più possibile a pratiche cliniche supportate da prove di fatto.