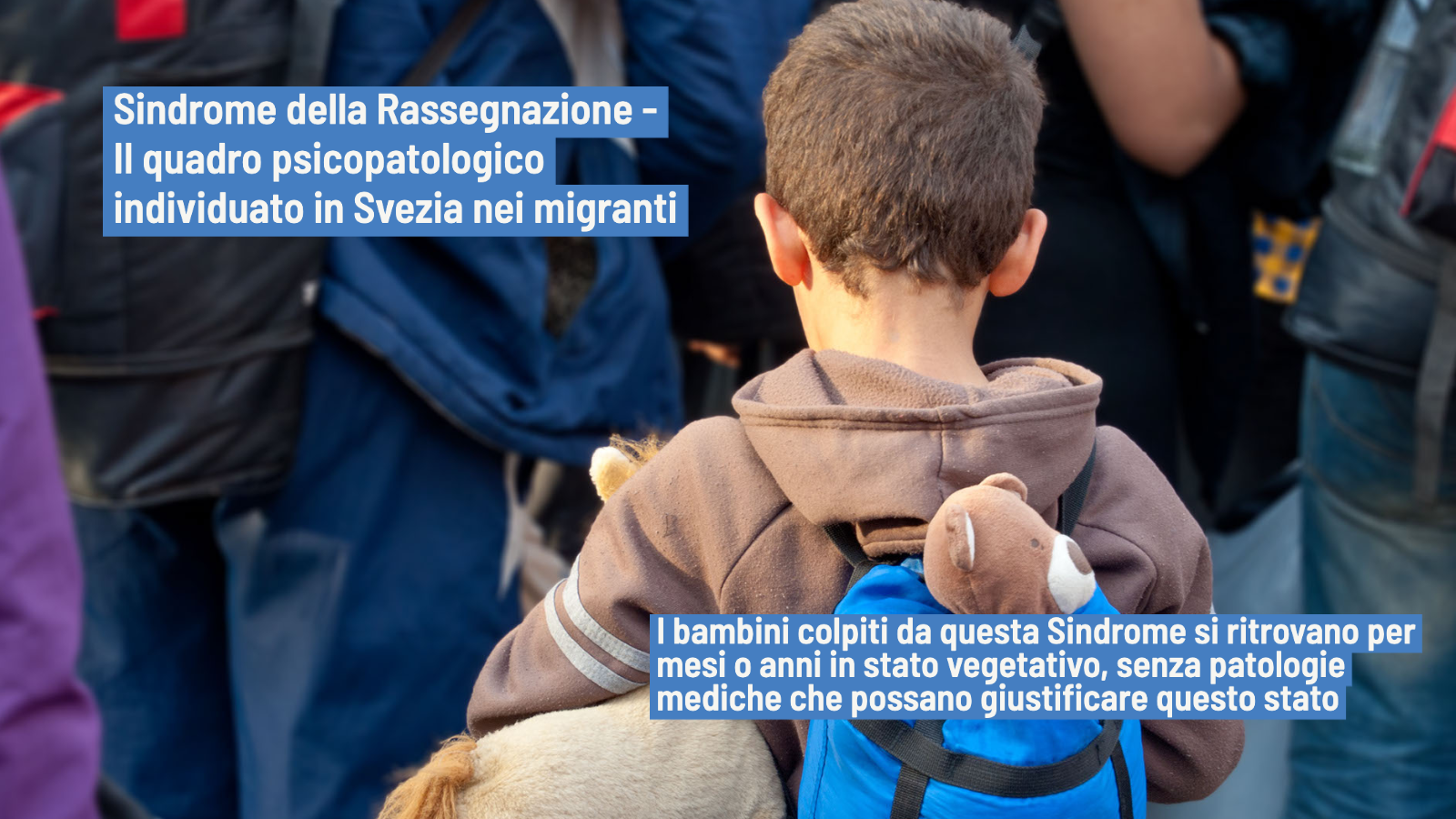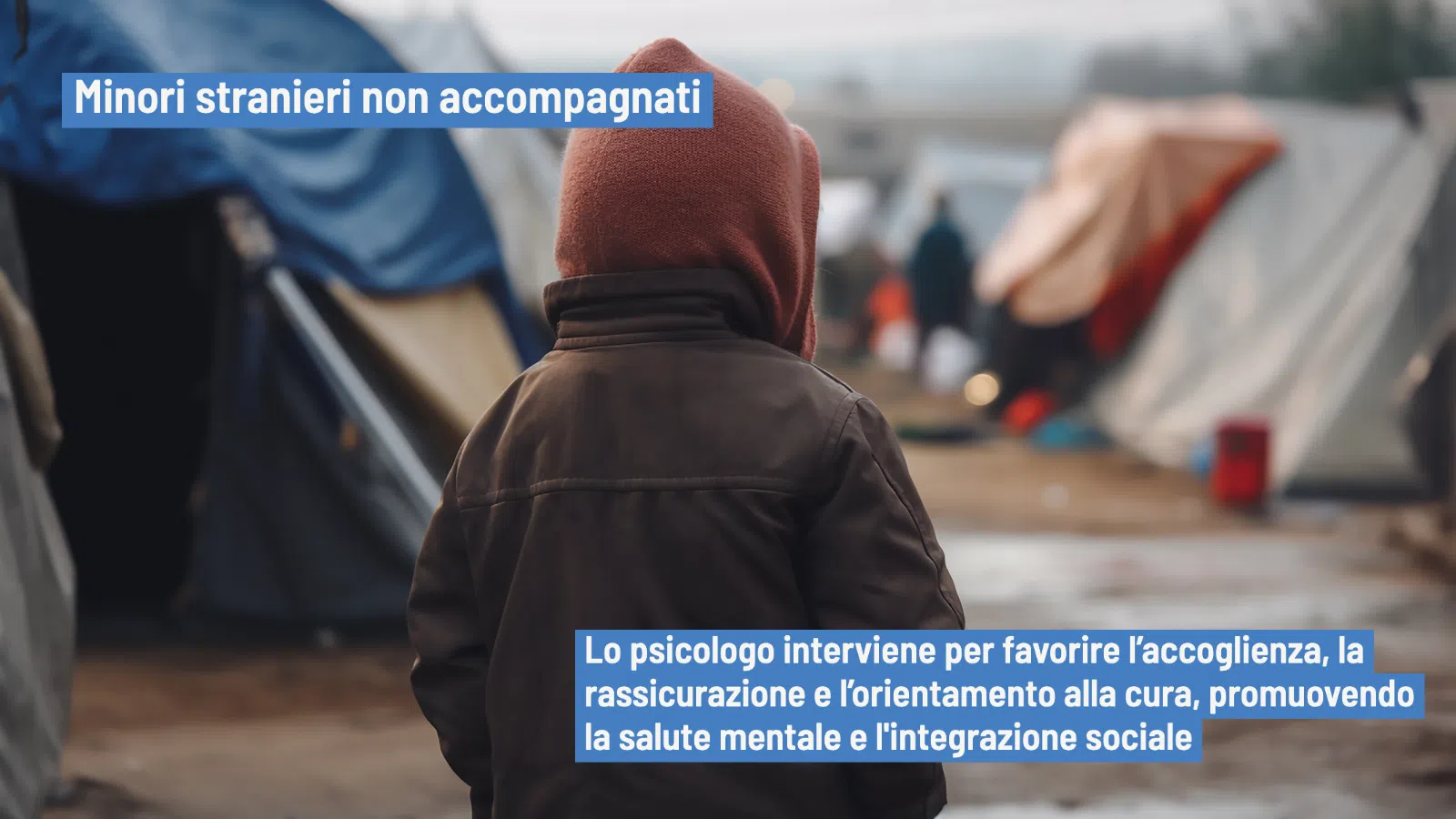È disponibile su Netflix il documentario “Sopraffatti dalla vita” che mostra un particolare quadro psicopatologico che ha portato gli studiosi a identificare una possibile nuova sindrome, detta Sindrome della Rassegnazione, in merito alla quale gli interrogativi e i dubbi non stentano a emergere. La visione del documentario mi ha spinto ad approfondire l’argomento attraverso la lettura di articoli scientifici, alla ricerca dei primi dati e delle prime ipotesi in merito a tale Sindrome.
Cos’è la Sindrome della Rassegnazione?
La Sindrome della Rassegnazione indicherebbe un disturbo di lunga durata che colpisce prevalentemente bambini e adolescenti che hanno vissuto un estenuante e faticoso processo di migrazione. L’evento scatenante infatti, sembrerebbe essere la risposta negativa alla richiesta d’asilo avanzata dalla famiglia del minore. Ma c’è di più: il fenomeno sembra verificarsi solo tra i figli di rifugiati in Svezia.
Come si manifesta la Sindrome della Rassegnazione?
I bambini che soffrono di Sindrome della Rassegnazione si ritrovano per mesi, se non per anni, in uno stato vegetativo senza che vi siano patologie mediche che possano giustificare questo stato.
I sintomi tipici evolvono in questo modo: l’ansia – spesso il primo sintomo che predice gli altri – e i sintomi depressivi, in particolare la letargia (grave stanchezza), progrediscono nello stupor (una condizione di mancata reattività dell’individuo) fino al raggiungimento di uno stato vegetativo del bambino e alla completa assenza di qualsiasi risposta agli stimoli esterni, compresi quelli che provocano dolore.
I pazienti possono essere ricoverati già dopo pochi giorni caratterizzati da rapido deterioramento e stupor. In altre occasioni invece vi è una presentazione più graduale di ansia, disturbi del sonno, ritiro sociale e altri sintomi, successivamente accompagnati da mutismo, incapacità di partecipare ad attività ludiche e scolastiche, incapacità di comunicare del tutto e, infine, di muoversi e rispondere agli stimoli, lasciando il paziente in posizione supina apparentemente incosciente e generalmente con gli occhi chiusi. In questa fase, si ricorre all’alimentazione mediante sondino.
La remissione avviene dopo mesi o anni in cui il bambino vive in questo stato vegetativo, con il ritorno graduale al recupero delle funzioni e dell’autonomia pre-sindrome. Il recupero si pensa sia legato al ripristino della speranza da parte della famiglia di ottenere l’asilo politico.
Sindrome della Rassegnazione: alcuni dati
Dal 1 gennaio 2003 al 31 aprile 2005, sono stati segnalati 424 casi di Sindrome della Rassegnazione (Hessle e Ahmadi, 2006) e delle 6547 domande di asilo presentate per bambini (0-17 anni) in Svezia nel 2004 (Von Folsach e Montgomery, 2006), nel 2,8 % dei casi si è manifestata tale Sindrome. Nessun caso è segnalato da altri paesi, il fenomeno sembra verificarsi esclusivamente in Svezia.
Le ultime stime contano 414 individui (2014–2019) (Socialstyrelsen, 2017). Tra i bambini e gli adolescenti richiedenti asilo in cura psichiatrica in Svezia nel 2014, il 5,1% soffriva della Sindrome della Rassegnazione (Fagerström, 2020).
Le diverse centinaia di casi segnalati esclusivamente in Svezia negli ultimi dieci anni, hanno spinto il Consiglio Nazionale Svedese per la Salute e il Benessere a riconoscere la diagnosi di Sindrome della Rassegnazione (decisione non pienamente condivisa da altri medici e studiosi che vedono la Sindrome della Rassegnazione attribuibile ad altre diagnosi quali disturbo da stress post-traumatico, depressione grave con catatonia o disturbo di conversione / dissociazione).
Davvero la Sindrome della Rassegnazione si manifesta solo in Svezia?
Descrizioni di disturbi simili alla Sindrome della Rassegnazione si possono trovare in letteratura, pertanto alcuni autori sostengono che non si tratti di una “nuova” condizione.
Numerosi fenomeni simili alla Sindrome della Rassegnazione sono stati segnalati da medici e antropologi in altri contesti, culture e periodi di tempo, suggerendo un meccanismo psicosomatico comune (Kihlbom, 2013). Morti acute o più graduali conseguenti a una minaccia di morte reale o immaginaria sono note nelle culture della maggior parte dei continenti (Lester, 2009).
Sono state descritte “epidemie” di morte in situazioni di guerra e prigionia, situazioni in cui non resta alcuna speranza (Kihlbom, 2013). Il termine del campo di concentramento “muselmann” denotava coloro che, privi di ogni speranza, esibivano un comportamento di rassegnazione (Kertész, 1998) e per settimane vivevano senza nutrirsi in uno stato di “autoipnosi arcaica” (Kihlbom, 2013).
Sono stati osservati fenomeni simili anche nelle ragazze Amish che mostravano una sintomatologia del disturbo di conversione molto simile alla Sindrome della Rassegnazione (Thomas,2017)
Tuttavia, oggigiorno spicca l’ampiezza del fenomeno e la sua distribuzione geografica.
Sindrome della Rassegnazione: possibili spiegazioni
La natura e la prevalenza della condizione sono state oggetto di un intenso dibattito pubblico. Sono stati tirati in causa anche fenomeni quali il malingering o la sindrome di Munchausen per procura, ipotesi etichettate però come xenofobe. Altre posizioni a riguardo hanno invece suggerito che sia il processo migratorio, presumibilmente imprevedibile e lungo, a creare una condizione di notevole stress e a traumatizzare i bambini, il cui corpo infine “si rassegna” nello stupor.
Un’indagine ufficiale (Hessle e Ahmadi, 2006) e un comitato di esperti (Rydelius, 2006) hanno proposto modelli esplicativi multifattoriali che coinvolgono vulnerabilità individuale, traumatizzazione, migrazione, modelli culturalmente condizionati e influenza genitoriale.
Tra le spiegazioni avanzate troviamo:
- Eventi stressanti: una risposta continua allo stress può essere, se non la spiegazione, almeno un fattore che contribuisce all’insorgenza della patologia.
- Spiegazioni Psicodinamiche: secondo queste teorie, le madri gravemente traumatizzate proiettano sui figli il loro bisogno di consolazione. La madre crea e mantiene inconsciamente una realtà alternativa in cui trova un suo significato prendendosi cura di un bambino immaginato morente che a sua volta, inconsciamente e influenzato dalla madre, continuerà a manifestare il disturbo.
- Isteria di massa e suggestione: secondo le teorie di Shorter (1992), il contesto culturale – in particolare i paradigmi medici, le aspettative familiari e i ruoli sociali – suggerisce un pool di sintomi “legittimi” e ad essi si associano determinate malattie organiche per le quali il paziente non può essere biasimato. Non a caso, il picco stimato nei casi di Sindrome della Rassegnazione è stato accompagnato da notevole attenzione da parte dei media e da una massiccia divulgazione.
- Il modello della codifica predittiva: tale ipotesi suggerisce che il cervello costruisce dei modelli (priors) del mondo che agiscono come aspettative del mondo esterno e interno. Quando un input esterno raggiunge il cervello e non trova corrispondenza in uno di questi modelli, si produrrà un segnale di errore. Nella Sindrome della Rassegnazione, quindi, abbiamo degli input che non trovano corrispondenza nei modelli dell’individuo e, nel tentativo di ridurre gli errori, si produrranno una serie di effetti fisiologici, comportamentali e percettivi, anche a discapito degli stati che garantiscono la sopravvivenza. In questo modo l’individuo si forma un’autorappresentazione inconsapevole da trasmettere all’esterno che potrebbe ridurre al minimo l’errore: dopo ciò che ho passato, dovrei ricevere aiuto (priors) > non lo ricevo > errore! > tutti i sistemi si mobilitano per ridurre l’errore, a scapito della sopravvivenza > sono nuovamente nella condizione di ricevere aiuto > ricevo aiuto (es. la mia famiglia ottiene l’asilo politico) > si riduce l’errore > sto meglio e inizio a guarire. L’ipotesi della codifica predittiva risulta più complicata ma spiegherebbe meglio l’incidenza di fattori culturali, tuttavia – in attesa di ulteriori delucidazioni – non si possono escludere combinazioni di più fattori e un mix di spiegazioni.
Trattamento
L’iter medico a cui sono sottoposti i bambini con quadro patologico sospetto include un iniziale screening tossicologico e un’intervista anamnestica tramite interprete. La risonanza magnetica è consigliata (Rydelius, 2006), tuttavia, non sempre viene eseguita.
Una volta che il quadro si è stabilizzato e che viene scartata l’ipotesi di una malattia somatica e quando il genitore si sente a suo agio nell’alimentare il figlio tramite sondino, il paziente viene dimesso e la parte successiva del trattamento è effettuata in ambiente domiciliare con regolari visite ambulatoriali alla clinica. A parte l’alimentazione mediante sonda, di sostegno vitale, il trattamento mira a promuovere e mantenere un ambiente familiare sicuro e pieno di speranza.
Accanto all’assistenza fornita dalla famiglia, gli infermieri, gli psicologi, i fisioterapisti e i terapisti occupazionali sono responsabili dell’assistenza quotidiana. Un pediatra e uno neuropsichiatra infantile sono coinvolti nelle visite domiciliari a intervalli regolari. Per quanto riguarda i farmaci, non esistono al momento segnalazioni di trattamenti farmacologici efficaci.