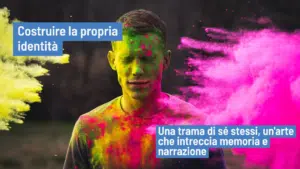Anendofasia: non tutti hanno una “voce interiore”
Spesso nei film o nei cartoni animati capita, quando viene inquadrato un personaggio, di sentire la sua voce dire alcune battute anche quando non sta parlando concretamente. Questo serve a renderci partecipi del monologo interiore del personaggio, ovvero la sua “voce interiore”. Per voce interiore si intendono i contenuti mentali verbali, ovvero i pensieri che formuliamo nella nostra mente sotto forma di linguaggio discorsivo (Perrone-Bertolotti et al., 2014).
Per molto tempo si è pensato che tutti avessero un monologo interiore. Questo assunto ha portato gli studiosi a formulare numerose ipotesi sulla funzione di tale fenomeno, valutando la possibilità che esso abbia contribuito allo sviluppo cognitivo della nostra specie. Tuttavia, recentemente è emerso che avere una voce interiore non è un’esperienza così universale come si riteneva (Alderson-Day et al., 2018; Soloducha, 2020). Quando si vogliono investigare esperienze umane nuove o insolite, risulta molto utile avere un’etichetta che permetta di identificarle: per questo motivo, allo scopo di descrivere il fenomeno dell’assenza di una voce interiore, la linguista Johanna Nedergård e lo psicologo Gary Lupyan – ricercatori presso l’Università di Aarhus e l’Università del Wisconsin – hanno coniato il termine “anendofasia”, derivante da an (mancanza), endo (interiore) e phasia (parola, linguaggio).
La scoperta di questo fenomeno fa sorgere spontanee alcune domande: com’è la vita di chi non possiede una voce interiore? Vi sono differenze tra chi possiede una voce interiore e chi non la possiede? Se sì, esse si riflettono anche in differenze comportamentali che possono essere misurate?
Un esperimento su voce interiore e memoria
Per rispondere ad alcune di queste domande – in particolare, per indagare se l’assenza di una voce interiore abbia un impatto sulla memoria – Nedergård e Lupyan (2024) hanno reclutato 93 soggetti e hanno previsto per loro quattro diversi compiti comportamentali aventi un nesso con la voce interiore e con la memoria. Nello specifico, si trattava di un campione ben bilanciato: 47 partecipanti avevano un’alta propensione a “mettere in atto” la voce interiore, mentre gli altri 46 sperimentavano l’anendofasia che, come abbiamo visto, indica l’assenza della voce interiore.
Nel primo task i soggetti vedevano coppie di immagini raffiguranti oggetti e dovevano indicare se i nomi di questi ultimi facevano rima tra loro oppure no; nel secondo, i partecipanti dovevano osservare cinque parole che erano fonologicamente simili e ortograficamente diverse (es. “bought”, “sort”, “taut”, “caught” e “wart”), oppure ortograficamente simili e fonologicamente diverse (es. “rough”, “cough”, “through”, “dough” e “bough”), ricordarle e infine riprodurle; nel terzo task, ai soggetti era richiesto di eseguire ad alternanza addizioni e sottrazioni. Il compito di memoria risiedeva nel fatto che talvolta ai partecipanti non veniva indicato quale operazione eseguire, ma dovevano ricordarlo loro in base a quella che avevano appena terminato, ed eseguire quella opposta; nel quarto e ultimo task, i partecipanti dovevano distinguere tra tre sagome nere di gatti e tre sagome nere di cani.
Si prevedeva che un minore utilizzo della voce interiore fosse associato a una difficoltà maggiore nel confrontare i nomi in rima e nel distinguere le sagome feline da quelle canine, e a una capacità di memoria inferiore per quanto riguardava le cinque parole fonologicamente e ortograficamente simili o diverse e le operazioni matematiche da eseguire.
Cosa è stato scoperto sulla voce interiore?
I risultati dello studio hanno evidenziato che gli individui senza una voce interiore hanno avuto prestazioni più scarse nello svolgimento dei primi due task, sperimentando maggiori difficoltà nel determinare se una coppia di immagini contenesse due parole che facevano rima tra loro e nel ricordare una serie di parole nell’ordine corretto. Probabilmente, questo è dovuto al fatto che ripetere le parole nella propria testa sia fondamentale per ricordarle meglio e per stabilire se fanno rima con altre parole. È infatti interessante notare che, quando i partecipanti hanno ripetuto le parole ad alta voce durante lo svolgimento dei compiti, non sono state rilevate differenze significative tra le performance dei due gruppi, suggerendo che questa modalità può rappresentare una sorta di “meccanismo di compensazione” per gli individui senza voce interiore.
Non sono invece state osservate differenze tra i due gruppi negli ultimi due task: i partecipanti senza una voce interiore non hanno mostrato maggiori difficoltà nel passare rapidamente da un’operazione matematica all’altra (ricordando quale avessero svolto precedentemente) e nel distinguere tra figure molto simili, suggerendo che i meccanismi alla base dello svolgimento di questi compiti non sono fondati sul linguaggio.
Questi risultati rappresentano una prima interessante evidenza del fatto che esistano delle differenze nel funzionamento della mente degli individui con e senza una voce interiore, differenze che possono essere mascherate grazie all’utilizzo di alcune strategie di compensazione. Una stimolante prospettiva futura è quella di esplorare altre conseguenze dell’anendofasia, e in particolare se l’assenza di una voce interiore possa influire sull’andamento della psicoterapia: la terapia cognitivo comportamentale, ad esempio, richiede di identificare e ristrutturare – tra le altre cose – i propri pensieri disfunzionali, e in questo processo avere una voce interiore potrebbe ricoprire un ruolo rilevante.