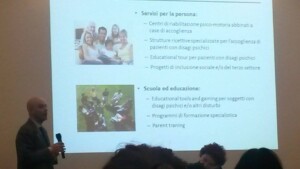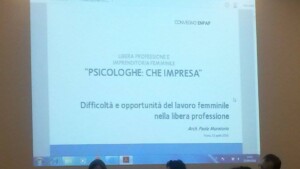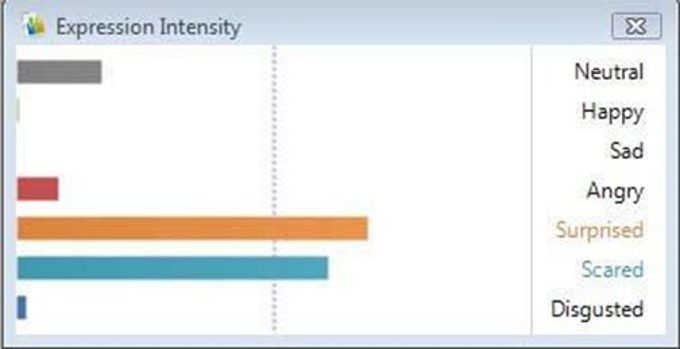Un caso di Rimozione e Spostamento in Hieronymus Bosch
Il pittore Jeroen Anthoniszoon van Aken, meglio noto come Hieronymus Bosch – o solamente Bosch – non è solo uno dei grandi maestri della pittura fiamminga ed universale, è anche un perfetto esempio di come l’arte possa rappresentare in modo sconfinatamente profondo i processi individuali psichici e collettivi negli esseri umani rappresentando, animando con forme e colori, un conflitto personale dilaniante tra pulsioni sessuali individuali e morale comportamentale comune.
Introduzione
Opere tecnicamente d’avanguardia, nei decenni che congedano il Quattrocento nord europeo da un formalismo sclerotizzato e lo schiudono, definitivamente, ai primi anni sperimentali del Cinquecento continentale mittel europeo.
Irradiano un messaggio fatto di estremi e di estremismi sempre e comunque antropomorfi: l’Anima – in senso Junghiano – dell’uomo è sempre centrale, con forme mostruose ovunque intente o accovacciate, o, raramente, con altre pervase di serenità e trasporto mistico sino perfino al culmine della speranza e della salvazione oltre il passaggio terreno.
Traspaiono nelle sue opere, ed in tutti i particolari in esse ascritti, una potenza espressiva che ha del prodigioso – anche tecnicamente parlando, forme, colori, variazioni stilistiche -, diretto riflesso di un uomo recettivo col suo talento ad una società in evoluzione e quindi per forza di cose conflittuale, con un animo tormentato, se non addirittura contorto, esattamente e precisamente come il suo tempo.
La produzione figurativa di Bosch, particolarmente lo sperimentalismo del Cinquecento mittel europeo di cui si diceva prima, è ispirata al “demoniaco” o, come potremmo dire noi oggi, al conflitto tra Conscio/Inconscio, tra pulsione individuale e morale comune, tra desiderio segreto e divieto sociale (J.C. Perry, 1991; Vaillant G.E., 1992; Gleser G.C. & Ihilevich D., 1969); ritroviamo le deformità “naturali” di tutti i “mal nati” e scansati dai villaggi e dalle città, gli zimbelli claudicanti presi ad esempio come punizione spirituale ascritta nella carne circa i suoi peccati; l’insondabile rocciosa presenza di silenziose immagini egiziane e mesopotamiche; la ineluttabile spaventosa e bestiale violenza delle deità infernali tibetane, che traviano più in vita che nell’intervallo tra una reincarnazione e l’altra; le perturbanti e chiassose presenze dei demoni gotici di Francia e d’Italia con annessi i resti mitologici e psichici di fauni e ninfe greci inglobati e rielaborati dalla mitologia nordica (prima vichinga, poi celtica, infine normanna).
Rimozione e Spostamento nella Teoria Psicoanalitica
Per poter leggere in modo adeguato l’opera e la psiche di Bosch, dobbiamo volgerci a Freud ed alla teoria psicoanalitica classica onde utilizzare due suoi concetti cardine, riferiti ai meccanismi di difesa intrapsichici: la rimozione e lo spostamento.
In psicoanalisi, la rimozione è un meccanismo psichico inconscio che allontana dalla consapevolezza del soggetto (Vaillant G.E., 1992), nel senso quasi fisico del termine, quei desideri, pensieri o residui mnestici considerati inaccettabili e intollerabili dall’Io, e la cui presenza provocherebbe ansia ed angoscia. Onde identificare meglio questo processo potremmo utilizzare il termine ulteriore di evitamento.
Il secondo meccanismo di difesa in esame, lo spostamento, è invece un processo operato dal Super Io il cui scopo è quello di modificare, ristrutturare nel contenuto e nella forma, il contesto reale di un ricordo rimosso di una esperienza, per ridurne l’impatto disturbante sulla coscienza (nello specifico l’Io). Per specificare questo secondo processo potremmo utilizzare il termine più ampio di riorganizzazione.
La funzione di questi due meccanismi interessa egualmente una pulsione, un’emozione o processo ideativo riferiti all’Io (Vaillant G.E., 1992) che, da una iniziale origine e conseguente obiettivo, viene variata – letteralmente ridirezionata – verso un altro oggetto organizzato in modo meno minaccioso per il soggetto.
La rimozione, inteso come meccanismo cardine di difesa cui consequenzialmente ne derivano tutti gli altri, va considerata come modalità universale dello psichismo con finalità propriamente difensiva; tale difesa è a tutela dell’ideale dell’Io (o Super Io) in cui ciascuno si rispecchia, ovverosia quella immagine, sempre e comunque esperienziale perchè ideativa affettiva e concreta, è la summa di specifici divieti e permessi enucleati e mossi dal Super Io stesso.
Un elemento esperienziale, o contenuto, ritenuto inaccettabile o al di fuori dei “permessi” del Super Io, risveglia il materiale rimosso che spinge, se così possiamo dire, per manifestarsi più o meno intensamente e progressivamente a livello cosciente, e l’Io quindi media fra questo elemento esperienziale e la resistenza/controllo della resistenza (Perry J.C., 1991). In questo caso entra in gioco il meccanismo di spostamento vero e proprio, enucleando un necessario appagamento, tramite mimesi e compensazione, che permette al materiale rimosso di manifestarsi ma – ed è proprio dello spostamento – in contenuti e forme assai diverse dal suo originario materiale, decisamente più distorte e lontane dalla forma originaria pulsionale quanto più è forte la resistenza agita dal Super Io.
Nella vita ordinaria il sogno, i lapsus, gli atti mancati, sono il prodotto e correlato di questo duplice processo.
Ciò che stiamo esaminando, circa la relazione tra psicoanalisi classica e l’opera di Bosch (che riguarda certamente tutti i soggetti dotati di un talento creativo o artistico), prende specificatamente il nome di “nevrosi creativa”. Questa forma di nevrosi – volendo utilizzare il termine primitivo freudiano – se è canalizzata è il motore proprio dell’arte, il genio creativo e gli ammiratori dell’opera vi manifestano, singolarmente e collettivamente, un proprio contenuto rimosso che utilizza l’opera (non importa in quale forma) come supporto ed estensione dell’Inconscio e questo ulteriore processo prende poi il nome di sublimazione – individuale e collettiva.
In questo senso l’arte non è tanto una velleità narcisistica o esercizio di talento tecnico ma, piuttosto, una necessità individuale di elaborare ed esperire materiale altrimenti collusivo l’Io nel suo tentativo di reggere l’opera difensiva del Super Io.
Ma facciamo un passo ulteriore nel comprendere queste difese e la loro relazione specifica col processo creativo, integriamo quanto detto con le osservazioni cliniche di C. G. Jung e con la sua rilettura specifica della rimozione e spostamento.
Notiamo due elementi:
per Jung i processi pulsionali non sono di esclusiva natura sessuale, anzi la sessualità è uno dei diversi possibili modi in cui la pulsione può estrinsecarsi. Più chiaramente Jung sostiene che ciò che è di natura sessuale “può” rimanere legato a questa origine ed “estinguersi” in medesimo modo ma non è meccanico, automatico, determinato tout court. Un contenuto sessuale può estrinsecarsi come elaborato in altra forma e in Jung il processo creativo, l’Arte, ne è la via regia.
I contenuti che riguardano la rimozione, a differenza di Freud, non hanno una valenza solo ed esclusivamente personale – individuale – ma anche storico-sociale. Jung, quindi, postula un Inconscio Collettivo con simboli, processi, archetipi propri condivisi che sono al contempo meta-linguaggio tra le persone e vere e proprie rappresentazioni inconsce condivise su vastissima scala.
Sarebbe riduttivo operare un distinguo forzato, settario, tra questi due contributi (Vaillant G.E., 1992), meglio è poterli integrare assieme onde avere uno strumento raffinato, e profondo nel suo scandagliare, per poter cogliere e capire il dinamismo psichico di un artista, nel caso specifico Bosch.
La rimozione e spostamento individuale opera, nel singolo, entro quella cornice inconscia determinata dai margini esperienziali-evolutivi di conflitto tra Io e Super Io (Perry J.C., 1991). La rimozione e spostamento individuale, nel processo creativo dell’artista, coglie e riprende quei dinamismi propri e causali in una cultura manifestandone la Weltanschauung del periodo.
In questo senso è opportuno dire che l’artista, il genio creativo, è al contempo altro e spurio dalle capacità altrui ma estremamente e profondamente recettivo circa i dinamismi e conflitti della Società, Cultura e Credenze del suo tempo. In quanto segue vedremo come il conflitto psichico in Bosch non solo è rappresentato artisticamente ma anche substanziato dalla stessa religione e da una ricerca personale di risposte tesa all’edonismo e ad una rilettura ieratica di un esoterismo alchemico-occidentale.
Cornice e Sfondo di un Conflitto: Confraternita e Setta
Un profondo conflitto tende sempre ad una risoluzione di compromesso, ad una “mediazione” ed “aggiustamento”, tra la sua estinzione e contenimento. Un conflitto pulsionale individuale rimanda sempre ad una Cultura che lo rappresenta ed, in parte, alimenta – come anche direziona e contiene. Questo fenomeno non è certamente meno presente in un individuo intellettualmente complesso ed artisticamente innovativo come Bosch, più precisamente in come l’uomo Hieronymus – nella sua personale esperienza psichica del mondo – abbia cercato di conciliare e pacificare il Bosch artista e uomo di fede.
Bosch cercò di elaborare una personale forma di alterità, di estrema e composita conciliazione, tra un mondo estremamente fragile, sconvolto da guerre, carestie ed elevata mortalità, e un’aspirazione segreta, intima, bramosa alla bellezza, alla passione, all’edonismo dei sensi e tensione spirituale all’eternità (W. Fraenger, 1983).
Bosch riuscì a coesistere ed a operare all’interno di due realtà culturali lontanissime e difformi che, attraverso l’obiettivo analitico, sono un immane meccanismo di elaborazione esogena pulsionale.
Una di queste realtà è strettamente legata all’impianto psichico specifico del Super Io e l’altra riversata, nutrita, vissuta ed esperita tramite contenuti e forme specifiche dell’Es.
Gli elementi storici, culturali, filologici sono centrali per contestualizzare quanto più compiutamente il punto di vista personale di Bosch, quindi è opportuno fornire alcuni elementi di riferimento per caratterizzare questa specifica cultura fiamminga che è una variazione autonoma e peculiare di un Rinascimento-Umanista totalmente a parte:
è una società spregiudicata negli investimenti e nelle alleanze politico-economiche cui fa da contraltare una massa quasi infinita di impiegati a basso salario, di delegati a percentuale, di domestici se non addirittura veri e propri schiavi.
È una società cattolica, non cattolico romana, ma calvinista, dove il profitto e il benessere sono considerati emanazione diretta della benevolenza divina nonché di essere ascritti nella buona società.
È una società in conflitto con lo sviluppo economico sociale esterno, ed in conflitto internamente, verticista, piramidale e classista il tutto a senso unico. Lo scavallo da un gradino basso al successivo è premiato ed incentivato ma lo stesso in senso inverso è penalità permanente cui consegue emarginazione e ludibrio.
I princìpi che regolano la morale, particolarmente in senso sessuale, sono dichiaratamente misogini e puritani su un doppio binario ove tutto è concesso all’uomo e nulla alla donna, ove matrimonio significa alleanza di buoni cognomi, di irrifiutabili abbondanti sostanze e, ancora, ove la malattia sessuale (sifilide e gonorrea) sono primariamente malattie morali, evidenza di degenerazione personale e di vizio e le cure mediche sono rifiutate in quanto elemento di punizione sociale.
Questa serie di punti è necessaria per ascrivere al meglio la cornice storica, culturale e psicologica tra Freud e Bosch e comprendere come le opere di quest’ultimo siano una diretta risultante e “permanenza” circa i meccanismi di difesa a contenuto sessuale cui di seguito verrà data spiegazione.
Nel 1486 (M. J. Friedländer, 1927; L. von Baldass, 1943; C. de Tolnay, 1937; R. H. Marijnissen, 1972), più o meno poiché alcuni documenti sono non chiari o definitivamente perduti, Bosch entrò a far parte della Confraternita di Nostra Diletta Signora (Lieve-Vrouwe Broederschap), un’associazione fondata nel 1318 che comprendeva uomini e donne laici, ed ecclesiastici, dediti al culto della Vergine, ad opere di mortificazione spirituale e fisica nonché a opere di carità. Per la Confraternita, che stimava molto le sue opere, Bosch, attorno al 1489, partecipò inizialmente alla realizzazione di un retablo per la cattedrale di san Giovanni proprio in Hertogenbosch. Nella cattedrale, infatti, la Confraternita aveva una sua propria cappella per la quale fece realizzare da vari artisti anche ulteriori opere celebrative.
Questa Confraternita era da considerarsi, a tutti gli effetti, il mezzo e il simbolo concreto di un’accettazione sociale ed affermazione individuale, all’interno di una enclave fondata e determinata da un ferreo moralismo, da un reciproco quotidiano vincolo di continua testimonianza della fede e da attività di tipo spirituale e con finalità pietistiche.
Bosch è l’uomo novus, il prototipo del talentuoso che riceve un riconoscimento sociale (W. Fraenger, 1983) poiché aderente ed attinente in toto alla norma e ai divieti social-religiosi di quello specifico contesto e comunità. Bosch è, a sua insaputa, uno dei tanti primi “uomini nuovi” che contribuiscono a quello specifico processo di rivoluzione sociale che darà forma alla borghesia europea così come la vedremo compiuta in Olanda e Germania a ridosso della Golden Age. È una vera e propria scalata sociale, di totale affermazione in un ambito ibrido tra religione (immancabile), società (comunità attiva) ed ordinamento sociale (stato).
Bosch è divenuto rispettabile ed anche assai rispettato, attenendosi alle richieste di un sistema sociale strutturato e funzionale al Super Io individuale e collettivo.
Ma questa è solo una parte dell’esperienza psicologica e sociale di Bosch. È il Super-Io.
Vi è tutt’altra parte che esiste, coesiste e forse bilancia magnificamente questo microcosmo di rettitudine sociale, osservanze private, servizi sociali e devozioni celebrative.
L’altra parte è quanto attiene all’Es, all’Inconscio. Alle pulsioni rimosse ma inestinguibili dell’animo umano.
Per Bosch ebbe una radicale importanza il suo ulteriore legame occulto con la Setta del Libero Spirito (M. J. Friedländer, 1927; L. von Baldass, 1943; C. de Tolnay, 1937; R. H. Marijnissen, 1972), fiorita in Europa nel XV secolo, dedita ad un culto totalmente altro – speculare ed inverso – rispetto alla Confraternita. Un culto decisamente esoterico, di ispirazione panteistica primordiale, ove ritroviamo quasi intonse le credenze, i simboli, i riti e le necessità di una società pre-cristiana; una società, rispetto la Chiesa di Roma, certamente definita pagana ma con uno suo preciso credo, regole, riti e finalità.
Si trattava di comunità segreta alle istituzioni religiose ufficiali, di persone e di pensiero che si rifacevano ad una dottrina chiaramente presente già in epoca paleocristiana e ad essa antecedente, imperniata sulla figura mitologica e mitizzata di un Adamo antecedente la cacciata dal Paradiso ove il mito della Tentazione Primigenia e del frutto proibito è volutamente posto a parte se non addirittura quasi del tutto ignorato. Questa dottrina si fondava su un’erotica adamitica, lontana dal sesso come esclusivamente procreativo, piuttosto intesa come ritualistica, volendo incarnare una forma primitiva di perfezione, uno stato di innocenza in un ripristinato, tangibile, paradiso terrestre per gli uomini ed indissolubile dalla loro natura incondizionata; un credo che è senza l’attesa della Redenzione evangelica che non attende il Giudizio e l’Apocalisse, o il momento postumo al trapasso terreno. Uomini e donne erano eguali in quanto eredi di Adamo ed Eva prima della cacciata dal Paradiso, prossimi e contemplativi il Creatore e dunque ancora in tutto somiglianti la perfezione e l’innocenza; soltanto rifacendosi al primo uomo ed alla prima donna c’era – secondo questa dottrina – la speranza tangibile di ricongiungersi con il Supremo, quindi la sessualità era una via privilegiata per ascendere e ritrovare la purezza, per emanciparsi sia dalla prigionia della carne come anche dalla vergogna e colpa della pulsione implicita la carne.
Questa setta celebrava i propri riti in grotte e catacombe, richiedendo ai presenti e all’officiante la più completa nudità e permettendo, incoraggiando, il contatto fisico. Ipotesi lecite e dubbi necessari, vi sono circa un possibile, probabile, uso di decotti e bevande psicotropi durante queste celebrazioni estatiche cosa tra l’altro non aliena a diversi culti in Europa poiché tra l’Italia e la Francia e la Germania abbondano ben 19 specie di funghi con proprietà psicotrope o allucinogene ampiamente utilizzate dalla Finlandia all’Inghilterra sino all’Italia, specie di facile reperibilità e preparazione sono Mycena pura, Psilocybe cyanescens e Amanita muscaria.
Qui la sessualità è gioia, estasi, serenità con i propri simili e con la natura, il mondo animale e vegetale. Sono uomini e donne dediti all’amore e alla purezza, in continuità con la coppia originaria che ha generato l’umanità: quell’Adamo e quella Eva così vicini a Cristo nel primo pannello del “Trittico delle Delizie”, di cui parleremo dopo. Un giardino delle delizie, dunque, che spetta ad ognuno di noi, se capaci di abbracciare la vera dottrina che porta alla purezza. “L’artista”, scrive Fraenger nel libro Hieronymus Bosch, il Regno Millenario, “voleva rappresentare l’apoteosi della felicità paradisiaca della creatura unita a Dio e riconciliata con la natura”. Un paradiso aperto ai fratelli e alle sorelle disposte a rinascere attraverso Adamo.
E l’inferno? Quello tocca a chi rifiuta questa verità, a chi continua a professare la vecchia dottrina, a chi vive nella cupidigia, nella lussuria, nei piaceri del mondo.
La dottrina adamitica, chiaramente eretica, incontrò in Italia l’interesse di pensatori di rilievo come Pico della Mirandola e Marsilio Ficino, in un sincretismo che mescolava cristianesimo, filosofia greca, pratiche misteriche. Nell’epoca che si avvicinava al Rinascimento, brillava l’idea di un rinnovamento dello spirito attraverso un miglioramento interiore, che portasse l’uomo ad un livello originario di purezza, semplicità, bellezza.
Vedere il conflitto pulsionale
Vediamo ora, con uno sguardo analiticamente edotto e culturalmente direzionato, alcune delle opere di Bosch che maggiormente rappresentano in termini analitici lo specifico conflitto pulsionale e la resistenza psichica ad essa associata.
I critici ritengono che una delle sue opere più rappresentative come anche più problematiche sia “Il Trittico delle Delizie”. Il gran maestro della Setta del Libero Spirito è stato, con ragionevole certezza di critici e filologi, il committente del Trittico medesimo e quindi ispiratore del pittore che già, naturalmente dotato di una sorprendente capacità nel tradurre in simbologia anche il più piccolo segno, raccolse nel suo linguaggio artistico la dottrina di questa enclave.
Il Trittico deve essere guardato e veduto con una immaginaria linea orizzontale di separazione che divide, a metà, l’opera tra un Alto ed un Basso. In Alto notiamo immagini, simboli, rappresentazioni di unità e perfezione. Nel Basso la rappresentazione dell’umanità, delle passioni, dei peccati e delle tentazioni morali.
Escludendo il terzo pannello, notiamo come fisicamente Bosch identifichi con la terra e la forza di gravità la natura e forza delle passioni mentre con il movimento verticale implicitamente asserisca che l’allontanarsi fisico da esse coincida con l’alleviamento dalla loro forza e quindi una sorta di progressiva – anche cromatica – apertura all’Assoluto, all’Eterno, ad una Estasi atarassica perfetta immutabile e completa. Il terzo pannello, di cui prima, è la esplicitazione e summa perfetta della presenza e permanenza del peccato e delle sue possibili corruzioni che sono le tentazioni, seduzioni e sedizioni del male verso l’uomo e contro la Fede.
Il mondo di Bosch, il mondo che Bosch rappresenta, è assolutamente sistematico e coerente e ciò perché:
sistematico in ogni suo punto e coerente l’insegnamento della fede cattolica;
sistematico e coerente il temuto effetto sull’anima in caso di allontanamento dalla Fede;
sistematico e coerente è il sistema sociale derivante dall’osservanza della fede e ripudio di ogni sua deviazione.
Cui si aggiunge una considerazione eminentemente psicologica:
la psiche (ogni psiche) è rispetto a sé – alla sua storia e sistema di funzionamento interno – comunque sistematica e coerente.
Questa aderenza asfittica e sistematica ad un tale sistema di vita potrebbe a noi moderni sembrare assolutamente estrema, se non addirittura assurda ma dobbiamo contestualizzare la vita di questo individuo, la sua esperienza concreta di vita come anche quella dei suoi simili, in una realtà che non è, nemmeno lontanamente questa attuale; ciò significa realizzare il brevissimo e fragile spam di vita in quell’epoca: 38/48 anni per gli uomini (15/20 in periodo di guerra) e 20/35 per le donne (14/20 in caso di morte per parto o conseguente setticemia) ed una media statistica generale di 25/28 anni di aspettative di vita; malnutrizione, carestie, infezioni, epidemie, morte violenta, omicidio, guerra, razzie, appropriazioni arbitrarie e ruberie private o di stato.
Il quadro (W. Fraenger, 1983; Vaillant G.E.,1992) che ne emerge è una società con un fulcro fisso ed inamovibile (Imperatore, dignitari, conti cui segue Chiesa, Papa e chierici) mentre tutta la restante parte della vita e degli eventi sociali è nella più assoluta precarietà, instabilità e violenta mutevolezza.
Bosch è a contatto con due aspetti continui, costanti ed imprevedibili della vita: l’Eros e il Thanatos (S. Freud; 1915; Perry J.C., 1991).
L’eros è l’esistere, il vivere, il sopravvivere in un mondo violentissimamente mutevole ed ignavio.
Il thanatos è la reputazione sociale intaccata dai giudizi o dalle malevole considerazioni, è lo scavallo sociale negativo da una posizione se non privilegiata quanto meno decente, è la morte per misteriosi e divini motivi, è la vulnerabilità e fragilità della condizione umana in quanto tale.
Vita e morte, eros e thanatos sono impastate, accostate, inscindibili e rendono l’esperienza del solo esistere grottesca, farsesca, quindi non è proprio un caso che come sostiene Roger Caillois – nel suo libro Nel cuore del fantastico – a furia di accostarsi l’una all’altra, queste realtà quotidiane e paventate ed immaginate meraviglie e terrori deformi finiscano per formare una sorta di vocabolario del grottesco nelle opere di Bosch. L’uomo e la sua esistenza sono sempre espressi per gradi ed estremi e lo psicoanalista e lo psicoterapeuta ben sanno come e quanto, alla parola sistematico, corrisponda il termine Popolazione dei Sè ed un coerente sistema di accostamenti di temi, di complessi/conflitti cognitivi ed emotivi, di straniamenti ed inclusioni esperienziali.
In moltissime figure uomini, animali e vegetali si uniscono in un solo, unico, essere e danno vita a spaventose mutazioni senza fine, che non hanno più nulla di umano ma che ancora non hanno raggiunto il soprannaturale: permangono ed abitano il regno del grottesco (M. J. Friedländer, 1927; L. von Baldass, 1943; C. de Tolnay, 1937; R. H. Marijnissen, 1972).
Se utilizziamo in modo proprio il termine “conflitto” – cum fligere, scontro violento, opposizione di forze-, così come risuona anche nell’impianto freudiano, di volta in volta abbiamo rappresentazioni di conflitti concettuali e pulsionali – morale e desiderio – ed unificazioni quasi caricaturali dove ogni parte assemblata alle altre dice e rappresenta una sola cosa: l’inscindibilità angosciosa tra una norma interna e il bisogno individuale di trascenderla, evitarla, superarla.
Ma al conflitto corrisponde, logicamente per il seminato analitico, il sintomo ed il conseguente tentativo di riparare (correggere come anche rendere sicuro) uno scontro interno, quindi non mancano tutte quelle rappresentazioni che tendono, in senso propriamente fisico ovvero direzionale ed energetico, a “bilanciare” la pulsione inizialmente contro la norma, da cui la colpa e la certa punizione e l’angoscia conseguente percepita. Le forme simboliche di questo “contro bilanciamento” che più ricorrono frequentemente sono l’uovo, la sfera, intonsi derivati del platonismo ed aristotelismo in una impellente necessità di equilibrio, annullamento di contrasti e violente forze, in altri termini raggiungimento di perfezione che, mutuando ancora dalla teoria freudiana, hanno come solo scopo una equidistanza e capacità di mediazione dell’Io stesso tra l’Es e il Super Io.
Nei demoni di Bosch (W. Fraenger, 1983; Vaillant G.E.,1992) si spande una visione del demoniaco, del male, del difforme che sembra capace di sintetizzare l’intera esperienza umana nella deviazione da una norma interna come anche sociale. Senza dubbio Bosch, in quanto individuo ed artista, ha raggiunto in questa particolare potenza espressiva e forza esorcizzante, inconfrontabile ad altri eccetto forse Salvador Dalì.
Se facciamo scorrere lo sguardo e vediamo, passo passo, questo Trittico iniziamo progressivamente a sperimentare dispiegamento concettuale ed una stratificazione simbolica (e contenutistica) che è proprio il focus conflittuale di quella rimozione e spostamento che tutto Bosch rappresenta e da cui egli stesso è mosso. Perché l’artista non si incentra solo sul demoniaco, anche se è questo che al principio colpisce di più, e sarebbe assai riduttivo considerarlo solo come creatore di fantasie bizzarre, ma utilizza e fonde l’elemento primigenio e substanziale del conflitto intrapsichico ovvero la sessualità, il desiderio sessuale, il corpo e la carne.
La sessualità è costantemente presentata nei suoi più assoluti estremi, è ambivalente, ma non potrebbe essere diversamente perché è pena e gioia in Bosch e i suoi contemporanei, è abbrutimento ed anche estasi, è fissazione incessante come anche finale serenità, è perversione e perfezione. Tutto è preso e coinvolto nel conflitto sessuale (J.C. Perry,1991; Vaillant G.E.,1992; Gleser G.C. & Ihilevich D., 1969) : esseri umani, il mondo animale, il regno vegetale. Vi sono uomini e donne dediti all’amore e alla purezza, in continuità con la coppia originaria che ha generato l’umanità: quell’Adamo e quella Eva così vicini a Cristo nel primo pannello.
Vi sono uomini e donne e animali e demoni dediti alla fornicazione, alla copula ed alla crapula della carne con la carne, come già fossero gli ultimi istanti prima del Giudizio Universale di apocalittica descrizione. Bosch estrinseca il suo conflitto, lo rappresenta come solo potrebbe un individuo moderno in una psicoterapia di gruppo, come un giardino delle delizie e degli orrori non solo personale o intimo.
La tensione ultima di Bosch, la sua fuga da questo gioco di specchi morale e carnale, è decisamente ben riassunta da Fraenger, che conclude che l’artista voleva [blockquote style=”1″]rappresentare l’apoteosi della felicità paradisiaca della creatura unita a Dio e riconciliata con la natura.[/blockquote]
Un paradiso aperto ai fratelli e alle sorelle disposte a rinascere attraverso Adamo, a tutti coloro disposti a cercare e trovare altro che fosse la vita civile e sociale intesa secondo il tempo (M. J. Friedländer, 1927; L. von Baldass, 1943; C. de Tolnay, 1937; R. H. Marijnissen, 1972). E’ un chiaro invito alla trasgressione o, anche e perchè no, una elaborata ricerca di complicità e comunione con quanti avessero a vivere lo strappo interiore tra il Super Io e l’Es, tra la persona in senso Junghiano e l’essere umano nel senso più tangibile e naturale possibile.
E l’inferno che in questo pellegrinare di immagini e pannelli Bosch mostra e silenziosamente descrive, cosa è? E ciò che tocca a chi rifiuta questa inevitabile verità ovverosia il bisogno di alterità ad un mondo che ha poco da offrire se non norma e punizione; è ciò che si sperimenta ogni giorno, psichicamente, a chi continua a professare la vecchia dottrina Cattolico Romana e papista, a chi vive nella cupidigia, nella lussuria, nei piaceri del mondo nell’ipocrisia del mondo stesso.
La forza principale di questo pittore (W. Fraenger, 1983) consiste nell’aver saputo tradurre, con un’esaltazione notevole ed inverosimile per la cultura del XV secolo, gli incubi, le visioni e le angosce che il cervello umano sa creare, trasformando in metafora esseri e situazioni incontrati nel labirintico territorio dove si lotta per l’esistenza, per la continuazione ed il trionfo del Bene sempre sottoposto alle lusinghe del Peccato.
Bosch lavorò sempre con grande coerenza narrando a noi uomini delle verità difficili da comprendere e trasformando le più inconsce paure umane in pennellate di incredibile bellezza.
Il suo tormento interiore, aumentato da conoscenze forse incredibili, è per noi ancora un enigma di difficile soluzione.
Riuscire a risolvere il Mistero ci permetterebbe di comprendere meglio la sua genialità ma potrebbe metterci di fronte a particolari verità in cui ci scopriremo nudi e circondati da ibridi orrendi in attesa di divorarci!