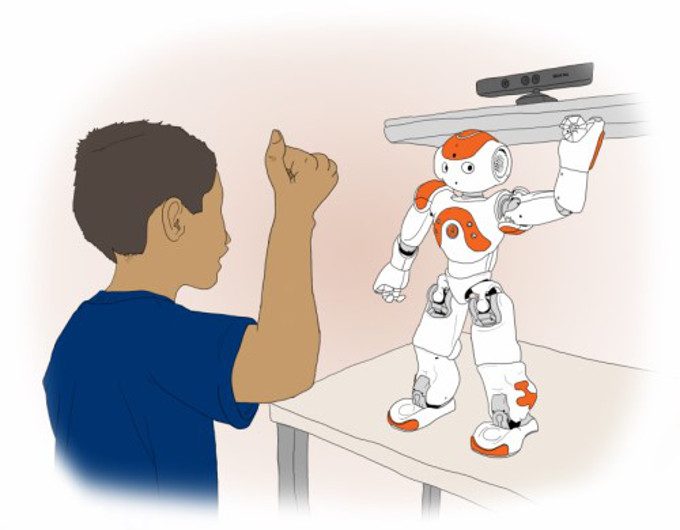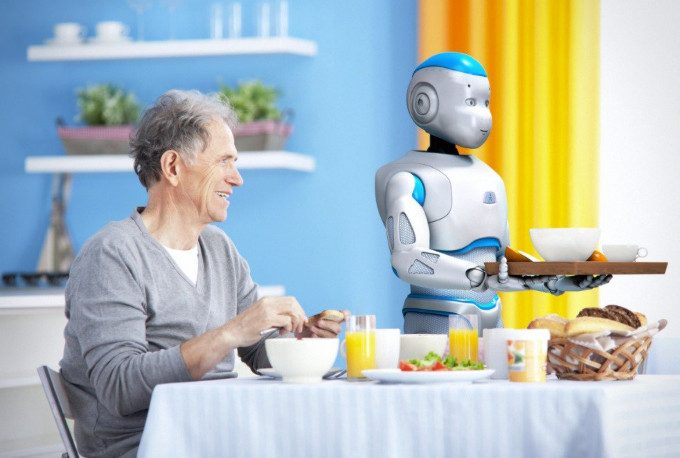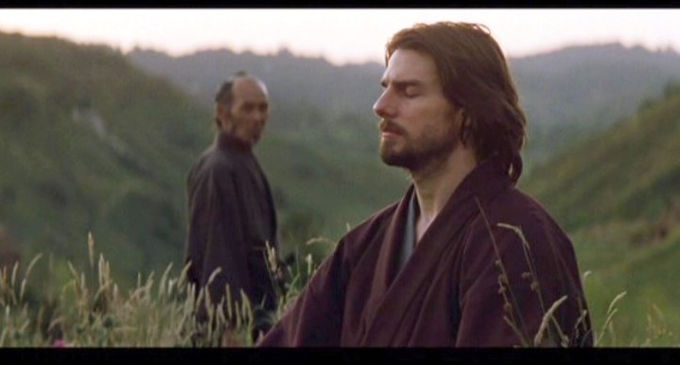Diagnosi, protocolli, industria e artigiani
I viventi di ogni specie devono fare previsioni sul proprio ambiente per poterlo gestire in modo da raggiungere i propri scopi. Conoscere serve innanzitutto per sopravvivere manipolando la realtà a proprio vantaggio. Si tratta di fare delle mappe della realtà e di se stessi per ipotizzare quali comportamenti saranno possibili ed efficaci.
CIOTTOLI DI PSICOPATOLOGIA GENERALE (RUBRICA) – LEGGI L’INTRODUZIONE
In accordo con Kelly penso che il primo atto conoscitivo sia una discriminazione bipolare che lui chiamò costrutto costruendoci sopra la teoria dei costrutti personali (1955) che ritengo tuttora gravida di potenzialità non ancora sfruttate pienamente.
L’operazione basilare del conoscere è dunque distinguere, differenziare. In un certo senso separare. Le grandi operazioni scientifiche sin dall’antichità hanno mirato e si sono avvalse per svilupparsi di classificazioni in cui si distinguono categorie all’interno delle quali si operano altrettante suddivisioni in ulteriori sottocategorie e via così fino al singolo oggetto o individuo.
Il più noto di questi sforzi fu quello di Linneo che con il suo ‘Sistema Naturae‘ ordinò tutti gli organismi viventi. Pensate che organizzò un edificio a 27 piani:
- Dominio
- Regno
- Phylum (o Tipo o Divisione)
- Subphylum (o Sottotipo o Sottodivisione)
- Classe
- Ordine
- Famiglia
- Genere
- Specie
- Sottospecie
- Forma (zoologia) o Varietà (botanica)
Questo furor classificatorio non è appannaggio esclusivo degli scienziati. Devo continuamente arginare domande di pazienti che mi chiedono se quello che sperimentano sia amore, innamoramento, passione, infatuazione o amicizia.
Insomma si fa presto, anche se un po’ di ossessività aiuta, a stilare lunghe liste di categorie e sottocategorie. Poi però la realtà non ci si adatta mai perfettamente. Tocca forzarla, tirarla di qua e spingerla di là e poi inventare delle categorie intermedie. Pensate anche alle categorie dell’attaccamento che vanno sempre più articolandosi. Sapreste dire con certezza che attaccamento avete. Quando io ci provo con me stesso e con i miei allievi ci trasformiamo subito in un branco di Veltroni per cui ‘E’ così ma anche…. In un certo modo ma un pò nell’altro‘.
Ognuno crea mappe di quella parte di mondo che ricade nei suoi interessi e la cui conoscenza garantisce il raggiungimento dei propri scopi. Per questo tutti gli esseri umani hanno teorie sul funzionamento degli esseri umani stessi e di loro stessi in particolare (sono quelle che ho chiamato tanti anni fa le Teorie psicologiche naives e che nei nostri pazienti riguardano il perché loro soffrono e come potrebbero smettere di farlo).
I medici hanno creato meravigliosi atlanti di anatomia e sarebbe interessante riflettere sul fatto che anch’essi sono passati via via da una descrizione diciamo così topografica del corpo umano dove il criterio è la localizzazione (dove stanno i vari pezzi e cosa hanno intorno), ad una descrizione per funzioni in cui il criterio ordinante è lo scopo, la funzione. Per cui l’apparato locomotore sta dappertutto e altrettanto il respiratorio o il digerente (quest’ultimi due entrambi parte di un sovrasistema di scambi energetici con l’ambiente).
Gli psicologi non sono stati da meno e da Aristotele in poi hanno distinto i tipi psicologici, i temperamenti, i caratteri. Altrettanto hanno fatto con la classificazione delle malattie dando origine alle nosografie categoriali che da Kraepelin in poi, ed oggi con la serie dei DSM, hanno monopolizzato il sapere psichiatrico al punto che ormai ci sembra evidente che le malattie mentali con i loro nomi e cognomi, esistano veramente e siano oggetti della realtà e non semplici costruzioni della nostra mente che cerca di far ordine per poter ‘parlare di’ e ‘operare su’ una realtà che è senza soluzioni di continuità, senza cassetti distinti.
Bisogna essere consapevoli, pur continuando ad avvalersene, che l’attuale modo di pensare psicopatologico è impregnato di una mentalità categoriale che ha da sempre spinto l’uomo a operare classificazioni nei domini di proprio interesse partendo dalla premessa implicità che fossero costituiti da oggetti separati e ben distinguibili. Operando con ciò quelle che Bateson chiamava ‘terribili semplificazioni’ pur riconoscendone il fascino e persino l’utilità purché se ne conservi consapevolezza e non ci si creda veramente. L’ordine rassicura, l’indeterminato confonde e spaventa.
Il motivo del successo dell’approccio categoriale lo ascrivo a due motivi. Intanto è corrispondente all’esperienza che abbiamo della natura dove gli oggetti o ci sono o non ci sono e sono distinti nettamente uno dall’altro. Inoltre è più semplice prevedendo solo decisioni binarie circa la presenza o l’assenza di un dato oggetto o al suo interno di una certa caratteristica piuttosto che la valutazione della sua intensità.. Gli stessi pazienti, impregnati di mentalità categoriale, ci chiedono se un certo disturbo ce l’hanno oppure no così come ci chiedono se quello che provano è innamoramento, amore o semplice infatuazione passionale.
Vogliamo fare ordine nella nostra realtà complessa e continua e siamo abituati a farlo forzando la multiformità del reale nei cassetti ben distinti della nostra scrivania mentale. Vi sembrerà strano che il grande ordinatore, lo psichiatra tedesco Kraepelin, sia nato nello stesso anno (1856) di quel gran confusionario cui tutti dobbiamo essere riconoscenti che fu Sigmund Freud. Da allora la tradizione categoriale non ha avuto rivali mandando al confino della scienza gli oppositori (Griesinger con il suo riduzionismo neurofisiologico e Jung con i suoi tipi psicologici). Quando L’approccio categoriale ha incontrato gli americani portati per natura alla semplificazione e legittimati al ruolo di padroni del mondo dalla vittoria nei conflitti mondiali, il risultato è stato l’imperialismo culturale delle ricorrenti edizioni del DSM che hanno soffocato la grande tradizione psicopatologica europea.
Il novecento è stato anche il secolo in cui tutte le certezze delle scienze cosiddette esatte come la fisica sono state messe in dubbio da Eistein e dalla teoria dei quanti che hanno ormai superato tutte le prove sperimentali e mostrato l’imprecisione di distinzioni elementari assolutamente evidenti come spazio e tempo, materia ed energia, onda e pacchetto, materia e antimateria e l’illusorietà dei confini che ci fanno sembrare che gli oggetti materiali siano discreti e separati tra loro o che le particelle elementari siano effettivamente in un dato luogo.
Tuttavia se si è imposto così largamente il DSM deve pur avere dei meriti (non possiamo essere evoluzionisti solo quando ci fa comodo) ma è certo che ha ucciso il ragionamento psicopatologico. Per accertarsene è sufficiente leggere le cartelle cliniche dei manicomi dei primi del ‘900 (non solo quelle affascinanti di illustri fenomenologhi come Jasper, ma dei medici comuni che si sforzavano di ragionare e capire, di dare un senso a ciò che pareva insensato) e confrontarle con quelle dei colleghi appena usciti dalle scuole di specializzazione che, preoccupati di stabilire la presenza o l’assenza di ognuno dei molteplici criteri diagnostici, ricordano le negoziazioni delle figurine Panini attraverso la frase fatidica del ‘ce l’ho… mi manca‘.
Il DSM si pregia di essere ateoretico e dunque valido per tutti, un esperanto su cui tutti possano convergere come se presupporre l’assenza di una teoria che ordini i fatti non sia a sua volta una ben precisa teoria opposta ad esempio a tutta la tradizione occidentale che va da Kant fino al costruttivismo. Andremo adesso a spasso tra le opportunità e i rischi della diagnosi in compagnia teorica di uno straordinario psicoanalista, Ignacio Matte Blanco, e di uno psichiatra americano burlone Rosenham. L’utilità della diagnosi sta nel fatto che ci da prevedibilità sulla malattia che abbiamo di fronte e quindi scoperta la presenza di alcuni elementi possiamo inferire la presenza di altri non immediatamente evidenti e di un certo decorso e prognosi nonché la risposta o meno a certi interventi. Ad esempio se registro un attacco di panico, posso ipotizzare la presenza di evitamenti, di comportamenti protettivi come un accompagnatore, una buona risposta agli ansiolitici ed agli SSRI e prevedere una prognosi favorevole.
Però Matte Blanco ci mette sull’avviso che nel pensiero razionale, arisotelico o simmetrico ( come lo chiama lui) solo dall’identità dei soggetti si può dedurre l’identità dei predicati. Mentre è nel pensiero simmetrico caratteristico del processo primario di Freud, del sogno e, a mio avviso (Lorenzini Sassaroli 1992 ‘Cattivi pensieri: i disturbi del pensiero schizofrenico, paranoico e ossessivo‘) della schizofrenia si stabilisce l’identità dei soggetti sulla base dell’identità dei predicati. Ritenere dalla presenza di alcuni segni che ci sia una certa malattia e dunque tutti gli altri suoi segni, che è l’essenza del processo diagnostico, non è molto diverso dal ragionamento della schizofrenica che affermava ‘Io sono vergine, la madonna è vergine e dunque io sono la madonna’ oppure della sua collega che riteneva di essere la Svizzera perché non era mai stata invasa.
In soccorso a Matte Blanco accorre Popper sostenendo la fallacia del ragionamento induttivo per cui non si può trarre una regola generale dall’osservazione anche di numerosi casi singoli e che solo la negazione è generalizzabile. In altre parole anche vedere milioni di cigni bianchi non ci permette di dire con certezza che tutti i cigni sono bianchi. Al contrario anche un solo cigno nero rende vera l’affermazione generale ‘non tutti i cigni sono bianchi’.
Dunque attenzione perché, alla faccia di questi due grandi pensatori, nel processo diagnostico facciamo assolutamente questo. Dalla presenza di alcuni predicati (caratteristiche, attributi) stabiliamo l’appartenenza di un certo caso singolo ad una classe generale e immaginiamo che abbia tutte le caratteristiche (predicati) appartenenti alla classe stessa. Poi, confermazionisti come siamo, aspettandoceli, li andiamo a cercare e ovviamente li troviamo.
La prova sperimentale di questo perverso procedere l’ha fornita appunto Rosenham. Per chi non avesse voglia di leggersi il suo esperimento riportato in un capitolo dal titolo ‘La beffa di Rosenham’ nel libro ‘La realtà inventata‘ di P. Watzlavich, ne riassumo brevemente i tratti essenziali. Rosenham, convinto che gli statunitensi fossero troppo di manica larga nella diagnosi di schizofrenia, chiese a 12 suoi normalissimi amici di presentarsi all’accettazione di altrettanti ospedali psichiatrici riferendo di udire da qualche giorno delle voci che gli dicevano parole come ‘vuoto’, ‘dentro’. Per tutto il resto, circa la loro vita attuale e passata dovevano dire la verità. Tutti furono ricoverati con la diagnosi di schizofrenia e i resoconti delle loro normalissime esistenze era catalogato in cartella clinica alla luce della teoria sulla schizofrenia. Un ‘Si’ alla domanda se da piccolo giocava anche da solo diventava ‘presentava comportamenti autistici sin dall’infanzia’. Oppure l’ammissione di bisticci con il coniuge, segno di impulsività e aggressività. Dal giorno del ricovero i falsi pazienti non lamentarono più il sintomo allucinatorio ma ogni volta che chiedevano di essere dimessi in cartella veniva riportato che il paziente non aveva alcuna coscienza di malattia, caratteristica portante della schizofrenia. I falsi pazienti ebbero periodi di ricovero tra i 20 e i 68 giorni e furono dimessi con la diagnosi di schizofrenia in stato di parziale remissione in ossequio al dogma dell’inguaribilità della schizofrenia.
Rosenham, cattedratico a Stantford pubblicò la sua ricerca sollevando una alzata di scudi e l’affermazione da parte dell’APA che l’errore era stato causato dal non sapere della possibile presenza di tali impostori.
Allora Rosenham avvertì che in 5 ospedali psichiatrici avrebbe mandato di nuovo nel successivo anno dei suoi falsi pazienti invitando i colleghi a stare accorti. In effetti ben il 33% dei pazienti presentatisi all’accettazione di quegli ospedali psichiatrici fu respinta con la diagnosi di ‘falso paziente di Rosenham’. Peccato che Rosenham non avesse mandato nessuno.
Tutto questo ci fa riflettere non soltanto sull’aleatorietà della diagnosi, ma sulla sua pericolosità in quanto crea un pregiudizio di emarginazione e disinvestimento che rischia di diventare una profezia che si autoavvera. Dunque se la diagnosi categoriale ci da l’impressione di aumentare la prevedibilità su ciò che abbiamo di fronte, da un lato fa si che cerchiamo e troviamo tutti gli indizi che la confermano e dall’altro scotomizziamo ciò che la contraddice.
I limiti dei modelli categoriali sono evidenziati anche dalla pratica clinica con i DSM.
Ad esempio, nei disturbi di personalità, la comorbilità è la norma piuttosto che l’eccezione. La categoria NAS è sempre più ampia e ciò è un pessimo segno per la validità di un sistema nosografico. Non è chiaro il confine tra tratti di personalità più o meno adattivi e veri e propri disturbi di personalità e neppure tra disturbi di personalità e disturbi di asse I°. Segnali di inefficienza del sistema ci vengono anche da numerosi studi che dimostrano come persino gli psichiatri più tradizionali e ferventi biologisti, adepti alla confraternità del farmaco, nella scelta del trattamento, anche farmacologico, siano guidati più dall’attenzione all’intensità di certe dimensioni che dalla diagnosi categoriale che poi invece sarà esibita nelle presentazioni scientifiche. Per questo non è infrequente assistere alla prescrizione di neurolettici a pazienti depressi o ossessivi in cui i temi di pensieri tendano a distaccarsi dalla realtà. Lo psichiatra sembra più attento ad una ipotetica sottostante ‘dimensione delirante’ che alla diagnosi categoriale. Altrettanto inconsueta può apparire la prescrizione di un AntiDepressivo ad un paziente schizofrenico con prevalenza di sintomi negativi come mirata ad una dimensione di blocco e apatia.
Immagino lo smarrimento momentaneo all’idea di rimanere orfani delle tanto rassicuranti diagnosi e dei loro figlioli più recenti nati dall’accoppiamento con l’ EBM (evidence based medicine), i protocolli di intervento. Molti gruppi nel mondo e la stessa task force del DSM stanno lavorando a classificazioni dimensionali ed io stesso ci ragiono a tempo perso con alcuni colleghi. L’approdo tuttavia non è vicino. E nel frattempo chi ci aiuterà? Mica possiamo aspettare anni. Col prossimo paziente che facciamo? Se va bene il modello dimensionale lo useremo nelle intervisioni a ‘Villa Sigismondo’ la casa di riposo degli psicoterapeuti o per impostare i trattamenti di angeli, arcangeli e trapassati che mi auguro ingarbugliati in problemi diversi.
Per mio conto dopo aver smesso da tempo ho ripreso a fare diagnosi, solo che adesso la diagnosi è costituita dal nome e cognome perché mi sembra che ognuno sia un caso a sé del tutto originale. Il mantenimento del cognome, perché mi sembra che la sofferenza di ognuno sia profondamente radicata nella propria storia personale e familiare transgenerazionale. Non ce la faccio a seguire la scorciatoia della diagnosi e dei protocolli (forse solo perché entrambi non li ho mai studiati abbastanza bene) e costruisco una teoria specifica sul funzionamento di ogni singolo paziente dalla quale consegue un progetto d’intervento fatto su misura, personalizzato. Unico limite alla mia soggettività, l’accordo del paziente su entrambi e, strada facendo, la valutazione di efficacia. Naturalmente anche il ragionamento clinico soggettivo deve seguire delle regole esplicite e condivisibili. Così come il buon artigiano che preferisce vestire i suoi clienti su misura e non vendergli abiti preconfezionati solo da ritoccare, deve seguire le linee guida della buona sartoria ed utilizzare materiali di qualità.
La spiegazione della sofferenza individuale la formulo nei termini di una psicologia scopi- credenze che ha il vantaggio di essere semplice e comprensibile a tutti essendo il modo naturale in cui ci spieghiamo sin da bambini il comportamento degli esseri umani. In estrema sintesi, le operazioni che compio sono due.
In primo luogo cerco di definire l’assetto motivazionale del paziente ovvero gli scopi (stati desiderati di sé e del mondo che persegue) e i cosiddetti antiscopi ( stati temuti di sé e del mondo che rifugge) che, sono certo, in psicopatologia sono più importanti dei primi. Le emozioni del paziente che sono ciò che lo spinge in terapia si muovono verso il positivo (gioia, soddisfazione, sicurezza) quanto più ci si avvicina agli scopi e ci si allontana dagli antiscopi e, viceversa si tingono di negativo (ansia, tristezza, colpa, vergogna, ecc) quando avviene l’opposto.
In secondo luogo indago le strategie di perseguimento degli scopi e quelle di fuga dagli antiscopi. Insieme esse danno un’idea del funzionamento premorboso del soggetto e consentono normalmente di prevedere il comportamento del paziente (la precisione di tali previsioni misura l’accuratezza del modello ipotizzato).
In terzo luogo vado a ricercare come mai il sistema non funziona più producendo sofferenza ed in genere ciò è dovuto ad un conflitto tra due o più strategie che se servono ad uno scopo ne danneggiano un altro (a tal proposito si veda il ciottolo 2: complicati rapporti tra mezzi e fini). Questi primi tre passaggi riguardano, di fatto, ancora esclusivamente l’assessment, ma l’acquisizione di consapevolezza, in tutte le psicoterapie di qualsiasi scuola è propedeutica al cambiamento.
L’intervento vero e proprio è all’insegna dell’ampliamento e si pone l’obiettivo di aumentare i gradi di libertà del sistema.
In primo luogo, l’intervento di più basso livello, mantenendo inalterato l’aspetto motivazionale di scopi e antiscopi cerchiamo (il plurale perché il paziente è il protagonista) di eliminare le strategie inefficaci o troppo costose e di inventarne delle altre (si mantiene lo stesso bersaglio ma ci si attrezza con nuove e più numerose frecce).
In secondo luogo cerchiamo di ampliare l’assetto motivazionale con tre operazioni:
- Eliminare vecchi scopi che il soggetto ha ereditato dalla sua famiglia o dalle esperienze infantili ma che costituiscono ormai soltanto una zavorra non più adattiva.
- Ampliare il portafoglio degli scopi attingendo dai desideri e bisogni individuali.
- Decatastrofizzare gli antiscopi e possibilmente volgerli in scopi positivi.
Il ciottolo finisce qui. Ora però per dar sfogo all’ossessivo classificatore che ho represso in me e farmi perdonare dai lettori che ho reso orfani delle diagnosi categoriali metto in appendice in corsivo una classificazione degli esseri umani secondo categorie meno consuete e più bizzarre.
Appendice:
Il mondo è bello perché è vario
Psichiatri e psicologi hanno sempre cercato di classificare gli esseri umani. La smania classificatoria è connaturata all’uomo e lo aiuta ad orientarsi in un mondo altrimenti caotico ed imprevedibile. Piante. animali, minerali e quant’altro sono stati suddivisi in specie, razze, famiglie e via via aggregati sempre più piccoli fino ad arrivare al singolo individuo inconsapevole delle sue appartenenze multiple. Lo stesso furore classificatorio si è abbattuto anche sui prodotti umani e non naturali. Si pensi al linguaggio e all’analisi logica e grammaticale. Ai numeri (razionali, irrazionali, interi, primi) alle figure geometriche e anche alle opere d’arte (espressionismo, classicismo, cubismo e via discorrendo). Quasi tutte le classificazioni seguono il criterio categoriale. Cercano di far ordine tra gli oggetti della realtà distribuendoli in cassetti discreti ben distinti tra loro. All’interno di un cassetto più grande esistono poi altri cassetti più piccoli che operano ulteriori sotto-distinzioni. Nel grande cassetto che include i viventi e dal quale sono esclusi gli oggetti e gli elementi naturali inanimati esistono due grandi sottocassetti: le piante e gli animali. Nel sottocassetto delle piante si è sbizzarrito Linneo. Gli esseri umani stanno nell’altro, insieme a leoni, pipistrelli, zanzare, armadilli, pitoni, batteri.
Il guaio è iniziato al momento di suddividere ulteriormente il cassetto degli uomini. I biologi hanno iniziato a distinguere le varie razze appartenenti alla stessa specie Homo sapiens sapiens. Gli psicologi si sono avventati sulla mente del sapientone (sapiens sapiens) per distinguerne i vari tipi. Qui sono nate le classificazioni psichiatriche. Le varie nosografie le malattie mentali. Parallelamente gli umani nella vita di tutti i giorni usavano categorie più semplici ma efficaci per orientarsi. Simpatico- antipatico, generoso- egoista, intelligente- stupido, sincero- bugiardo, forte- debole. La differenza tra i due modi di ordinare la realtà sta nel fatto che quello scientifico è appunto categoriale, a cassetti discreti e discontinui. Quello naif è dimensionale per cui si può essere in un punto qualsiasi del continuum tra simpatico ed antipatico. Si può esserlo più o meno. Tentare una classificazione dimensionale scientifica è sfida cui non sottrarsi al termine di una vita di studio della mente umana e dunque mi avvio al compito. Volontariamente non utilizzerò la distinzione categoriale tra maschi e femmine pur utilissima nella vita quotidiana.
La prima distinzione fondamentale che non è una duplice categoria ma una dimensione, è quella dell’intelligenza vs stupidità. L’intelligenza è la capacità di cambiare il proprio assetto di fronte alle mutate contingenze ambientali. Intelligenza è sinonimo di elasticità, adattabilità, cambiamento. Va spesso associata alla curiosità. Gli intelligenti sono vivaci, mai noiosi, divertenti. Spesso anche belli. La stupidità da l’idea dell’inanimato del non vitale. E’ stabilità, fermezza, solidità rocciosa. Gli stupidi tendono a fuggire le novità, sono conservatori, temono il cambiamento. Siccome non capiscono la realtà ne hanno paura. Sono noiosi, lamentosi, aggressivi. Esteticamente hanno una prevalenza di sviluppo in orizzontale, bassi e larghi.
La seconda dimensione ha come due estremi gli ombelicali (che vedono solo il proprio ombelico) e gli sbalconati (sempre protesi verso gli altri). Gli ombelicali pensano di essere la misura e il centro dell’universo. Ciò che è bene per loro è il bene assoluto. Ciò che reputano giusto è la giustizia assoluta. Gli sbalconati al contrario perdono il baricentro proprio mettendosi nei panni degli altri. Si immedesimano talmente tanto da non sapere più chi sono e cosa vogliono. Gli ombelicali si piacciono e si curano fisicamente ma attraggono poco perché non trasmettono interesse per l’altro, esca fondamentale dell’innamoramento. Gli sbalconati sono in genere trascurati non preoccupandosi di sé stessi e sempre impegnati a fare regali agli altri. Loro hanno senso in quanto strumento al servizio dell’altro come invece per gli ombellicali gli altri sono solo oggetti di servizio o al massimo specchi di sé.
Non è una dimensione che ha a che fare con l’egoismo e l’altruismo ma semmai con qualcosa di più basilare come l’egocentrismo. Per essere degli efficienti egoisti è utile non essere del tutto egocentrici. Per utilizzare gli altri, manipolarli, ingannarli, occorre mettersi nei loro panni. Quest’ultima dimensione non coincide a sua volta con la tradizionale e infantile distinzione tra buono e cattivo. L’egoista persegue il suo interesse e attacca l’altro se rappresenta un ostacolo al suo successo. Il cattivo fa del male gratuitamente, anzi talvolta investendoci delle risorse. Per questo il cattivo puro spesso è anche stupido. Inutile aggiungere che gli ombelicali pensano di avere sempre ragione e vivono in un mondo di certezze assolute mentre gli sbalconati sono amleticamente dubbiosi e incerti.
Ancora gli esseri umani possono essere schienati o vedette. Gli schienati vivono rivolti al passato gonfi di rimorsi, rimpianti e nostalgie che dispensano a piene mano agli ex (compagni di scuola, compagni di battaglione, compagni di sventura, coniugi, amici) tutto purché ex. Sono persone che ricercano la continuità, il ripetersi, i film cult da vedere e rivedere. Spesso la loro vita è la replica ripetuta alla noia dello stesso atto unico. Le vedette sembrano uscite dall’uovo di Pasqua. Sono appena arrivate ed hanno tutto il futuro davanti. Sono uomini di progetto, di speranze, have a dream e di paure. Tendono ad essere rivoluzionari a rompere con le tradizioni. Considerano la novità un valore aggiunto in sé indipendentemente da ciò che sia. In questo sono come dei bambini entusiasti; al contrario degli schienati che sembrano vecchi centenari che tutto hanno già visto e non conoscono più sorpresa e meraviglia.
Solo apparentemente più superficiale è la dimensione lepre – tartaruga. Le lepri vanno di fretta, si avvantaggiano ‘perché non fare subito una cosa che comunque andrà fatta?‘. Le Tartarughe assaporano il cammino e se c’è un sol motivo per dilazionare lo fanno di certo. Le lepri avvantaggiandosi con tutto si spicciano presto anche con la morte e sistemano presto la questione. le tartarughe notoriamente invecchiano a lungo. Entrambi sono insofferenti con la polarità opposta.
Decisamente più sostanziale è la dimensione viscerale- meningeo. Il viscerale sa di avere un corpo, ne va fiero e lo cura. Sente il freddo e il caldo, la fame, la sete e il sonno e i piaceri connessi al corpo. Gode dei sapori, degli odori, dei colori e apprezza l’esercizio delle pratiche connesse alla riproduzione, anche destituite di tale scopo. Il meningeo utilizza il corpo solo come sostegno del cervello. La realtà in cui vive e per cui si emoziona è una rappresentazione della realtà. Non si sporca con le cose ma lotta con le idee. Non fa sesso ma sessuologia, non vive ma parla della vita, spesso con maestria e competenza. Ha disgusto della materialità. Gli organi di senso sono atrofici E’ cittadino del mondo platonico delle idee. Amabile conversatore, è inadatto alla sopravvivenza fuori da un’aula o da un salotto.
L’aspetto del meningeo è trasandato quanto curato il suo eloquio. Tra le dimensioni più importanti c’è quella talebano – romano. Il talebano prende tutto maledettamente sul serio. Fa le cose fino in fondo, ci crede veramente. E’ tutto d’un pezzo. Non scherza con le cose serie che per lui sono tutte. Se è di sinistra farà il brigatista. Se è cattolico si accoppia secondo le indicazioni vaticane. Se ha un vizietto diventa drogato all’ultimo stadio e poi convertitosi farà l’operatore nelle comunità per tossici più intransigenti e severe. Non è uomo dalle mezze misure. E’ sempre in buona fede ed in nome di ciò può commettere i crimini più orrendi a posto con la sua coscienza. E’ geneticamente un estremista e un intollerante. Applica ciò anche ad aspetti marginali come l’alimentazione. Anche qui fa parte di gruppuscoli estremisti che hanno vaste categorie di cibi vietati. Il rigore è elemento essenziale quale che sia la scelta in questione.
Il romano se ne frega, non prende niente sul serio. E’ incapace di indignazione e di slanci. Sa che prima o poi tutto cambia e dunque basta aspettare senza scaldarsi troppo. Il romano ne ha viste troppo, ha una saggezza da sampietrino e lascia che tutto gli passi sopra. Raramente interviene sulla realtà per modificarla, aspetta che si assesti da sé. L’emozione di base è l’indifferenza come per il talebano era l’orgoglio e l’indignazione. Il romano misura le sue scelte operative in termini di fatica che costano e la regola decisionale è il risparmio energetico. Non ama le persone che lo sollecitano ma in compenso non rompe le palle agli altri, vive e lascia vivere. Si badi che il romano non è un abitante di Roma ma una categoria dello spirito. Tuttavia è innegabile che l’amministrazione pubblica è il suo habitat naturale per cui innumerevoli esemplari vengono a riprodursi nella capitale. Tra i suoi sogni proibiti c’è fare il bidello in una elementare o l’usciere al ministero. Ancora gli umani possono essere retti o seghettati. I retti sono coerenti, prevedibili, conseguenti, evolvono secondo un percorso in linea retta. I seghettati cambiano continuamente orientamento, sono mutevoli, indecidibili, inaspettati, sorprendenti. Seppure la retta seghettata ha complessivamente una direzione, il percorso è frastagliato cangiante.
Affettivamente i retti sono fedeli e affidabili, hanno inventato l’indissolubilità del matrimonio. I seghettati hanno vinto il referendum sul divorzio. Anche loro hanno la direzione orientata ad un rapporto stabile e proprio per questo fanno molti tentativi per scegliere il meglio. Sono criticati dai retti, a loro volta derisi dai seghettati. I seghettati cambiano spesso pur non cambiando mai radicalmente. I retti non cambiano apparentemente mai. Poi un giorno nello specchio del bagno non si riconoscono più e coerentemente sparano in bocca all’intruso.
Sempre per restare in ambito geometrico gli uomini si dividono in perimetrali o superficiali e centrali. I perimetrali badano all’esteriorità, a ciò che appare e si vede da fuori. I centrali sono interessati alle essenze al nocciolo duro, al profondo. Spesso fanno gli psicoanalisti o gli speleologi e si occupano di faccende serissime. I perimetrali possono fare gli stilisti, i creativi pubblicitari o i cognitivisti ed hanno sempre un senso di inferiorità rispetto ai centrali perché le loro cose non sono mai essenziali, non è mai questione di vita o di morte ma al massimo di qualità della vita. In un certo senso si invidiano reciprocamente e se condividono l’esistenza possono fare cose importanti divertendosi. I centrali vanno subito all’essenziale e perciò sessualmente sono trascurati rispetto alla periferia dell’atto sia precedente che seguente. La sigaretta post è oggetto di violento rimprovero da parte del perimetrale che invece è molto attento al prima e al dopo.
Completamente diversa è la dimensione che va dai piloti ai passeggeri. I piloti ritengono di avere la piena e totale responsabilità di quanto gli accade. Sono i protagonisti, gli artefici della loro vita. Sentono un fortissimo senso di responsabilità che genera spesso tracotante orgoglio, talvolta penosa colpa. Sentono che tutto dipende da loro. Al contrario i passeggeri sono in balia di un destino che li determina rispetto al quale sono assolutamente impotenti.
Tutto dipende dal caso, dal destino, dagli dei, dalla fortuna. L’emozione di fondo è l’ansia di chi è in balia di forze incontrollabili. La responsabilità, non esiste sopraffatta dall’impotenza. La storia della loro vita è il prodotto di ripetuti scontri con gli eventi esterni. Tutto avviene fuori di loro. La colpa o il merito è sempre degli altri. Loro sono spettatori del loro invecchiare senza infamia ne lode. I piloti anche di fronte alle malattie più maligne combattono convinti onnipotentemente che l’esito dipenda dalla loro determinazione a non morire e rappresentano i pazienti ideali dei medici dediti all’accanimento terapeutico e soprattutto economico. Al contrario i passeggeri che ritengono fermamente che sarà quel che deve essere si lasciano divorare da sparuti gruppetti di batteri o da poche cellule cancerogene che trovano nel loro atteggiamento non interventista un inaspettato alleato.
Voraci e anoressici possono anche essere chiamati stitici e diarroici. I voraci diarroici scambiano molto con l’ambiente sia in entrata che in uscita. Danno e prendono molto. Non passano inosservati agli altri con cui si mischiano facilmente fino a trasformarsi e trasformare l’interlocutore. Il Vorarroico tende sempre a fare un gran baccano, è un po’ sguaiato, evidente, notato. L’anostitico invece sta sulle sue, basta a se stesso. Non ha bisogni da soddisfare con oggetti esterni, vive in un’autarchica autosufficienza. E’ riservato ed elegante, inappuntabile quando si sta con lui si ha l’impressione di essere soli. L’ideale sessuale è la frigidità. Quando la morte lo solleva per portarselo, spesso lo lascia perché si sente gelare, quindi campa moltissimo. Tuttavia anche il vorarroico sopravvive a lungo perché intrattiene gioiosamente la morte che finisce per dimenticarsi cosa fosse venuta a fare. Persino scontata, abusata e banale la distinzione tra formiche e cicale. Le prime portate coattamente all’accumulo per un domani di cui non v’è certezza conducono una vita arida che non si capisce perchè dovrebbero preoccuparsi di prolungare. Se il gelo invernale e la conseguente carestia ponesse fine alle loro sofferenze sarebbe una liberazione per tutti. Per loro il bello viene sempre dopo. Oggi è il tempo del sacrificio, ma domani…. La scuola è dura ma l’università…Si aspetta il lavoro… e poi la gioia arriverà con la pensione. Quando si accomodano nel ligneo contenitore vellutato si dispiacciono soprattutto di non sapere cosa aspettarsi di bello domani. Gli manca un motivo per sacrificarsi oggi.
Le cicale invece, modello negativo da additare per il danno che comportano alle banche a ai custodi dei granai si assaporano il presente e quando arriverà il gelo moriranno cantando a pancia piena. Le cicale affettivamente godono relazioni intense e brucianti e stanno su montagne russe emotive. Le formiche hanno matrimoni duraturi che si consumano lentamente e strangolerebbero il partner secondino. La sessualità cicala è precipitevole, quella formica soporifera e misurata. Gli unici ad avvantaggiarsi del fare formichico sono gli eredi. E’ ben noto infatti che le scaltre cicale tentino, e spesso con successo, di farsi adottare dalle formiche.
Gli umani si distinguono ancora lungo il percorso che va dai solisti ai coristi la cui differenza è intuitiva dal nome stesso. I solisti vanno per proprio conto, dettano le mode, non si guardano intorno, non si preoccupano del giudizio degli altri, l’appartenere non è un loro problema. Sono piuttosto impegnati a distinguersi a differenziarsi. La bizzarria è un pregio, la vergogna ignorata. I coristi pensano di non avere nulla di originale da dire. Sono maestri nel camuffamento, nello scomparire. Non vogliono essere figura ma sfondo, pastore non bambinello. Seguono le mode, si fanno consigliare. Vogliono far parte. Il loro godimento è la tranquillità della perdita di una identità identificabile.
In tutto ciò non c’è alcunché di scelto, è così e basta: è la sindrome del camaleonte. I coristi criticano i solisti per il loro protagonismo con un livore amaro d’invidia. I solisti invece disprezzano apertamente i coristi, presi come sono dal demone della prima fila.
Ad ogni bambino si insegna precocemente a non dire le bugie. Tuttavia la dimensione sincero – bugiardo non è poi così scontata. Stante che non c’è una realtà oggettiva che si impone necessariamente ma tante costruzioni soggettive della stessa realtà il confine diventa labile, incerto, mendace. I sinceri sono dei fotografi che ritengono sinceramente di riportare la realtà così com’è e non come appare loro. Poco importa l’angolatura da dove prendono l’immagine, la luce che scelgono, la sensibilità della pellicola, la carta usata per la stampa, ciò che mettono al centro o ai lati. Quella non è la loro fotografia, quella è la realtà.
I bugiardi non sono fotografi ma pittori. La realtà è uno spunto che siano classici, impressionisti o cubisti. I bugiardi manipolano consapevolmente. Non vogliono comunicare all’altro una cosa esterna senz’anima ma la loro realtà. Chi prova una grande emozione ha bisogno di esagerare nell’esprimere altrimenti l’altro non capirebbe. Lo immaginate un innamorato che dica all’amata: ‘mia cara provo per te un sentimento non ben chiaro ma certamente significativo, è possibile che in questo momento sia tendenzialmente e transitoriamente innamorato di te’. No il termine giusto è ‘sono innamorato perdutamente di te dal momento che ti ho visto, come non lo sono mai stato. E quest’amore assoluto sarà eterno, per sempre ti amerò come oggi’. Sinceri e bugiardi sono complementari come ingegneri e architetti. Senza ingegneri i palazzi crollerebbero, ma senza architetti crollerebbero le anime degli inquilini. A volte i sinceri mentono e quelle sono proprie le bugie che fanno piangere Gesù perché non sono artistiche: sono i tentativi decorativi degli ingegneri.
Abbiamo visto come ogni dimensione abbia le sue emozioni caratteristiche e contrapposte nelle due polarità estreme. Esiste tuttavia una dimensione ulteriore e trasversale che esprime la capacità di provare emozioni più o meno intense. Ad un estremo troviamo i drammatici e all’altro i sordinati . I drammatici non solo manifestano in modo vistoso e istrionico le emozioni ma le provano anche in maniera forte. Nella loro anima non si passa senza necessariamente fare un gran rumore: non ci sono frusci ma solo schianti. Le foglie che cadono fanno un rumore assordante, disastroso segnale della caducità della vita. Un fiore che sboccia è un fuoco d’artificio dirompente che festeggia l’eterna rinascita. I sordinati hanno il volume emotivo quasi azzerato. Si nasce, ci si ama, ci si perde, si muore, con estrema discrezione, senza clamori. Non si piange, si inumidiscono gli occhi. Non si gioisce, si è soddisfatti. I sordinati guardano con disprezzo e superiorità i drammatici. Solo un pizzico d’invidia se ci fanno l’amore ma si ricompongono subito. I sordinati tuttavia si preparano una vita per fare la loro gran bella figura al momento conclusivo e non fare una piega di fronte alla morte. Per loro è una questione di principio un traguardo decisivo non dare soddisfazione alla vecchiaccia e mostrare disinteresse e distacco mentre i drammatici che godevano sguaiati sui letti dell’amore, tremeranno di paura e piangeranno dal dolore. Ma la vecchia che conosce l’animo umano e vuole far da padrona si attrezza. I drammatici se li porta nel sonno inconsapevoli per non sentire strepiti. I sordinati li tortura per mesi con dolori incoercibili, con piaghe purulente e ne umilia in tutti modi la dignità, ne offende la mente, rosicchia il corpo. Loro fanno finta di niente e lei furiosa si accanisce. Sempre più colpi ai fianchi e al volto ma mai il decisivo K.O. Poi quando i sordinati confidano all’orecchio dell’amico che non ne possono più. Quando una goccia salata tracima dal ciglio inferiore sul naso affilato. Allora, solo allora, conclude il lavoro, liberandosi del noioso cliente.
Ancora il paziente è contrapposto a l’intollerante. Il paziente è divino nel suo rapporto con il tempo, vive in una dimensione di eternità. Nel suo eterno presente può aspettare, nulla sfugge. La sua grandezza è la capacità di incassare senza turbarsi. Nei momenti difficili riesce a dissociarsi. Si assenta e ritorna quando gli altri hanno finito. La assenza dissociativa è una sorta di stato mistico. il corpo non sente più niente e la mente dorme. Sa che prima o poi la nottata deve finire e lui resiste con un sorriso ironico che sbeffeggia il nemico che avanza.
Nel loro rapporto con il tempo gli uomini si distinguono anche lungo la dimensione puntualità – ritardatari. Si tratta di caratteristiche assolutamente genetiche e dunque immodificabili dall’esperienza. Il ritardatario ha vinto il tempo, ne ignora il potere, inizia a fare le cose nel momento in cui ha promesso che le avrebbe concluse. Se deve andare ad un appuntamento esce di casa all’ora esatta dell’appuntamento. Si potrebbe pensare che sia disinteressato al disagio dell’altro ma non è così. Non ignora l’altro ma il tempo. Non riesce ad accettare che le sue azioni siano estese nel tempo, che durino. Per lui sono istantanee. Pensiero e azione durano egualmente zero. Il puntuale vuole l’assoluto controllo e calcola tutti i possibili inciampi, ritardi, contrattempi. Il tempo è da lui dominato. Non lo può sprecare ma non è chiaro per cosa risparmiarlo. Che farne. Il tempo peraltro è difficile da conservare, non ci sono contenitori che lo intrappolino. Il tempo corre sempre via e finisce. Il ritardatario lo sa e se ne frega arrendendosi a questa ineluttabile realtà. Il puntuale si ribella e cerca di controllarla. il tempo scodinzola a entrambi beffardo e fugge via.
La psicologia di gruppo si è arrovellata a descrivere le relazioni sociali degli umani in gruppo e la distinzione più utilizzata è quella che distingue i capi dai gregari. Il capo è tale in un gruppo di lavoro, in una assemblea di condominio, nel gruppetto alla fermata dell’autobus, nella tavolata al ristorante. Il capo è tale non perché bada ai suoi interessi ma perché coglie al volo quelli degli altri, li sa unire e promuovere. Il capo è generoso, lui ha un solo interesse, comandare, tutto il resto è per gli altri. Il gregario invece non vuole decidere, fugge le responsabilità e conserva solo il diritto di lamentarsi con il suo capo. Non è affatto inferiore al capo, spesso per molti aspetti è più in gamba. E’ solo disinteressato al comando e a tutti gli impicci che comporta. La distinzione tra capi e gregari è qualcosa di simile seppure non sovrapponibile a quella tra mamme e figli.
La mammità è una dimensione che ha al suo estremo opposta la figlitudine. Le mamme, che siano maschi o femmine è lo stesso, sono accudenti si mettono nei panni del figlio, ne sanno bisogni e desideri ed hanno il loro piacere nel soddisfarli. Hanno uno strabismo congenito che gli consente di vedere il mondo dalla prospettiva del figlio. Il figlio al contrario vede esclusivamente se stesso. Per sopravvivere se ne strafrega dei possibili bisogni degli altri. Il suo compito è affermarsi a discapito degli altri: è violentemente impegnato nella lotta per la sopravvivenza. Le mamme lo guardano compiaciute per la sua forza e la determinazione mentre le fa a pezzi per crescere sano e forte. In questa crudele macchina da guerra loro intravedono il loro successo genetico e ne gioiscono. Mamme e figli si attraggono e non riescono a staccarsi se non quando le mamme muoiono, contente di far spazio su questa terra ai loro cuccioli.
Nei gruppi gli uomini si dilettano in due possibili giochi: la guerra e le costruzioni. Questi due giochi corrispondono a due opposte tendenze dell’animo umano. La guerra esprime la tendenza a competere, a sopraffare l’altro a ordinare il mondo in una scala in cui chi sta più in alto ha più diritto e campa meglio di chi sta sui gradini più bassi. Già tra i cuccioli c’è chi è meno interessato a fare a botte con gli altri e si raccoglie con i compagni per innalzare costruzioni, per costruire attrezzi e giocarci insieme. Questi esprimono la tendenza alla cooperazione, al fare insieme. la storia del mondo è stata sempre segnata da grandi imprese collettive, nella dimensione dell’insieme e da grandi guerre, nella dimensione del contro. I guerrieri restano un po’ più stupidi perché non imparano a fare le cose. Loro se ne appropriano dagli altri che le sanno fare. I costruttori non portano armi di cui hanno paura e sono laboriosi e cordiali. Per fare a botte serve meno cervello che per collaborare. I costruttori debbono ricordarsi come siano i loro compagni e cosa aspettarsi da loro. I guerrieri è sufficiente che picchino alla cieca. Per il successo di una società servono sia i costruttori che i guerrieri che non sono, in genere ostili gli uni con gli altri avvertendo la reciproca complementarietà. Tuttavia il successo di una società dipende fortemente dalle leggi che la governano.
Nel rapporto con le regole c’è un’ulteriore significativa differenza tra gli uomini che possono essere miopi o presbiti. I miopi tendono ad osservare e far osservare le regole minuziosamente e identiche in ogni circostanza. Non ricordano più perché quelle regole fossero state fissate, non gli interessa la loro utilità. Ci sono e vanno rispettate. Le tavole della legge non vanno sottoposte a referendum confermativo. Il rispetto della regola è un valore assoluto in sè. I miopi trovano persino irrispettoso qualsiasi quesito sull’opportunità di questa o quella regola. L’apparato normativo è come la mamma. Senza di lei non ci saremmo e dunque va amata e rispettata quale che sia. I miopi sanno adattarsi meravigliosamente ai cambiamenti anche radicali del sistema di regole. L’importante è che le regole ci siano, non quali siano. Esse sono come la piantina della città nelle mani di un viaggiatore straniero smarrito nella sconosciuta metropoli, indicano ad ogni incrocio la strada da seguire. Guidano ogni passo tenendo a riposo il discernimento personale. Cancellano il dubbio, fugano le responsabilità.
I presbiti, al contrario, traguardano l’orizzonte. Si chiedono qual’è sia la metà che quella regola addita e ci vanno seguendo una loro personalissima strada. Attenti allo spirito e non alla legge che lo incarna si sentono superiori ai miopi e spesso confondono lo spirito della legge con il proprio. L’interesse collettivo con quello personale. Forti del fatto di essere i detentori dello spirito giusto guardano sicuri verso l’orizzonte trascurando cosa calpestino nell’immediato. Per loro il fine giustifica sempre i mezzi. Hanno qualche difficoltà a distinguere l’interesse personale da quello collettivo. Da unti del Signore sono in grado di compiere i crimini più atroci. Cadono dalle nuvole quando gli viene fatto notare perché le loro intenzioni erano ottime. Per loro contano le intenzioni, appunto, e non i fatti. Miopi e presbiti possono cimentarsi per ore in discussioni sull’opportunità o meno di una certa condotta senza avvicinarsi di una spanna: partono da presupposti opposti.
Le società umane come gli stessi uomini nascono, vivono per un certo periodo e poi muoiono.
La nascita è connessa alla riproduzione consistente nel gioioso mescolarsi dei geni. Gli individui si avvistano alla distanza e si scelgono sommariamente. poi manovrano avvicinamenti, si odorano, si strofinano, si assaporano come esperti sommelier. Infine si tuffano l’uno nell’altro e, per alcuni istanti perdono i propri confini. Alla fine dei giochi la ragione ce l’ha chi ha più successo riproduttivo. Chi fa più figli vince e popola la terra. Il corteggiamento non è dunque faccenda marginale, svago del sabato sera, distrazione dagli importanti impegni della quotidianità. Al contrario tutto il restante affaccendarsi è finalizzato ad esso. E’ nella corsa senza esclusione di colpi degli spermatozoi verso l’ovocito che tutto trova significato. Nelle curve tubariche si gioca il palio della vita. La ragione e la verità in realtà si stabilisce a maggioranza e chi ha più elettori vince. Il corteggiamento dunque è faccenda estremamente seria. Anzi l’unica seria.
Sarebbe banale ricordare che maschi e femmine hanno due diverse mercanzie da vendere al gran bazar della riproduzione ma un accenno è utile. Per le femmine è più importante la bellezza segno di una salda capacità riproduttiva: fianchi larghi per partorire e seno florido per allattare. Per gli uomini la capacità di poter proteggere e mantenere la prole e dunque la forza e il potere. Il più preciso indicatore del potere di un uomo è la bellezza della sua compagna e viceversa. Stante la diversità delle merci da scambiare al gran bazar le strategie per conquistare il mercato possono essere diametralmente opposte : ci sono gli espositori e i celanti. Gli espositori mettono in mostra la loro merce vi fanno splendere sopra il sole. Richiamano con grida l’attenzione degli avventori, invitano alla prova. Ritengono che la pubblicità sia il fondamento del successo e che la quantità sia più importante della qualità. Sono le donne in bikini succinti o con le piume di struzzo e i gioielli, i rossetti vistosi e i profumi assordanti. Sono gli uomini con le auto di lusso, con i servitori intorno, con divise altezzose o moderni scettri e corone, rolex e imbarcazioni e soprattutto una moltitudine di altri intimoriti: l’uomo potente incute timore. La paura negli occhi degli altri è una misura certa del suo potere. Gli espositori maschi e femmine si attraggono reciprocamente. L’uno diventa per l’altro oggetto da esporre: i tacchi a spillo ticchettano gioiosi al seguito di pesanti stivali, le calze a rete si imprimono volentieri sui sedili di pelle morbida delle Maserati.
I celanti invece hanno una innata tendenza a nascondere. Vogliono che sia l’altro ad impegnarsi in una faticosa ricerca del tesoro che sanno essere in loro. Ritengono che la qualità della loro merce sia così superiore da non necessitare di alcuna pubblicità. Scelgono un basso profilo che non esprime autentica modestia quanto piuttosto smisurato orgoglio. Le donne sono acqua e sapone, scarpe basse, gonna castigata o persino pantaloni senza ammiccamenti. Indaffarate in altre faccende, apparentemente disinteressate all’effetto che fanno sui portatori di gameti complementari. Attente a ricomporre i lembi della gonna che risalgono le ginocchia e lascerebbero spiragli tra la coscia e la poltrona. Avvezze a raccogliere gli oggetti flettendo le ginocchia e accucciandosi verso terra piuttosto che a piegarsi con il busto in avanti estroflettendo il sedere che sanno avere l’effetto di uno starter sui partecipanti al palio della vita.
Gli uomini celanti apparentemente disinteressati al potere, spesso di sinistra, gentili e talvolta un po’ femminili, miti, pacati, comprensivi, porgenti l’altra guancia. Odiano le divise e prediligono le uniformi che non sono la stessa cosa. Le prime dividono, distinguono. Le seconde assimilano, omogenizzano Anche i celanti sanno riconoscersi e si attirano tra loro ma soprattutto fuggono con repulsione dagli espositori per i quali provano sincero disgusto. Quando si incontrano il loro scambio, in quanto apparentemente non cercato e casuale, quasi disinteressato, è ancora più esplosivo e travolgente. Le cosce avvezze alla chiusura monastica e i seni normalmente celati da addobbi quaresimali intonano festosi canti pasquali al momento dell’incontro con il loro paziente scopritore. Lo speleoarcheologo gioisce nell’intimo del suo ritrovamento ma vuole tenere lontani i curiosi. La sua gioia è tanto più grande quanto più resta intima e privata.
Tra il momento della nascita a quello della morte c’è un periodo più o meno lungo che consiste nella vita. Questa parentesi può essere vissuta come carnevale o piuttosto come quaresima. I carnevaleschi si permettono di tutto, sghignazzano, ridono e si divertono per ogni sciocchezza. Non prendono nulla sul serio, scherzano sulla vita e sulla morte. Sono disordinati e caotici. Afferrano ciò che desiderano senza temere le conseguenze. Sembrano non avere nulla da perdere, sono orgogliosi e non si scusano mai. Spesso arroganti e volgari. Agli occhi dei quaresimali sono dissoluti e tristi. I quaresimali invece si trattengono. rinunciano in vista di un bene maggiore. Il piacere è sempre rimandato al futuro ed è frutto di un premio, di una concessione. Sono artisti della frenata, si esaltano nel digiuno e nell’astinenza. Si regalano cilici e penitenze raffinate in attesa della conquista del premio. I migliori arrivano pure a rinunciare all’attesa della ricompensa finale. La rinuncia da strategia si fa scopo. Hanno il timore di scoprire alla fine che il grande arbitro sia un enorme clown.
Come in un quadro di Caravaggio i tenebrosi e i solari si dividono la scena della vita. Gli uni senza gli altri non risalterebbero scomparirebbero in una insignificante tonalità di grigio. I solari hanno larghi sorrisi, pensieri che traspaiono sui volti, movimenti ampi e inequivoci. Sono di una decisione che viene scambiata per forza e persino per bontà. La gente tende a fidarsi di loro dimentica che Lucifero era uno di loro, spendente e al centro della scena.
I tenebrosi sanno che ogni astro luminoso ha una faccia nascosta più affascinante e meno svergognata. Nel quadro sanno di avere il ruolo di sfondo su cui far risaltare il solare di turno. Si dispiacciono solo quando vengono identificati con il losco, la cattiveria, la cupezza. Allora possono giungere a fare molto male ma solo per rivendicare il loro ruolo di servi della luce. Nel caso di questa dimensione gli estremi si attraggono con una certa frequenza. Ognuno ha bisogno dell’altro per risaltare. Molte coppie sono formate da un solare e un tenebroso, ognuno al servizio dell’altro.
E’ evidente anche ai non addetti ai lavori che molte delle dimensioni finora descritte si presentano in associazione tra loro con indici di correlazione più o meno forti. Il loro intrecciarsi con delle ripetitività è alla base dei nostri pregiudizi ed anche della possibilità di fare previsioni sugli esseri umani.
Così per alcuni se si è intelligenti molto probabilmente si sarà anche vedette, centrali, lepri, romani, sordinati, celanti, costruttori e presbiti Per altri invece i piloti saranno anche retti e solari. Le combinazioni possibili sono tante quante gli stessi esseri umani ed è questo il motivo per cui l’insufficienza di qualsiasi classificazione categoriale ci ha spinto a questo incompleto e parziale tentativo di classificazione dimensionale.
RUBRICA CIOTTOLI DI PSICOPATOLOGIA GENERALE