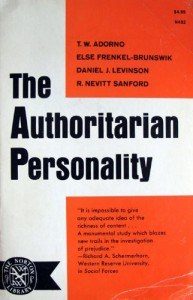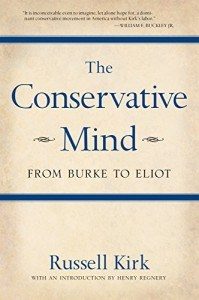Dalla finestra di Johari al phubbing: relazioni sempre più social
Questo articolo propone una breve analisi delle ormai sempre più presenti relazioni virtuali, iniziando con una riflessione a partire dal modello de ‘La Finestra di Johari‘, e concludendosi con la disamina di un fenomeno sempre più frequente: il phubbing, termine coniato dagli americani che deriva dall’unione di due parole, phone (telefono) e snubbing (trascurare).
Laura Marchesini – OPEN SCHOOL, Studi Cognitivi Modena
Introduzione
L’ampia diffusione che i social network e le tecnologie di Rete stanno avendo nella costruzione di relazioni online pone una serie di interrogativi sulla natura dei nostri rapporti affettivi e romantici, su cosa ci aspettiamo da questi e su come si ripercuotono sulla nostra vita quotidiana, reale (Manca, 2014).
Nel 1995 lo psichiatra Ivan Goldberg avanza la proposta provocatoria di individuare una categoria diagnostica precisa per creare una nuova classe nosografica, da poter inserire nel DSM-IV: l’Internet Addiction Disorder, cioè la dipendenza patologica da Internet. Nello stesso periodo, Kimberly Young, si occupa dei disagi che l’utilizzo eccessivo della Rete sembra comportare in alcuni soggetti più a rischio. Essa raccoglie sempre più numerose testimonianze di persone che non riescono a scollegarsi dalla Rete, che vi trascorrono anche 10 ore al giorno, costruendosi un vero e proprio mondo virtuale sostitutivo, dove incontrare altre persone, innamorarsi, giocare, studiare: tutto ciò avviene spesso a scapito della vita reale off-line, provocando problemi coniugali, il deteriorarsi dei rapporti sociali fino ad arrivare ad una graduale chiusura verso il mondo e la realtà. Queste persone riferivano di manifestare ansia ed irritabilità se gli veniva impedito di navigare su Internet e quando erano scollegati, non vedevano l’ora di collegarsi di nuovo con la Rete (Young, 1999).
Questo articolo si propone di fare una breve analisi di quelle che sono le caratteristiche della comunicazione in Rete e delle ormai sempre più presenti relazioni virtuali, sottolineando le differenze tra questo mondo e quello reale, fisico.
L’articolo inizia con una riflessione a partire dal modello di Luft e Ingham (1955) de ‘La Finestra di Johari‘, in seguito analizza le caratteristiche della comunicazione in Internet per poi delineare le discrepanze, a livello di interazione umana, tra realtà virtuale e fisica. L’articolo si conclude con la disamina di un fenomeno sempre più frequente, in cui tutti quanti noi ci siamo probabilmente trovati, come spettatori o come protagonisti: il phubbing, termine coniato dagli americani che deriva dall’unione di due parole, phone (telefono) e snubbing (trascurare). Questo comportamento indica l’atto di trascurare qualcuno, mentre si è in sua compagnia, dedicandosi al proprio telefono. Tale fenomeno di massa possiamo dire essere il punto di arrivo, il culmine della società che vuole essere sempre più connessa in Rete, sui Social Network e sulle chat anche quando fuori casa, anche quando in compagnia di amici, conoscenti, colleghi di lavoro e addirittura partner. Come se non ci si potesse scollegare nemmeno un secondo dal mondo virtuale, come se realmente quel mondo finto, illusorio fosse arrivato ad essere più soddisfacente di quello quotidiano, materiale, fatto di sguardi, fatto di contatti fisici, fatto di discussioni, di risate, di carezze, di vicinanza fra persone in carne ed ossa.
La Finestra Di Johari
Negli anni ’50 due ricercatori americani, Joseph Luft e Harry Ingham (1955) idearono un modello che descrive il processo dell’interazione umana in modo semplice, efficace. Il modello, chiamato Finestra di Johari, si costituisce di un pannello che somiglia ad una finestra diviso in 4 quadranti, che rappresentano diverse aree della consapevolezza umana e che si allargano o si restringono a seconda dei processi dinamici che regolano le interazioni. Il primo quadrante è l’ ‘Area pubblica‘, si riferisce a tutto ciò che sia noi che gli altri conosciamo di noi, quindi le informazioni più superficiali come il genere, lo status sociale, le caratteristiche fisiche. Il secondo quadrante è l’ ‘Area cieca‘ ed è formato dalle cose che gli altri vedono di noi, ma di cui noi non siamo consapevoli, ossia le impressioni che facciamo agli altri, l’idea che diamo di noi stessi. Il terzo quadrante è chiamato ‘Area privata‘, cioè quello che noi sappiamo di noi stessi ma che preferiamo non rivelare agli altri; è l’area formata dai nostri sentimenti, emozioni, paure. Infine il quarto quadrante è definito ‘Area buia‘ e rappresenta gli aspetti di noi che sono sconosciuti sia a noi che agli altri. Sono inclusi i sentimenti, le attitudini inesplorate, che fanno parte di noi ma che sono ignoti (Senna, 2011).
La dinamica del modello della
Finestra di Johari è regolata da due processi che agiscono reciprocamente: l’autorivelazione e la richiesta di feedback. L’autorivelazione è quel meccanismo per cui una persona condivide e rivela aspetti di sé, che conosce, agli altri. Questo comporta un ampliamento dell’area pubblica e un restringimento di quella privata. La prima volta che incontriamo una persona, l’Area pubblica non sarà molto grande, ma mano a mano che la conoscenza aumenta, se si crea fiducia, si condivideranno più informazioni. Il feedback è il processo attraverso cui io divento più consapevole di ciò che riguarda me stesso attraverso i rimandi che gli altri mi comunicano relativamente ad aspetti di me. Ciò comporta un restringimento dell’ area cieca a favore di quella pubblica. Concludendo, quello che emerge è che sia il feedback che l’autorivelazione funzionano solo nella misura in cui le persone coinvolte interagiscono costruttivamente, e che l’obiettivo è l’ampliamento dell’area pubblica per permetterci di sentirci più liberi di essere noi stessi e di percepire gli altri come sono realmente; aumentando la fiducia reciproca ci si sente più sicuri e meno vulnerabili e quindi diminuisce il bisogno di nascondere sentimenti e pensieri rilevanti (Luft; Ingham, 1955).
Le relazioni virtuali e le discrepanze con la comunicazione reale
Ora come ora Internet, la Rete, rappresenta probabilmente il mezzo di comunicazione principale, il computer svolge il ruolo di medium che ha rivoluzionato i sistemi e le modalità di comunicazione.
Quando parliamo di comunicazione attraverso Internet parliamo di CMC, Comunicazione Mediata da Computer e intendiamo quella che permette di mettere in connessione, attraverso strumenti informatici, punti tra loro lontani, senza che questa relazione si realizzi secondo un rapporto di tipo gerarchico (Belloni, 2002). Fra i sistemi di comunicazione online disponibili attualmente quello che ha certamente portato il maggior numero di innovazioni è certamente costituito dai sistemi di chat-line.
La chat può essere considerata un vero e proprio salotto virtuale: un luogo dove è possibile dialogare liberamente e senza freni inibitori e dove le persone mostrano in parte ciò che sono o che vorrebbero essere. Nel cyberspazio ciò che scriviamo ci identifica: la soggettività di ognuno è il personaggio della trama che vogliamo raccontare. Fantasie e bugie, dolori e felicità, solitudine e perversioni possono mescolarsi tra di loro, facendo nascere un personaggio ad hoc, adattabile alle varie situazioni (Troiano, Petrone, 2001). Gli ambienti di conversazione virtuale rappresentano una sorta di teatro, un palcoscenico dove gli interlocutori possono mettere in scena i loro personaggi.
Nulla ci impedisce, nelle relazioni virtuali, di essere ciò che vorremmo essere o diventare, di dare forma a uno dei nostri Sé possibili. Tuttavia in questi ambienti viene a mancare, a primo impatto, il sentimento di fiducia (Roversi, 2004) che viene conquistata pian piano, quando vengono aperti altri canali di comunicazione più personali che consentono di verificare più a fondo la verità degli interlocutori (telefono, scambio di foto o conoscenza reciproca nella vita reale) o più semplicemente quando le relazioni virtuali in chat si protraggono nel tempo, permettendo a ciascuno dei soggetti di acquisire più informazioni sull’altro.
La semplicità con cui le relazioni virtuali significative vengono strette all’interno dei contesti della Comunicazione Mediata da Computer è da ricercare nell’intersezione fra i fattori che agevolano la costituzione di queste nella vita reale e le specificità tecniche del mezzo, che da limiti strutturali si trasformano in vere e proprie risorse (Castrovilli, 2004):
1. Prossimità vs frequenza di intersezione
Le chat annullano le distanze fisiche fra gli utenti, vicini di casa o distanti migliaia di chilometri, per interagire via Comunicazione Mediata da Computer gli interlocutori digitano sempre e solo sulla tastiera davanti ad uno schermo. La vicinanza fisica di una persona si traduce pertanto, nelle relazioni virtuali, nella frequenza con cui questa si incontra in rete (Wallace, 2000). L’assenza del corpo e della comunicazione non verbale è significativa perché facilita comportamenti disinibiti. (Pravettoni, 2002); l’apparato fisico non è messo in gioco e non ci sono vincoli spazio-temporali, perciò la mente può prendersi maggiori libertà (Di Maria, Canizzaro, 2001).
2. Attrazione fisica vs mancanza di contatto visivo
Nella vita reale il grado di piacevolezza fisica di un individuo, la cosiddetta bella presenza, è in grado di influenzare le aspettative che gli altri hanno nei suoi confronti. Inutile negare che nelle situazioni vis à vis basta un’impressione iniziale dell’altro per decidere se portare avanti o meno la relazione (Sunnafrank, 1986). Tutti gli aspetti del Sé ecologico (bellezza, modo di vestirsi, di muoversi, di atteggiarsi) possono influire sulla prima impressione che viene formulata verso un soggetto. Se ci lasciassimo condizionare sempre da questa è evidente che tutte le persone che non rientrano nella nostra rappresentazione mentale di ‘bell’aspetto’ verrebbero automaticamente tagliate fuori dalle nostre prospettive. Infatti, secondo la letteratura classica (Bargh et al., 2002), chi va in cerca di relazioni intime su Internet è soprattutto chi si sente inibito da insicurezze relative al proprio aspetto fisico o da ansia sociale. Da questo punto di vista i rapporti online, basati sulla distanza fisica, su una grande vicinanza emotiva e su una forte idealizzazione dell’altro, sembrano essere motivo di maggiore soddisfazione rispetto a quelli basati sulla vicinanza fisica (McKenna et al., 2002).
3. Apertura all’altro
L’anonimato e il minore autocontrollo possono favorire, nelle relazioni virtuali, il rapido svilupparsi di forme di intimità tra gli utenti in quanto questi, meno condizionati da vincoli sociali e timori reverenziali verso l’altro legati ad attitudini personali (per esempio la timidezza), negli ambienti della Comunicazione Mediata da Computer si comportano in maniera più disinibita. Mentre nel mondo reale il processo di conoscenza e apertura reciproca è normalmente graduale e lo svelamento di informazioni procede di pari passo con l’aumento della fiducia, in Rete le persone tendono a rivelarsi molto più facilmente talvolta anche a persone quasi sconosciute. Secondo alcuni autori (Gross, Acquisti, 2005), si può parlare di una nuova forma di intimità che consiste nel condividere informazioni personali con un numero potenzialmente sconosciuto di persone che comprende sia amici che estranei.
3. Il Phubbing
Siamo sempre più connessi in Rete, sempre più presenti sui Social Network e su Whatsapp, sempre più aggiornati su quello che succede nella vita di chi non conosciamo o conosciamo poco, mentre magari siamo all’oscuro di ciò che sta vivendo chi divide con noi le quattro mura in cui abitiamo. Allo stesso modo, spesso capita che sappiano più cose di noi proprio quei mezzi conoscenti che abbiamo come amici su Facebook, rispetto alla nostra vera famiglia. Abbiamo lo smartphone sempre vicino, a casa, a lavoro, in palestra, in bagno, quando usciamo con gli amici, quando usciamo a cena con il partner, anche mentre stiamo dialogando con qualcuno che magari ci sta raccontando di attraversare un momento di difficoltà e si confida con noi per sentire il nostro parere o per ricevere una parola di conforto…
Alzi la mano chi non si è mai trovato, come spettatore o come protagonista, al tavolo con un amico, un famigliare o il partner e l’altro passa buona parte del suo tempo a rispondere ai messaggi sulle chat, o a postare foto/commenti su Facebook, Twitter, Instagram, a controllare pedissequamente il cellulare appena arriva un minimo suono da parte di quel suo ‘compagno inseparabile di vita’.
Gli Americani hanno coniato un nuovo termine per descrivere questo atteggiamento: phubbing. Si tratta di una parola che deriva dall’unione di due termini, phone (telefono) e snubbing (trascurare). Il phubbing, quindi, indica l’atto di trascurare qualcuno, mentre si è in sua compagnia, per dedicarsi al proprio telefono. È un fenomeno relativamente nuovo, che ancora ha ricevuto poca attenzione dal mondo della ricerca. Recentemente però è stato pubblicato un articolo su un giornale americano Computers in Human Behaviour (2016) intitolato ‘La mia vita è diventata la principale distrazione dallo smartphone: phubbing e soddisfazione relazionale tra partner‘ (Roberts, David, 2016) su uno studio, svolto presso la Hankamer School of Business della Baylor University, volto a indagare il phubbing messo in atto nei confronti del proprio partner, e l’impatto di questo comportamento nella vita di coppia e del singolo. Gli autori hanno costruito un questionario ad hoc somministrato a un campione di 145 partecipanti. Ecco qualche domanda del questionario:
- Quando lo smartphone del mio partner suona, lui/lei lo estrae anche se siamo nel bel mezzo di una conversazione;
- Il mio partner dà uno sguardo al suo smartphone mentre mi parla;
- Se c’è una pausa durante la nostra conversazione, il mio partner controlla il suo smartphone.
I risultati indicavano che il phubbing aumentava la frequenza dei conflitti relazionali dovuti all’uso del cellulare. Questi conflitti diminuivano poi il livello di soddisfazione nella coppia e, di riflesso, il più generale livello di soddisfazione di vita. Ciò aveva infine un effetto anche sul livello di depressione del partner. Questo effetto del phubbing è ancora più forte nei partner con uno stile di attaccamento di tipo ansioso. Dei 145 partecipanti alla ricerca, il 46% aveva dichiarato di avere un partner con comportamenti indicanti phubbing, il 23% dichiarava che ciò causava conflitti nella coppia, il 37% dichiarava di essersi sentito triste o depresso qualche volta a causa di questi aspetti (Roberts, David, 2016).
Conclusioni
Alla luce di un modello dell’interazione umana come la Finestra di Johari, risalente agli anni ’50, diventa lecito chiedersi se processi come l’autorivelazione e il feedback possano ancora funzionare oggi, con i nuovi strumenti comunicativi.
Ormai risulterà difficile tornare indietro, i Social Network e tutti i suoi ‘fratelli’ fanno parte della nostra vita. Sta al buon senso di ciascuno di noi decidere come e quando utilizzarli, con che frequenza, in quali contesti. Diventa difficile pensare che il fenomeno del phubbing possa diminuire, dal momento che sempre più spesso nei ristoranti, nei bar e in qualsiasi locale si può notare un cartello più o meno grande con su scritto ‘Free Wi-Fi‘ che solleva l’umore di tutti coloro che non possono fare a meno della propria vita virtuale. Auguriamoci solo di non arrivare al punto di comunicare attraverso chat anche all’interno delle nostre stesse quattro mura.