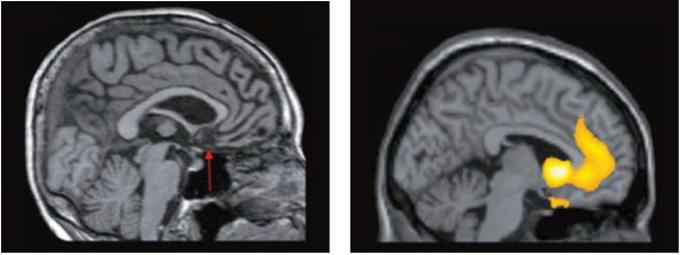Presenza di comportamenti aggressivi e prosociali in bambini con diverso status sociale: popolarità e aggressività
Negli studi che indagano la relazione tra popolarità e aggressività, vengono misurate aggressività diretta (la quale include assalti fisici e verbali) e aggressività relazionale (include azioni quali ignorare, escludere, sparlare di qualcuno) in modo separato. Lo studio di LaFontana e Cillessen (2002) mostra un’associazione positiva della popolarità con entrambe le forme.
Pastore Valentina, OPEN SCHOOL SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA E RICERCA DI MILANO
L’importanza delle relazioni con i pari
L’osservazione di un gruppo di bambini in un parco giochi o all’interno di una scuola, evidenzia con chiarezza la presenza di comportamenti molto diversi rispetto alle modalità con cui i bambini interagiscono e si rapportano agli altri, le quali a loro volta riflettono specifiche condizioni sociali all’interno del gruppo dei pari.
Le relazioni con i pari sono in grado di rivelare i meccanismi messi in atto per affrontare il mondo sociale; tali meccanismi sembrano essere stabili negli anni e possono contribuire a prevedere lo sviluppo di futuri problemi di adattamento.
Le relazioni sviluppate con i coetanei, essendo di tipo orizzontale, sono caratterizzate da simmetria, sono di tipo reciproco e finalizzate ad offrire al bambino l’opportunità di apprendere le abilità di cooperazione, competizione, condivisione e assunzione di ruoli (Hartup, 1983).
All’interno delle interazioni tra bambini è possibile osservare comportamenti socialmente disfunzionali tra cui comportamenti aggressivi, ma anche comportamenti di aiuto e cooperazione, meglio conosciuti come comportamenti prosociali.
La posizione sociale nel gruppo dei pari
All’interno del gruppo dei pari si creano delle strutture ben precise legate agli scopi comuni, alle norme e alle caratteristiche individuali dei singoli membri e alle preferenze o antipatie che vengono a crearsi (Bombi & Cannoni, 2000).
Già a partire della scuola dell’infanzia si formano gerarchie sulla base delle preferenze e dei rifiuti che ciascun bambino esprime nei confronti dei compagni, su tale base, ogni bambino occupa un posto preciso all’interno del gruppo. Questa posizione, definita “status sociometrico”, rappresenta la posizione che un bambino occupa all’interno del gruppo dei coetanei. Esso viene definito in base al grado in cui ogni soggetto piace oppure non piace ai suoi pari ed è l’indicatore più usato per valutare l’adattamento sociale (Di Norcia, 2009).
All’interno del gruppo dei pari i bambini possono assumere posizioni diverse, che vanno dall’essere popolari, all’essere rifiutati.
Generalmente i bambini popolari sono ammirati poiché capaci di prendere in considerazione i bisogni dell’altro, di offrire aiuto nel caso in cui un loro coetaneo sia in difficoltà, di mantenere il proprio punto di vista senza imporsi con forza. Questi soggetti sono inoltre considerati dei buoni leader e sono disposti a condividere le proprie cose, sono poco aggressivi e predisposti alla messa in atto di comportamenti prosociali (Coie, Dodge, Coppotelli, 1982; Hayvren & Hymel, 1984; Newcomb & Bukowski, 1983).
I bambini rifiutati si collocano all’estremo opposto del continuum, in quanto vengono esclusi dal gruppo da parte dei coetanei. I soggetti che rientrano in questo gruppo generalmente presentano elevati livelli di aggressività mettendo in atto numerose condotte antisociali, sono poco rispettosi delle regole e poco disponibili a condividere le proprie cose con gli altri; questi soggetti manifestano raramente empatia e mettono in atto comportamenti inadeguati nel corso delle interazioni sociali.
Una terza tipologia di status sociale è costituita dall’essere ignorati. Questi bambini all’interno del gruppo dei pari non vengono né scelti né rifiutati dai compagni, come se fossero invisibili. I bambini ignorati presentano comportamenti di isolamento. Alcuni di essi presentano comportamenti solitari di tipo passivo, apparendo quieti, sedentari e impegnati in attività esplorative; altri presentano comportamenti solitari di tipo reticente, mostrando timidezza e ansia nel caso in cui debbano agire in una situazione sociale, sono poco desiderosi di entrare a far parte di un gruppo (Coplan et al., 1994).
Una quarta tipologia di status sociale è costituita dai bambini controversi, cioè coloro che ottengono diverse scelte dai compagni, ma che a differenza dei bambini popolari, ricevono sia scelte positive che negative. Ciò è dovuto al fatto che questi soggetti mettono in atto sia condotte prosociali, mostrando empatia nei confronti degli altri, che condotte aggressive, per questo motivo vengono ammirati da alcuni compagni e rifiutati da altri (Coie & Dodge, 1998; Newcomb, Bukowsky, Pattee, 1993).
L’ultima categoria è rappresentata dai bambini medi: questi soggetti non possiedono né le abilità necessarie per diventare popolari, né condotte aggressive che possono indurre i compagni a rifiutarli o ignorarli. Nonostante in questa categoria rientrino il 60-70% dei soggetti appartenenti ad un gruppo, ha suscitato scarso interesse nei ricercatori (Di Norcia, 2005).
L’assegnazione di uno status sociale piuttosto che un altro avviene in seguito alla somministrazione di strumenti che prendono il nome di “tecniche sociometriche”; con tale termine si intende un insieme di metodi messi a punto da Jacob Moreno (1934), utili a misurare le relazioni positive e negative che si vengono a creare all’interno di un gruppo di persone; per fare ciò è necessario che ogni individuo interno al gruppo, sia in grado di valutare gli altri membri in relazione alle loro caratteristiche o competenze (Cillessen, 2009). Tra le tecniche sociometriche, lo strumento più conosciuto ed utilizzato, è la nomina dei pari (McCandless & Marshall, 1957), intesa come “il processo attraverso il quale i membri di un gruppo valutano in quale misura gli altri membri presentano determinate caratteristiche e condotte” (Pastorelli, 1994). Utilizzando questo strumento è possibile vedere le attrazioni-repulsioni che i soggetti appartenenti ad un gruppo manifestano nei confronti degli altri (Cassibba & Elia, 2009).
Numerosi sono stati gli studi che hanno indagato la presenza di comportamenti aggressivi e prosociali all’interno dei diversi status sociali con particolare interesse ai comportamenti predominanti, il loro sviluppo, l’andamento e le eventuali differenze di genere.
Le ricerche condotte evidenziano con chiarezza come alla base dell’accettazione da parte dei compagni vi sia prevalentemente la competenza sociale precedentemente acquisita: i bambini popolari mettono in atto un numero maggiore di comportamenti altruistici, di aiuto nei confronti dei coetanei, sono più cooperativi, più capaci di negoziare e risolvere i conflitti senza ricorrere all’aggressività, hanno quindi una maggiore capacità di regolare le emozioni; inoltre sembrano maggiormente abili nella gestione della comunicazione e dello scambio sociale. Tali competenze non sono invece presenti nei bambini rifiutati, che appaiono poco graditi perché non sono capaci di interagire efficacemente con gli altri e mostrano un comportamento intrusivo, chiassoso, a volte prepotente e aggressivo (Corsano, 2008).
Quest’ultimo aspetto appare controverso: se inizialmente si tendeva ad affermare l’esistenza di alta correlazione fra l’essere rifiutati dai pari e l’essere aggressivi (Coie & Keane, 1981; Newcomb, Bukowski, Patee, 1993), oggi questa correlazione non è più chiara (Molinari, 2007).
Popolarità e aggressività
Per diversi anni il termine “popolare” è stato usato per raggruppare una serie di caratteristiche generalmente positive, che andavano dall’essere bene accetto dal gruppo dei pari, all’avere comportamenti prosociali, bassi livelli di aggressività, elevati livelli di regolazione emotiva, buone abilità sociali e cognitive. La popolarità era desiderata da molti, in quanto indice di buon adattamento e di lodevoli abilità sociali, e non riportava traccia di caratteristiche negative (Mayeux, Houser, Dyches, 2011).
I soggetti percepiti come popolari da parte dei loro coetanei, sono ben voluti, attraenti, possiedono beni desiderabili, sono accettati da altri individui popolari e desiderati dai giovani di sesso opposto (Butcher, 1986; Eder, 1985; Lease et al., 2002), ma oltre a dimostrare caratteristiche a cui viene attribuito valore all’interno della società contemporanea, manifestano anche una certa frequenza di comportamenti aggressivi (Luthar & McMahon, 1996; Parkhurst & Hopmeyer, 1998; Rodkin et al., 2000). Anche le ricerche di La Fontana e Cillessen (1998) giunsero a simili scoperte.
Recentemente, l’immagine del bambino popolare è leggermente cambiata, o meglio sono emersi nuovi pattern comportamentali che prima, si pensava fossero del tutto assenti in questo status sociale. Di conseguenza i ricercatori hanno focalizzato la loro attenzione sull’eterogeneità dei comportamenti presenti all’interno del gruppo di bambini e adolescenti classificati come popolari (Antonius, Cillisen, Rose, 2005).
A questo proposito è opportuno distinguere la popolarità sociometrica (sociometric popularity) dalla popolarità percepita (dominance-based popularity). Nonostante gli autori affermino che esista una correlazione ed una parziale sovrapposizione tra i due costrutti (Hawley, 2003; Cillissen & Mayeux, 2004; La Fontana & Cillisen, 2002), popolarità sociometrica e popolarità percepita non possono essere considerati costrutti identici.
Andando ad esaminare i profili comportamentali, la popolarità sociometrica è associata a caratteristiche prettamente positive come alti livelli di prosocialità, comportamenti di cooperazione e bassi livelli di aggressività (Rubin, Bukowski, Parker, 1998), invece la popolarità percepita è associata sia a caratteristiche positive, che a caratteristiche negative.
La propensione all’aggressività nella vita di bambini e adolescenti è stata spesso concettualizzata dalla psicologia dell’età evolutiva, come un fattore di rischio, per lo sviluppo del disadattamento. La prospettiva evoluzionistica ha modificato tale assunto ribadendo che la presenza di comportamenti aggressivi sia tra i vertebrati che tra gli invertebrati suggerisce che questi siano il prodotto della selezione naturale e possono essere visti come funzionali alla sopravvivenza e al successo riproduttivo.
Le ricerche successive, influenzate da questo orientamento, hanno messo in evidenza le dimensioni funzionali dell’aggressività in termini di dominanza sociale. In accodo con questo lavoro, una combinazione di comportamenti aggressivi e strategie affiliative potrebbero predire centralità nel gruppo dei pari e controllo delle risorse sociali.
Negli studi che indagano la relazione tra popolarità e aggressività, vengono misurate aggressività diretta (la quale include assalti fisici e verbali) e aggressività relazionale (include azioni quali ignorare, escludere, sparlare di qualcuno) in modo separato. Lo studio di LaFontana e Cillessen (2002) mostra un’associazione positiva della popolarità con entrambe le forme.
A conferma di ciò, vi è lo studio di Cillessen e Mayeux (2004), in cui fu seguito longitudinalmente un campione di bambini dalla quinta elementare alla prima superiore e venne valutata la relazione tra popolarità percepita, popolarità sociometrica e aggressività (manifesta e relazionale). Gli autori scoprirono che se da un lato la correlazione negativa tra popolarità percepita e aggressività manifesta tende a diminuire nel tempo fino ad invertire il segno, dall’altro lato l’associazione positiva tra popolarità percepita e aggressività relazionale diventa più forte nel tempo, soprattutto per le femmine.
Gli autori giunsero alla conclusione che la correlazione positiva tra popolarità percepita ed entrambe le forme di aggressività aumenta con l’aumentare degli anni, e affermarono che i soggetti che guadagnano in popolarità, presentano un aumento delle condotte aggressive.
La funzione dell’aggressività
Nel tentativo da parte dei vari autori di comprendere la funzione dell’aggressività in soggetti percepiti come popolari, è stata formulata l’ipotesi secondo cui le condotte aggressive vengano messe in atto dai soggetti in modo strategico per aumentare o mantenere il loro status sociale all’interno del gruppo. A conferma di questa ipotesi, vi sono diversi studi longitudinali (Cillessen & Mayeux, 2004; Rose et al., 2004), i quali oltre a confermare la funzione dell’aggressività per i soggetti percepiti come popolari, sottolineano una forte correlazione tra popolarità percepita e aggressività relazionale. Infatti, escludere e ignorare gli altri possono essere mezzi efficaci per manipolare le relazioni (Antonius, Cillessen, Rose, 2005).
Sebbene numerosi studi abbiano esaminato gli antecedenti comportamentali dello status sociometrico (Bukowsky & Newcomb, 1984; Rubin et al., 1998), nessuno studio quantitativo si è dedicato a verificare gli antecedenti comportamentali della popolarità percepita. Tuttavia i ricercatori hanno suggerito che i soggetti potrebbero manifestare aggressività con lo scopo di aumentare la loro popolarità percepita (Adler & Adler, 1998; Lease et al., 2002; Rodkin et al., 2000).
Lo studio di Rose et al. (2004), ha esaminato l’ipotesi opposta, ossia il fatto che essere considerati come popolari porti ad un aumento dell’aggressività. I bambini che hanno raggiunto la popolarità all’interno del gruppo dei pari, si sentono in diritto di soddisfare totalmente i propri bisogni. Questi soggetti si sentono giustificati nell’uso dell’aggressività di fronte a frustrazioni o competizioni, si potrebbe quindi dedurre che la loro abilità nell’aggredire aumenti a causa del loro status sociale (Merten, 1997).
Tali relazioni possono essere anche bidirezionali: l’iniziale aggressività manifestata da un individuo può portare ad un aumento della popolarità, la quale, può ulteriormente accrescere l’aggressività. Aggressività e popolarità risultano implicate in un processo di influenza reciproca (Rose, Sweason, Waller, 2004).