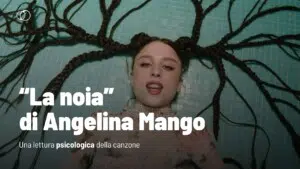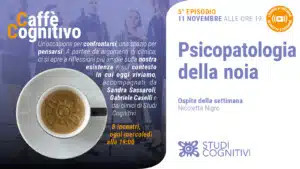Che cosa è la noia
La noia è un’esperienza psicologica caratterizzata da una mancanza di interesse, stimolazione o sfida che può manifestarsi in vari modi, tra cui irrequietezza, apatia e disinteresse (Ndetei et al., 2023). Per alcuni studiosi, la noia è definita come un’esperienza avversiva di voler, ma non essere in grado di, impegnarsi in qualcosa di appagante: in altri termini, desiderare di fare qualcosa di soddisfacente, ma non voler fare nulla tra le alternative disponibili (Eastwood et al., 2012).
La noia è un’esperienza spiacevole, diversa dall’inerzia del tempo libero e del relax, in quanto essere annoiati implica un desiderio non appagato di essere impegnati. Sebbene abbia costituito un argomento di interesse filosofico fin dagli antichi Greci (Martin et al., 2006), la noia ha ricevuto poca attenzione dalla ricerca psicologica moderna, in quanto considerata generalmente uno stato fugace e poco appariscente, irrilevante per il funzionamento umano. Tuttavia, la frequenza con cui la noia viene sperimentata in individui e culture suggerisce la possibilità che essa abbia un impatto significativo nella vita quotidiana.
Manifestazioni della noia
Dal punto di vista cognitivo, la noia è in genere associata alla percezione soggettiva del tempo che passa lentamente, difficoltà di concentrazione e problemi di attenzione (Eastwood et al., 2012). Le persone annoiate possono mostrare la parte superiore del corpo inclinata in avanti, movimenti attenuati e poco espansivi (Wallbott, 1998). Inoltre, la noia è comunemente associata alla motivazione a cambiare o a sfuggire alla situazione vissuta attraverso strategie cognitive o comportamentali, ad esempio sognando ad occhi aperti, divagando con la mente o addormentandosi, cambiando compito, cercando distrazioni o impegnandosi in attività più interessanti (van Hooft & van Hooff, 2018).
La noia come emozione
Esiste un consenso crescente tra i ricercatori nel considerare la noia un’emozione, avente la funzione di perseguire un obiettivo alternativo. Alcuni studi, infatti, sostengono che la noia sia motivante e incoraggi l’azione verso un nuovo obiettivo man mano che l’intensità emotiva svanisce. È noto che le emozioni svaniscono nel tempo (Robinson & Clore, 2002), diventando meno intense. Una volta che un obiettivo è stato raggiunto (elicitando in questo caso un’emozione di felicità), o bloccato (rabbia), minacciato (ansia) o perso (tristezza), ed è rimasto in tale stato abbastanza a lungo da far sì che la risposta emotiva inizi a svanire, la noia potrebbe fungere da segnale in grado di suggerire che è tempo di passare ad altre attività (Bench & Lench, 2013).
Cause della noia
Alcuni fattori possono facilitare l’esperienza di noia:
- sottostimolazione/sovrastimolazione: situazioni e attività monotone o eccessivamente caotiche possono rendere difficoltosa la concentrazione (Westgate, 2020);
- livello di difficoltà: compiti troppo facili o troppo difficili possono aumentare le difficoltà di attenzione (ibidem);
- isolamento o solitudine: essere soli o sentirsi disconnessi dagli altri può contribuire alla noia. Gli esseri umani sono creature sociali e le interazioni con gli altri spesso forniscono impegno e stimolazione;
- tratti della personalità: nevroticismo (bassa stabilità emotiva) ed estroversione risultano maggiormente associati alla noia (Martin et al., 2006). Ad esempio, gli estroversi hanno generalmente un bisogno maggiore di interazione sociale. Per questo, stare da soli a lungo potrebbe aumentare la sensazione soggettiva di isolamento, portando alla noia;
- età: gli studi mostrano una correlazione negativa tra età e noia. Più si è giovani, più è probabile annoiarsi (Chin et al., 2017). Questo suggerisce che la propensione alla noia può cambiare nel corso dell’arco di vita;
- disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD): le persone con ADHD, che hanno difficoltà a mantenere elevate soglie attentive, sono più inclini alla noia (Malkovsy et al., 2012);
- stati emotivi: stress, ansia e depressione possono influire sulla capacità di una persona di impegnarsi in attività;
- incongruenza delle aspettative: grandi aspettative non soddisfatte per un’attività, un ambiente o un’esperienza (Anderson et al., 2022).
- ripetitività: anche quando un’attività soddisfa le nostre aspettative, la ripetizione può renderla noiosa;
- mancanza di agency: individui con bassa agency (agentività), ovvero capacità di influenzare il corso della propria vita, formulando, agendo e perseguendo obiettivi, possono sperimentare più frequentemente la noia (Gorelik & Eastwood, 2023).
Noia di stato e noia di tratto
Diversi teorici hanno suggerito l’esistenza di due tipi di noia: una noia “reattiva” o di stato, transitoria e di breve durata, evocata dalla situazione, e una noia “cronica” o di tratto, indipendente dalla situazione (Bernstein, 1975; Neu, 1998; Todman, 2003). Alcuni individui sperimentano la noia più spesso di altri. Questa osservazione ha dato origine al concetto di “inclinazione alla noia” (Farmer & Sundberg, 1986).
Noia “di tratto” e salute mentale
Vari studi collegano la noia di tratto a una serie di problemi clinici, psicologici e sociali.
La noia può rappresentare sia un fattore di rischio che un sintomo della depressione. Essa può interferire con la motivazione e il comportamento orientato a obiettivi, ridurre il piacere e innescare pensieri e preoccupazioni ansiose, esacerbando sintomi preesistenti di disturbi d’ansia (LePera, 2011). Inoltre, la noia di tratto è implicata nello sviluppo e nel mantenimento dei disturbi da uso di sostanze, è associata a maggiore l’impulsività, portando gli individui a impegnarsi in attività rischiose o in cerca di sensazioni come modo per alleviare la loro noia (Lee et al., 2007; Mercer-Lynn et al., 2013). Infatti, uno studio sul comportamento di binge drinking negli adolescenti ha scoperto che la propensione alla noia rappresenta un predittore significativo del binge drinking (Biolcati et al., 2016 ). Non solo, la noia non situazionale è collegata a gioco d’azzardo, abbuffate alimentari e abbandono scolastico precoce (Mercer & Eastwood, 2010; Lee et al., 2007; LePera, 2011; Bench & Lench, 2013).
Impatto della noia nella vita quotidiana
La noia può manifestarsi in diversi contesti: lavoro, scuola, relazioni e tempo libero, ed è più diffusa tra uomini, giovani, non sposati e persone con reddito più basso (Chin et al., 2017 ; Weybright et al., 2020). Sebbene la noia sia spesso vista come un’esperienza spiacevole, può avere effetti sia negativi che positivi sugli individui. Da un lato, la noia può essere una fonte di creatività e innovazione: quando ci si annoia, la mente è più propensa a “vagare” ed esplorare nuove idee o prospettive (Ndetei et al., 2023). La noia può incoraggiare a cercare nuove esperienze, scoprire nuovi interessi o sfidare se stessi per imparare e crescere. Ad esempio, durante la pandemia di COVID-19, la noia dovuta a lockdown e isolamento ha aiutato molti individui a esplorare nuove idee e scoprire nuovi interessi: creazione di contenuti, pittura, cucina, panificazione e lavoro a maglia (Morse et al., 2021). La noia può anche spingere a riflettere su valori, obiettivi, aspirazioni e motivare a fare cambiamenti nella vita. In questo senso, la noia può essere vista come un’opportunità di autoconsapevolezza e auto-miglioramento. Gli studi hanno dimostrato che le persone che sperimentano livelli moderati di noia hanno maggiori probabilità di impegnarsi nel pensiero creativo e nella risoluzione dei problemi (Elpidorou, 2018; van Tilburg e Igou, 2019).
D’altro canto, la noia può avere anche conseguenze negative come una diminuzione della produttività, una cattiva salute mentale e persino problemi di salute fisica. In uno studio, una percentuale significativa di partecipanti, il 67% degli uomini e il 25% delle donne, ha preferito somministrarsi delle scosse elettriche piuttosto che provare noia mentre era seduta da sola con i propri pensieri (Wilson et al., 2014 ). Questa scoperta evidenzia quanto le persone in genere detestino annoiarsi.
- Anderson, A. J., McMeen, C. E., Perone, S., & Weybright, E. H. (2022). Sound and Silence: The Effects of Environmental Conditions on State Boredom in an Online Study during the COVID-19 Pandemic. Behavioral Sciences, 12(8), 282
- Bench SW, Lench HC. On the function of boredom. Behav Sci (Basel). 2013 Aug 15;3(3):459-472.
- Bernstein H. E. (1975). Boredom and the ready-made life. Social Research, 42, 512–537.
- Biolcati R., Passini S., Mancini G. (2016). “I cannot stand the boredom.” Binge drinking expectancies in adolescence. Addict. Behav. Rep. 3, 70–76.
- Camerini, A.L., Morlino, S., Marciano, L.(2023). Boredom and digital media use: A systematic review and meta-analysis, Computers in Human Behavior Reports, Volume 11, 100313.
- Chin A., Markey A., Bhargava S., Kassam K. S., Loewenstein G. (2017). Bored in the USA: experience sampling and boredom in everyday life. Emotion 17, 359.
- Eastwood, J. D., Frischen, A., Fenske, M. J., & Smilek, D. (2012). The Unengaged Mind: Defining Boredom in Terms of Attention. Perspectives on Psychological Science, 7(5), 482-495.
- Elpidorou A. (2018). The good of boredom. Philos. Psychol. 31, 323–351.
- Farmer R., Sundberg N. D. (1986). Boredom proneness: The development and correlates of a new scale. Journal of Personality Assessment, 50(1), 4–17.
- Goldberg Y.K., Eastwood J.D., Laguardia J., Danckert J. Boredom: An emotional experience distinct from apathy, anhedonia, or depression. J. Soc. Clin. Psychol. 2011;30:647–666.
- Gorelik D, Eastwood JD. Trait Boredom as a Lack of Agency: A Theoretical Model and a New Assessment Tool. Assessment. 2024 Mar;31(2):321-334.
- Lee C.M., Neighbors C., Woods B.A. Marijuana motives: Young adults’ reasons for using marijuana. Addict. Behav. 2007;32:1384–1394.
- LePera N. Relationships between boredom proneness, mindfulness, anxiety, depression, and substance use. New School Psychol. Bull. 2011;8:15–25.
- Leung, L. (2020). Exploring the relationship between smartphone activities, flow experience, and boredom in free time. Computers in Human Behavior, 103 (2020), pp. 130-139.
- Malkovsky, E., Merrifield, C., Goldberg, Y., & Danckert, J. (2012). Exploring the relationship between boredom and sustained attention. Experimental Brain Research, 221, 59-67.
- Martin M., Sadlo G., Stew G. The phenomenon of boredom. Qual. Res. Psychol. 2006;3:193–211.
- Mercer K.B., Eastwood J.D. Is boredom associated with problem gambling behaviour? It depends on what you mean by ‘boredom’. Int. Gambl. Stud. 2010;10:91–104.
- Mercer-Lynn K. B., Hunter J. A., Eastwood J. D. (2013). Is trait boredom redundant? J. Soc. Clin. Psychol. 32, 897–916. 10.1521/jscp.2013.32.8.897
- Morse K. F., Fine P. A., Friedlander K. J. (2021). Creativity and leisure during COVID-19: examining the relationship between leisure activities, motivations, and psychological well-being. Front. Psychol. 12, 609967.
- Ndetei DM, Nyamai P, Mutiso V. Boredom-understanding the emotion and its impact on our lives: an African perspective. Front Sociol. 2023 Jun 29;8:1213190.
- Neu J. (1998). Boring from within. In Flack W. F., Laird J. D. (Eds.), Emotions in psychopathology: Theory and research (pp. 158–170). Oxford University Press.
- Robinson M.D., Clore G.L. Belief and feeling: Evidence for an accessibility model of emotional self-report. Psychol. Bull. 2002;128:934–960.
- Tam, K.Y.Y. , van Tilburg, W.A.P. , Chan, C.S. , Igou, E.R. , Lau, H. (2021). Attention drifting in and out: The boredom Feedback model. Personality and Social Psychology Review, 25 (3) (2021), pp. 251-272.
- Todman M. (2003). Boredom and psychotic disorders: Cognitive and motivational issues. Psychiatry, 66(2), 146–167.
- van Hooft EAJ, van Hooff MLM. The state of boredom: Frustrating or depressing? Motiv Emot. 2018;42(6):931-946.
- van Tilburg W. A. P., Igou E. R. (2019). The unbearable lightness of boredom: a pragmatic meaning-regulation hypothesis. Boredom is your mind. A Shar Psychol. Approach 2, 11–35.
- Wallbott HG. Bodily expression of emotion. European Journal of Social Psychology. 1998;28:879–896.
- Weybright E. H., Schulenberg J., Caldwell L. L. (2020). More bored today than yesterday? National trends in adolescent boredom from 2008 to 2017. J. Adolesc. Heal. 66, 360–365.
- Westgate, E.C. (2020). Why boredom is interesting. Current Directions in Psychological Science, 29 (1) (2020), pp. 33-40.
- Westgate, E.C., Wilson, T.D. (2018). Boring thoughts and bored minds: The MAC model of boredom and cognitive engagement. Psychological Review, 125 (5) (2018), pp. 689-713.
- Wilson T. D., Reinhard D. A., Westgate E. C., Gilbert D. T., Ellerbeck N., Hahn C., et al. (2014). Just think: the challenges of the disengaged mind. Science 345, 75–77. 10.1126/science.1250830