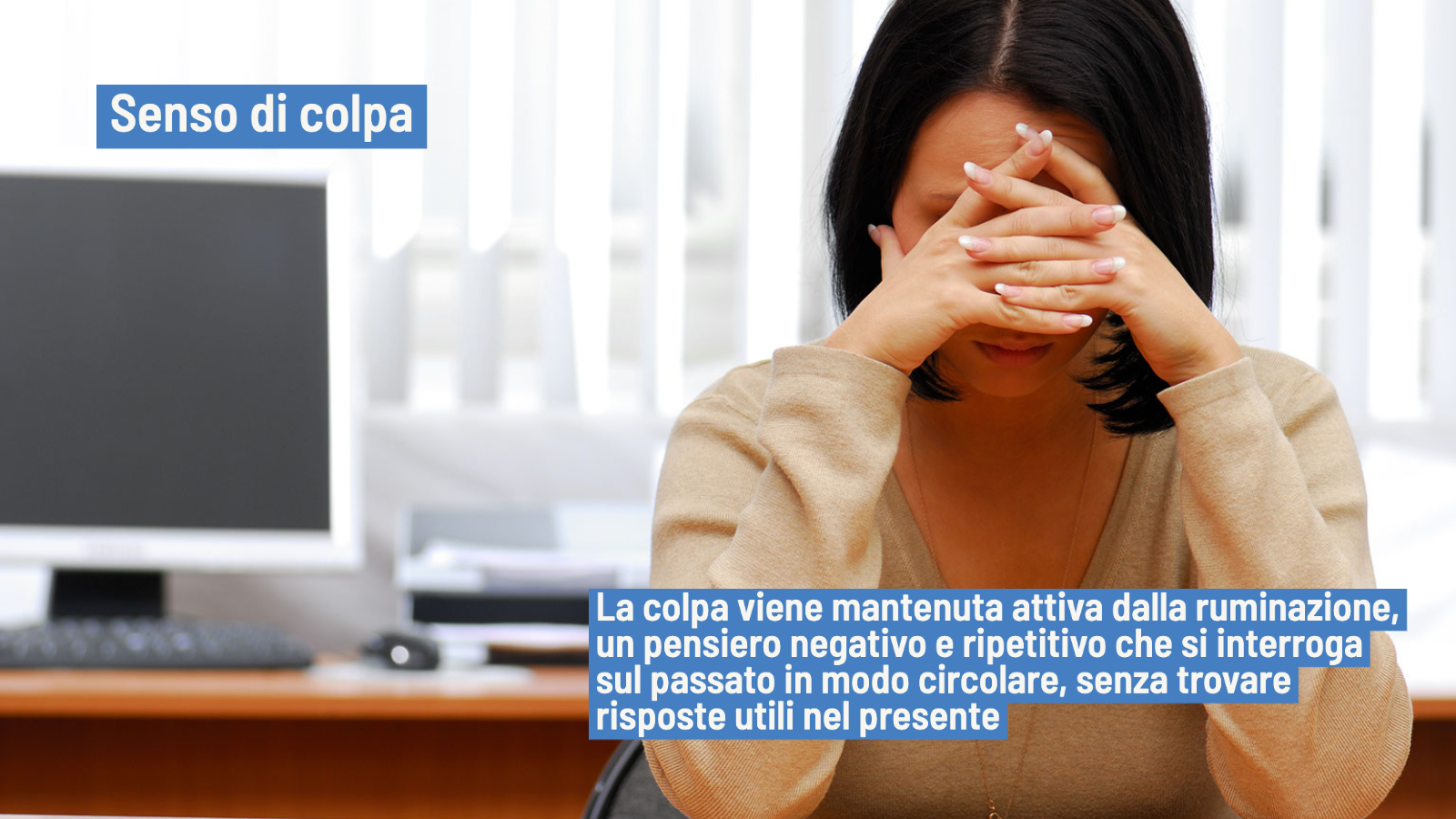Cos’è la sindrome del sopravvissuto
Ci sarà capitato, almeno una volta nella vita, di sentirci afflitti per la sofferenza provata da un nostro caro, soprattutto dopo esserci resi conto della nostra condizione di benessere. Può capitare, infatti, di non riuscire a godere dei propri successi o attimi di felicità per via di un intrinseco dovere alla sofferenza che, di fronte a quella altrui, ci impone di non essere troppo soddisfatti dei nostri traguardi. Questo meccanismo, in misura estrema, può presentarsi anche in relazione a eventi luttuosi e perdite significative, quando la persona che rimane in vita si sente in colpa ad andare avanti e a riprendere le fila della propria esistenza. Alcune di queste persone possono arrivare a manifestare i sintomi tipici del Disturbo da Stress Post-Traumatico, come il senso di impotenza di non essere riusciti a tenere in vita la persona cara o di non essere stati in grado di risparmiarle le sofferenze.
Cosa dice la psicologia
Da un punto di vista storico, la psicologia ha trattato l’argomento da diversi punti di vista, così da comprendere al meglio le cause e la fenomenologia della sindrome del sopravvissuto. Freud (1961) fu il primo ad utilizzare il termine, specificamente nell’ambito luttuoso, descrivendola come la sofferenza basata sul senso di colpa che deriva dalla morte di una persona cara. Neiderland (1961), più tardi, ne parlò a proposito dei sopravvissuti ai campi di concentramento della Seconda Guerra Mondiale, che continuavano a chiedersi perché fossero ancora vivi quando le loro famiglie erano state uccise dai nazisti. A questo riguardo, è paradigmatico il caso di Primo Levi, scrittore italiano sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti e morto suicida perché vittima di un attanagliante senso di colpa nei confronti di chi non era sopravvissuto allo stesso trauma.
In ambito psicoanalitico, Weiss e Modell (1986) ampliarono presto il termine per definire l’esperienza che gli individui provano quando sentono di “superare” le persone che amano in senso più generale, cioè rispetto a situazioni più ordinarie e meno catastrofiche di quelle luttuose. In effetti, il senso di colpa del sopravvissuto può insinuarsi anche nelle piccole cose, finendo per influenzarci nelle situazioni più quotidiane: è difficile godere dei propri risultati accademici quando il proprio fratello ha difficoltà di apprendimento e fa fatica ad ottenere buoni voti a scuola, come è doloroso e angosciante ricevere una promozione sul lavoro quando il merito del proprio collega non viene parimenti riconosciuto.
Come funziona il senso di colpa del sopravvissuto
Secondo gli studiosi, il senso di colpa del sopravvissuto può essere invalidante per il soggetto per due principali motivi:
- Per il fatto di vivere una condizione di privilegio rispetto ad altri che appaiono maggiormente svantaggiati o danneggiati (Kunaby e Manke, 1995);
- Per la percezione di non aver fatto abbastanza per prevenire il danno di cui l’altro è vittima e le sue conseguenze (Parson, 1986).
A generare questo forte senso di responsabilità sarebbe quindi un’operazione cognitiva di confronto tra le fortune del sopravvissuto e quelle della vittima: quando il primo, pesate sulla bilancia la propria e l’altrui sorte, scopre di essere in una posizione vantaggiosa, può iniziare a sperimentare senso di colpa (Poggi, 1994). Secondo Polizzi e Parise (2019), ciò che minaccerebbe internamente il benessere psicologico del sopravvissuto sarebbe quindi il senso di equità e uguaglianza che si presume debba esserci fra le persone.
Anche a livello neurologico c’è riscontro rispetto a questo meccanismo. Se si parte dalla premessa che i neuroni specchio, responsabili delle nostre reazioni empatiche, si attivano in risposta alla sofferenza dell’altro facendoci provare disagio, non c’è da sorprendersi se la maggior parte di noi fatica a premiarsi per i propri meriti quando di fronte a un’ingiustizia.
La proposta cognitivo-comportamentale
Provare il senso di colpa del sopravvissuto non significa vivere una condanna eterna. La terapia cognitivo-comportamentale risulta un approccio molto efficace per risolvere questa problematica. Presupponendo che il senso di colpa derivi dal modo in cui la persona interpreta l’evento, l’obiettivo di questo approccio è quello di ristrutturare cognitivamente le credenze alla base di tale emozione negativa: da un lato, si aiuterebbe il paziente a riformulare le credenze disfunzionali che lo conducono a trarre conclusioni erronee associate alla colpa, dall’altro lo si inviterebbe a generare delle interpretazioni più realistiche della situazione attivante. Lavorando sulla colpa, del resto, la persona viene aiutata a maturare quella dose di autocompassione e autoaccettazione necessarie a sviluppare un atteggiamento meno giudicante nei confronti del sé e della propria esperienza interna (Gilbert e Procter, 2006).
Sulla base di queste premesse, la Dottoressa O’ Connor (2023) fornisce tre principali indicazioni per affrontare e tollerare il senso di colpa del sopravvissuto:
- Imparare a riconoscere l’emozione di colpa, individuarne le credenze e iniziare a vedere le cose in modo più realistico;
- Cominciare a coltivare l’autocompassione non solo con gli altri sofferenti, ma anche con se stessi, riconnettendosi intimamente alla propria storia e a come si è riusciti a superare le difficoltà;
- Provare a svolgere il seguente esercizio di immaginazione attiva, che aiuta a visualizzare la fonte delle emozioni negative in senso terapeutico: inspirare, immaginandosi di respirare il fumo nero della sofferenza delle persone che amiamo, ed espirare, pensando di esalare raggi di felicità che si diffondono fino alle persone del cui dolore siamo stati testimoni.
Insieme, queste pratiche possono permettere di convivere col senso di colpa senza la necessità di “pareggiare i conti”, ossia non punendosi per le proprie gioie e non obbligandosi ad una sofferenza “dovuta”.