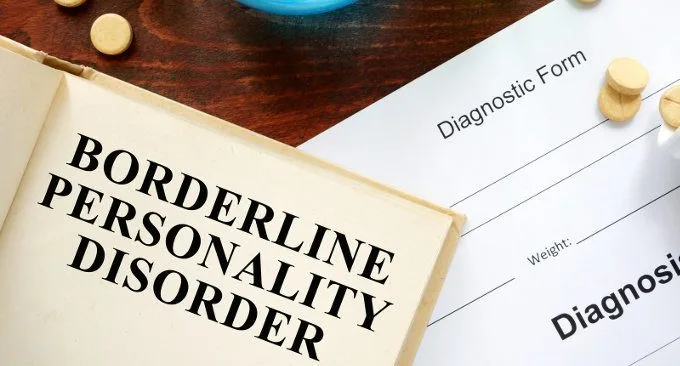Il Disturbo Borderline di Personalità, come gli altri Disturbi di Personalità, è una patologia pervasiva che inficia il funzionamento sociale, le relazioni interpersonali e l’andamento lavorativo di chi ne soffre; gli individui che ne sono affetti hanno inoltre, spesso problemi economici e legali
Naomi Aceto e Giulia Meloni – OPEN SCHOOL Studi Cognitivi
La letteratura scientifica, nel corso degli ultimi trent’anni, si è ampiamente concentrata in maniera crescente sul tema dei Disturbi di Personalità, la cui classificazione è stata oggetto di controversie durante la stesura del DSM V 5 (Paris, 2014). Secondo alcuni autori, infatti, la classificazione potrebbe essere talvolta arbitraria, data la frequente sovrapposizione di sintomi e manifestazioni cliniche. Dal punto di vista epidemiologico, sono disturbi comuni e diffusi ma spesso non riconosciuti o riconosciuti tardivamente (Tyrer, 2015).
Un’ulteriore difficoltà è quella relativa alla diagnosi in età evolutiva: esiste, d’altra parte, oramai un’ampia letteratura a sostegno della possibilità di porre diagnosi di disturbo di personalità anche in età evolutiva, impostazione accettata anche dal DSM 5 (APA, 2013), il quale asserisce che “l’esordio può essere fatto risalire almeno all’adolescenza”. La presenza di un disturbo di personalità in età adolescenziale comporta senza dubbio un impatto sul funzionamento del ragazzo e un rischio di ricadute negli anni a seguire, questo risulta essere uno dei principali fattori a sostegno di una diagnosi precoce, al fine di poter strutturare un intervento adeguato e tempestivo in una fascia d’età duttile e particolarmente suscettibile al cambiamento (Larrivee, 2013).
Il Disturbo Borderline di Personalità
Tra i Disturbi di Personalità, il Disturbo Borderline di personalità è indubbiamente uno dei più frequenti e meglio studiati. La sua prevalenza sembrerebbe aggirarsi, a seconda degli studi, intorno al 2% nella popolazione generale, fino ad arrivare circa al 10% in campioni estratti dall’utenza dei Servizi di Salute Mentale (Tomko, 2014). Sembrerebbe essere più diffuso nel sesso femminile ed è spesso accompagnato, da altri disturbi in comorbidità, come i disturbi d’ansia, i disturbi dell’umore e i disturbi legati all’uso di sostanze.
Il Disturbo Borderline di Personalità, come gli altri Disturbi di Personalità, è una patologia pervasiva che inficia il funzionamento sociale, le relazioni interpersonali e l’andamento lavorativo di chi ne soffre; gli individui che ne sono affetti hanno inoltre, spesso problemi economici e legali (Coid, 2009).
Il Disturbo Borderline di Personalità (Bordeline Personality Disorder, BDP) è una patologia caratterizzata da un’elevata impulsività e da una considerevole instabilità nelle relazioni interpersonali e nell’immagine di sé.
Le relazioni sono caratterizzate da una pervasiva paura dell’abbandono, la quale il più delle volte può potare a gesti impulsivi nel tentativo di non rimanere da soli. Generalmente l’impulsività può essere rivolta verso se stessi, attraverso tentativi di suicidio, automutilazioni, e più in generale, varie forme di autolesionismo, oppure può dare luogo a comportamenti disfunzionali, quali abuso di sostanze, scoppi di ira, guida spericolata etc.
Tra le persone affette da Disturbo Borderline di Personalità è frequente una forte instabilità emotiva, che si manifesta, il più delle volte, attraverso marcati e improvvisi cambiamenti dell’umore: queste persone possono oscillare infatti, in maniera repentina, tra serenità e tristezza, tra rabbia e senso di colpa o vergogna. Tali emozioni contrastanti, a volte si presentano contemporaneamente, creando confusione nel soggetto e nelle persone a lui vicine.
Sono frequenti sensazioni di angoscia e di vuoto interiore e stati mentali di natura non psicotica, come la convinzione di essere persone cattive e le frequenti esperienze di dissociazione, quali depersonalizzazione e derealizzazione.
I pazienti affetti da Disturbo Borderline di Personalità sono riconosciuti dalla letteratura come ad alto rischio suicidario e sono spesso ospedalizzati in situazioni acute in cui evidenziano crisi emotive, comportamenti autolesivi anche se non suicidari e comportamenti invece di tipo suicidario (Nelson, 2013).
La disregolazione emotiva, l’impulsività, il carico di sofferenza individuale e familiare e la significativa disabilità psicosociale impongono la necessità di trattamenti specifici. La sola terapia farmacologica, a lungo utilizzata per il trattamento del Disturbo Borderline di Personalità, sembrerebbe essere piuttosto fallimentare, ad eccezione dell’impulsività, così come la sola psicoterapia, sembrerebbe essere associata ad alti livelli di drop-out.
Il trattamento del Disturbo Borderline di Personalità
Sembrerebbe fondamentale dunque, nel trattamento del Disturbo Borderline di Personalità, un lavoro d’équipe che condivida i riferimenti concettuali che fondano il trattamento, al fine di evitare la scissione tra l’intervento del terapeuta e quello di altre figure professionali. Una formazione specifica su un tipo di trattamento quindi non solo permette di applicare un modello psicoterapico validato, ma dà anche coerenza all’insieme degli interventi multidisciplinari.
In letteratura la terapia farmacologica non viene considerata il trattamento elettivo dei disturbi di personalità, mentre la psicoterapia individuale è ritenuta generalmente la pietra miliare della maggior parte dei trattamenti (NICE, 2009; National Health and Medical Research Council, 2012).
Orientamenti teorici diversi hanno realizzato diversi tipi di terapie per la cura dei disturbi di personalità. Attualmente vi sono alcuni trattamenti validati empiricamente tramite RCT (Beatson, Rao, 2014), tra questi sono presenti: la Transference Focused Psychotherapy (TFP), la Dialectical Behavior Therapy (DBT), la Schema Focused Therapy (SFT) e la Systems Training for Emotional Predictability and Problem Solving (STEPPS).
Psicoterapia focalizzata sul transfert
La psicoterapia focalizzata sul transfert (Transference-Focused Psychotherapy, FTP), sviluppata da Otto Kernberg e il suo gruppo di ricerca, è un trattamento psicodinamico basato sul modello delle relazioni oggettuali (Clarkin, Yeomans, Kernberg, 2011). Secondo il modello delle relazioni oggettuali, il Disturbo Borderline di Personalità, nasce da conflitti inconsci del passato, radicati nella psiche, come modelli di relazione interiorizzati, che vengono riprodotti simbolicamente dal paziente ed esperiti come una realtà nella vita attuale. La patologia del paziente dunque, viene vista come una ripetizione inconscia nel qui e ora, delle relazioni patogene interiorizzate in passato (Kernberg, 1975).
Il principale obiettivo della terapia è quello di aiutare il paziente a sviluppare immagini di sé e degli altri multidimensionali, coese e integrate e l’enfasi di tale terapia è posta sulle distorsioni del transfert e sulla loro interpretazione. Clarkin e colleghi (2001) in uno studio preliminare volto a valutare l’efficacia della psicoterapia focalizzata sul transfert, hanno rilevato che dopo un anno di trattamento, nessuno di coloro che ha partecipato con costanza alla terapia, ha mostrato sintomi di peggioramento e che il 52% circa dei soggetti, non soddisfaceva più i criteri DSM IV-TR per una diagnosi di Disturbo Borderline di Personalità.
Dialectical Behavior Therapy
La Dialectical Behavior Therapy (DBT), sviluppata da Marsha M. Linehan, professore di Psicologia Clinica presso la Washington University di Seattle (USA), è un trattamento cognitivo-comportamentale complesso originariamente sviluppato per soggetti con tendenze suicidarie e autolesionistiche, in seguito applicato a soggetti che soffrono di Disturbo Borderline di Personalità. La Dialectical Behavior Therapy si basa sul modello dialettico, il quale presuppone che individuo e ambiente si trovino in un rapporto di mutua e continua interazione, reciprocità e interdipendenza.
La ricerca empirica ha ampiamente dimostrato l’efficacia della Dialectical Behavior Therapy nel Disturbo Borderline di Personalità soprattutto nel ridurre i comportamenti suicidari, i ricoveri in ambiente psichiatrico, l’abbandono delle cure, l’abuso di sostanze, la disregolazione emozionale e le difficoltà interpersonali. Uno studio del 2001 (Koons, Robin, Tweed, 2001) volto a verificare l’efficacia della Dialectical Behavior Therapy in un campione di donne veterane con comportamenti parasuicidari, ha mostrato già dopo soli sei mesi di trattamento, una significativa diminuzione dei sintomi di rabbia, depressione, ideazione suicidaria e gesti autolesivi.
L’ipotesi della Linehan è che i pazienti con Disturbo Borderline di Personalità siano persone emotivamente instabili e incapaci di controllo sulla propria sfera emozionale a causa di una predisposizione biologica esacerbata da un ambiente invalidante, in altri termini, l’espressione dei propri stati interni non solo non è riconosciuta, ma durante l’infanzia è probabile che sia stata spesso punita o banalizzata.
La Dialectical Behavior Therapy è un trattamento ambulatoriale strutturato, che si muove su due livelli principali di intervento: una psicoterapia individuale e, in contemporanea, una terapia di gruppo centrata sull’apprendimento di abilità emotive (skills training). A questi interventi si aggiunge la possibilità di una consulenza telefonica con il terapeuta tra una seduta e l’altra e la possibilità di partecipare a gruppi di sostegno.
Schema Focused Therapy
La Schema Focused Therapy (SFT) è un trattamento psicoterapeutico messo a punto da Jeffrey Young (Young, Klosko, Weishar, 2003) che si fonda su tre concetti base: gli schemi, gli stili di coping e le modalità (mode). Gli stili di coping disfunzionali, secondo l’autore, sono le modalità con cui l’individuo cerca di far fronte alle minacce, rimanendo intrappolato però nei propri schemi maladattivi, mentre per modalità o mode si intende l’insieme delle risposte di coping, sia adattive sia disfunzionali. I pazienti borderline presentano un cospicuo numero di schemi e una continua oscillazione di stati affettivi e risposte di coping differenti; inoltre non hanno possibilità di accedere ad altri mode quando in loro se ne attiva uno specifico: le diverse modalità sono totalmente dissociate le une dalle altre. Secondo Young (2003), in seguito a esperienze negative vissute durante l’infanzia, il soggetto sviluppa, quelli che egli definisce, schemi maladattivi precoci. Tali schemi, secondo l’autore sono all’origine di tratti di personalità patologica e talvolta di veri e propri disturbi di personalità, come il Disturbo Borderline di Personalità.
Systems Training for Emotional Predictability and Problem Solving
Systems Training for Emotional Predictability and Problem Solving (STEPPS) è un trattamento ambulatoriale di stampo cognitivo-comportamentale basato su gruppi di skills sviluppato per pazienti con Disturbo Borderline di Personalità e con difficoltà nella regolazione emotiva e comportamentale (Blum, 2012; Alesiania, 2014). Il fondamento teorico della Systems Training for Emotional Predictability and Problem Solving è che il deficit centrale nei soggetti affetti da Disturbo Borderline di Personalità sia l’incapacità di regolare e controllare l’intensità emotiva. Come risultato, il paziente borderline è ciclicamente vittima di picchi emotivi intensi e intollerabili che lo portano a cercare sollievo mediante comportamenti disfunzionali quali auto-mutilazione, agiti spericolati e abuso di sostanze. Il programma terapeutico si compone di un trattamento di psicoeducazione e di un modulo di skills training, per una durata di 20 settimane.
La STEPPS è stata descritta dalla United States Substance Abuse and Mental Health Administration come un trattamento evidence based ed è stata inserita nel National Registry for Evidence-Based Practices come un programma di trattamento completo per il Disturbo Borderline di Personalità e/o come supplemento o aggiunta alle terapie già esistenti e utilizzate. L’obiettivo della terapia è aiutare i pazienti ad acquisire nuove strategie di coping, al fine di modulare e ridurre i dolorosi picchi emotivi e i comportamenti impulsivi. L’acquisizione di queste abilità permette al paziente di anticipare situazioni stressanti e incrementare la fiducia nelle proprie capacità nel gestire il proprio disturbo. Il programma della STEPPS prevede tre componenti principali: consapevolezza della malattia, skills training per controllo emotivo, skills training per controllo comportamentale.
Recentemente alcuni autori (Madeddu et al. 2012) hanno messo a confronto differenti modelli di trattamento, validati empiricamente tramite RCT, ed hanno concluso che tutti possono essere considerati efficaci nella cura del Disturbo Borderline di Personalità o, quantomeno, idonei al trattamento di specifici sintomi ad esso associati.
Disturbo Borderline di Personalità negli adolescenti
L’ampliamento della diagnosi di Disturbo Borderline di Personalità agli adolescenti (Miller, 2008) ha reso necessario l’adattamento delle tecniche di intervento messe a punto per l’adulto, all’età adolescenziale. Tra i protocolli sopracitati solo Dialectical Behavior Therapy e Psicoterapia Focalizzata sul Transfert sono stati adattati per l’adolescente.
La DBT-A per l’adolescente (Miller 2008) prevede innanzitutto il coinvolgimento dei familiari del ragazzo, un adattamento dei contenuti e del linguaggio degli skills training e la riduzione della durata del protocollo da 1 anno a 16 settimane con la possibilità di accedere ad una seconda fase opzionale.
Anche la TFP-A prevede un adattamento del linguaggio per l’età evolutiva e comprende il coinvolgimento dei familiari nel trattamento. Il modello, manualizzato da Kernberg e colleghi, contempla anche un adattamento delle tecniche ed è focalizzato a sviluppare relazioni più adeguate sia in ambito familiare che extra-familiare (Kernberg et al. 2008). Non vi sono al momento studi di valutazione di efficacia dell’applicazione del modello in adolescenti con Disturbo Borderline di Personalità.