La scelta del partner
 Quando due persone si incontrano ognuna porta con sé un bagaglio di modelli e abitudini relazionali, di “teorie” e aspettative, di bisogni da soddisfare, di domande alle quali rispondere per trovare una via d’uscita a difficoltà sentimentali precedenti, fantasie e bisogni evolutivi, o regressivi, spesso legati a ruoli e funzioni assunte all’interno della famiglia di origine o a precedenti rapporti di coppia.
Quando due persone si incontrano ognuna porta con sé un bagaglio di modelli e abitudini relazionali, di “teorie” e aspettative, di bisogni da soddisfare, di domande alle quali rispondere per trovare una via d’uscita a difficoltà sentimentali precedenti, fantasie e bisogni evolutivi, o regressivi, spesso legati a ruoli e funzioni assunte all’interno della famiglia di origine o a precedenti rapporti di coppia.
Le persone quindi vivono le relazioni sentimentali non solo sulla base degli aspetti “pragmatici” e coscienti della relazione con l’altro, ma anche in funzione delle rappresentazioni interne, i modelli, che hanno costruito nel corso dell’esistenza all’interno dei rapporti più significativi.
Ma qual è il meccanismo attraverso il quale avviene la scelta di una persona piuttosto che di un’altra? Cosa del proprio bagaglio personale peserà maggiormente nell’effettuare la scelta?
Gli aspetti implicati nel meccanismo di scelta sono molteplici:
– L’altro, il partner, l’amato, è sempre, in parte, usato narcisisticamente come un contenitore per alcune parti di noi, cioè in lui proiettiamo uno o più aspetti complementari di noi. Questo meccanismo può investire parti idealizzate del sé, come per esempio nell’innamoramento, o parti indesiderabili, angoscianti e difficili da gestire.
Questo processo può dimostrarsi evolutivo, e favorire l’integrazione, quando il rapporto con il partner permette di riconoscere e bonificare le parti di noi che abbiamo fino a quel momento respinto, diminuendo anche la proiezione di aspetti scissi; o, al contrario, questo meccanismo può andare nella direzione di un uso difensivo dell’altro, per cui la relazione con lui diventa il mezzo per negare la propria realtà psichica, ignorando e misconoscendo le parti del sé che sono state risposte nel partner, e mantenendo allo stesso tempo anche un controllo sugli aspetti angoscianti e ingestibili del sé.
La scelta del partner, da questo punto di vista, è tutt’altro che casuale, infatti il prescelto deve rappresentare il contenitore “adatto” alle proiezioni e questo deve avvenire per entrambi i membri della coppia: si creano così contesti interattivi circolari all’interno dei quali entrambi i coniugi si trovano ad agire e pensare inconsapevolmente secondo modalità analoghe o contrarie a quelle indotte nell’altro dalle proprie proiezioni. Nel corso di relazioni di coppia significative è possibile osservare questo adattamento reciproco che può, come già detto, essere dinamico, cioè evolutivo e facilitante l’integrazione, o rigido e difensivo. Integrare significa poter riprendere su di sé tanto le parti buone quanto quelle inaccessibili, ma anche saper riconoscere la separatezza e la diversità dell’altro rispetto a noi. In questo senso diversi autori, primo tra tutti Dicks, si riferiscono al matrimonio come a una relazione terapeutica naturale, cioè a un terreno comune di scambio all’interno del quale è possibile trovare un contenitore idoneo all’elaborazione ed integrazione dei nuclei non risolti di ognuno di noi. In quest’ottica i lutti e le separazioni sono esperienze molto difficili da affrontare perchè comportano la perdita, oltre che della persona reale, anche di aspetti del proprio sé, del senso di identità ed equilibrio interno che è stato affidato all’essere in coppia.
– un altro aspetto coinvolto nella scelta del partner ha a che fare con come ci rappresentiamo il “noi”: questa rappresentazione interna della relazione con l’altro permette di discriminare affettivamente ciò che può essere condiviso da ciò che non lo è. Il tema della condivisione rimanda automaticamente anche al suo contrario, cioè al senso di esclusione, e a come sono stati affrontati non solo i momenti di non incontro con le figure significative, ma anche quelli di esclusione all’interno di dinamiche triangolari, quelle edipiche innanzi tutto, ma anche quelle che coinvolgono i fratelli in alleanze e coalizioni, sia orizzontali, che verticali.
Ultimo elemento, ma non meno importante degli altri, è il modello di coppia che ci portiamo dentro, così come l’abbiamo interiorizzato sulla base della nostra esperienza con i genitori. Il progressivo sovrapporsi di configurazioni di coppia nei vari periodi evolutivi (dall’idealizzazione dei genitori nella prima infanzia, alla coppia che proibisce del periodo edipico, fino alla coppia “smembrata” dallo spirito critico e dalla contestazione adolescenziale e “ricomposta” con l’apporto di altri modelli anche esterni alla famiglia) subisce una progressiva integrazione che nell’adulto raggiunge la rappresentazione interiorizzata di coppia. Questo schema definisce ciò che ci aspettiamo dall’ “essere insieme” e influenza una porzione rilevante della vita affettiva perchè può o meno favorire la capacità di instaurare rapporti di coppia nella vita adulta, nel senso che questi saranno “usati” per confermare o smentire le attese sulla relazione di coppia. Se da un lato infatti questo schema orienta la qualità delle relazioni interpersonali e con il tempo subisce un progressivo accomodamento alla realtà, dall’altro è possibile che permangano aspetti irrisolti che non si piegano all’esame di realtà.
– Un altro fattore importante che influenza la scelta del partner è il mito, e il relativo mandato, familiare.
Il mito familiare è un insieme di rappresentazioni, valori e credenze condivise concernenti l’immagine che i membri di una famiglia hanno di sé stessi e dei ruoli reciproci all’interno della famiglia stessa. Per comprenderlo bisogna quindi concentrarsi sui contenuti simbolici e ideativo-affettivi che appartengono a più generazioni di individui. Ogni individuo infatti trova nell’universo di valori familiari e nei suoi miti una peculiare collocazione, funzionale alla soddisfazione dei suoi bisogni primari e al suo equilibrio psico-affettivo. Il mito familiare da un lato ha una funzione omeostatica perché, assicurando continuità all’identità dei suoi membri e alle relazioni reciproche, funziona come mezzo di resistenza al cambiamento; d’altro canto con il tempo può subire delle modificazioni importanti e questo spesso avviene in corrispondenza delle tappe evolutive, in cui è richiesta una modificazione funzionale dei rapporti all’interno del sistema. È’ intuitivo quindi come anche il mito familiare, e il mandato che lo veicola, abbiano una funzione importante nel determinare la scelta del partner. Quando il mito familiare prevale sui bisogni individuali, la spinta a realizzarlo è tale da sostenere la convinzione che esso esprima il tipo di legame più idoneo a soddisfare le esigenze individuali; in altri casi si può invece assistere a una ribellione, più o meno cosciente, al mandato e a una conseguente scelta del partner con caratteristiche opposte a quelle previste. In entrambi i casi è comune che le aspettative sul piano affettivo rimangano insoddisfatte. Comunque quanto più il mito sarà ricco e articolato tanto maggiori saranno le possibilità di scelta e sviluppo individuale, al contrario tanto più una componente prevarrà sulle altre quanto minori saranno le possibilità che un’ampia gamma di bisogni venga considerata e soddisfatta all’interno della relazione di coppia.
Insomma la scelta del partner, anche quella apparentemente più spontanea, acquista un senso solo alla luce di una più attenta analisi degli elementi che l’hanno determinata. In particolare il mito, in virtù della sua matrice prettamente relazionale, sembra fare da cornice alla costruzione delle rappresentazioni interne individuali.
BIBLIOGRAFIA:
- Angelo C (1999) “La scelta del partner”, in “La crisi della coppia”, Raffaello Cortina, Milano.
- Dicks, H. V. (1967) Marital Tensions. Trad. it. Tensioni coniugali. Studi clinici per una teoria psicologica dell’interazione. Roma: Borla 1992.
- Norsa D, Zavattini G C (1997) “Intimità e collusione. Teoria e tecnica della psicoterapia psicoanalitica di coppia”, Ragffaello Cortina Editore, Milano



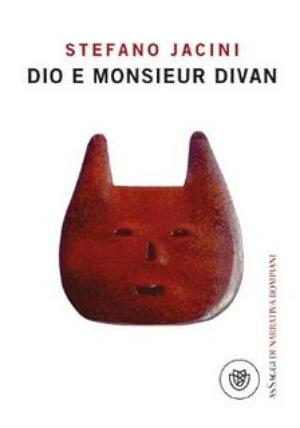
 In questo periodo, in cui un anno è finito e un altro è cominciato, siamo tutti impegnati a fare propositi, si spera buoni, e a decidere a cosa sarebbe meglio rinunciare e cosa portare con noi in questo nuovo inizio d’anno. Il giornalista scientifico David Di Salvo ha pensato analogamente di stilare la classifica, pubblicata sul sito
In questo periodo, in cui un anno è finito e un altro è cominciato, siamo tutti impegnati a fare propositi, si spera buoni, e a decidere a cosa sarebbe meglio rinunciare e cosa portare con noi in questo nuovo inizio d’anno. Il giornalista scientifico David Di Salvo ha pensato analogamente di stilare la classifica, pubblicata sul sito 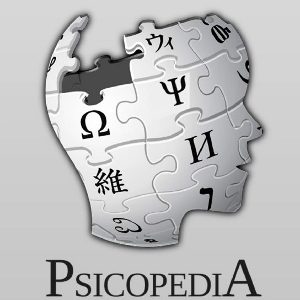 L’attacco di panico è un improvvisa manifestazione di intensa paura in assenza di un reale pericolo, accompagnata da sintomi somatici (tachicardia, intensa sudorazione, fame d’aria, tremore) e cognitivi (paura di impazzire, di perdere il controllo, paura di morire). Generalmente raggiunge rapidamente l’apice ed è di breve durata (di solito 10 minuti o meno).
L’attacco di panico è un improvvisa manifestazione di intensa paura in assenza di un reale pericolo, accompagnata da sintomi somatici (tachicardia, intensa sudorazione, fame d’aria, tremore) e cognitivi (paura di impazzire, di perdere il controllo, paura di morire). Generalmente raggiunge rapidamente l’apice ed è di breve durata (di solito 10 minuti o meno). The previous installment of this sub-series showed that video feedback can heighten maternal sensitivity within the context of adoption. More recent research has examined the effect of video feedback on mothers with psychopathology. This installment will discuss the effect of maternal eating disorders on mother-child interaction and the possible benefits of video feedback therapy.
The previous installment of this sub-series showed that video feedback can heighten maternal sensitivity within the context of adoption. More recent research has examined the effect of video feedback on mothers with psychopathology. This installment will discuss the effect of maternal eating disorders on mother-child interaction and the possible benefits of video feedback therapy. Che passare le domeniche sul divano davanti a una ventina di uomini che corrono dietro ad un pallone non fosse un’attività capace di promuovere lo sviluppo intellettivo, questo si sapeva, ma ora i ricercatori ci dicono che anche chi pratica questo sport mette a rischio il suo cervello.
Che passare le domeniche sul divano davanti a una ventina di uomini che corrono dietro ad un pallone non fosse un’attività capace di promuovere lo sviluppo intellettivo, questo si sapeva, ma ora i ricercatori ci dicono che anche chi pratica questo sport mette a rischio il suo cervello.  Le violenze subite in famiglia sembrano aumentare la sensibilità e la capacità dei bambini di intercettare potenziali stimoli minacciosi nell’ambiente. “Assistere a violenze” o “esserne vittima” poco importa, entrambe mettono in scacco la speranza di sopravvivere e facilitano il rapido incremento della capacità di captare indizi pericolosi.
Le violenze subite in famiglia sembrano aumentare la sensibilità e la capacità dei bambini di intercettare potenziali stimoli minacciosi nell’ambiente. “Assistere a violenze” o “esserne vittima” poco importa, entrambe mettono in scacco la speranza di sopravvivere e facilitano il rapido incremento della capacità di captare indizi pericolosi.
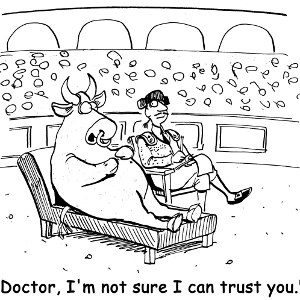




 Vi è mai capitato di osservare in giro una coppia di fidanzati dai comportamenti molto simili e, spesse volte, anche dai tratti somatici affini, tanto da pensare: “è proprio vero, chi si somiglia si piglia!”. Strana affermazione, perché nell’immaginario collettivo si è soliti pensare che gli opposti si attraggono. Infatti, basta guardarsi intorno per verificare che si è attorniati da elementi dai poli opposti incastrati perfettamente, ad esempio due calamite, le batterie del telecomando, la chiave nella toppa, lui alto lei è bassa, lei è loquace e lui parla poco, e potremmo andare avanti per ore.
Vi è mai capitato di osservare in giro una coppia di fidanzati dai comportamenti molto simili e, spesse volte, anche dai tratti somatici affini, tanto da pensare: “è proprio vero, chi si somiglia si piglia!”. Strana affermazione, perché nell’immaginario collettivo si è soliti pensare che gli opposti si attraggono. Infatti, basta guardarsi intorno per verificare che si è attorniati da elementi dai poli opposti incastrati perfettamente, ad esempio due calamite, le batterie del telecomando, la chiave nella toppa, lui alto lei è bassa, lei è loquace e lui parla poco, e potremmo andare avanti per ore.
 Nei gruppi MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy; Segal, Williams & Teasdale, 2001) di prevenzione delle ricadute per i pazienti che hanno avuto una storia clinica di depressione mi colpiscono e affascinano i commenti e le discussioni che spesso emergono. Ma uno in particolare, mi ha incuriosito e arricchito molto. Durante una sessione, circa a metà del percorso MBCT, un paziente alza la mano e dice: “Vorrei dire una cosa. Il percorso che sto facendo mi sta servendo molto. Sto meglio, riesco a riconoscere quando parto con le mie ruminazioni (ricordo che le ruminazioni sono “un insieme di pensieri su una stessa tematica che si presentano anche quando non vi è una necessità immediata o una richiesta ambientale che giustifichi tali pensieri” e sono riferiti al passato, NdA), riesco abbastanza bene a non seguirle troppo… però, ho paura di una cosa: adesso che non perdo così tanto tempo a ruminare, ho paura, perché non so cosa fare, è come se temessi che qualcosa di brutto stesse per accadere!“
Nei gruppi MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy; Segal, Williams & Teasdale, 2001) di prevenzione delle ricadute per i pazienti che hanno avuto una storia clinica di depressione mi colpiscono e affascinano i commenti e le discussioni che spesso emergono. Ma uno in particolare, mi ha incuriosito e arricchito molto. Durante una sessione, circa a metà del percorso MBCT, un paziente alza la mano e dice: “Vorrei dire una cosa. Il percorso che sto facendo mi sta servendo molto. Sto meglio, riesco a riconoscere quando parto con le mie ruminazioni (ricordo che le ruminazioni sono “un insieme di pensieri su una stessa tematica che si presentano anche quando non vi è una necessità immediata o una richiesta ambientale che giustifichi tali pensieri” e sono riferiti al passato, NdA), riesco abbastanza bene a non seguirle troppo… però, ho paura di una cosa: adesso che non perdo così tanto tempo a ruminare, ho paura, perché non so cosa fare, è come se temessi che qualcosa di brutto stesse per accadere!“

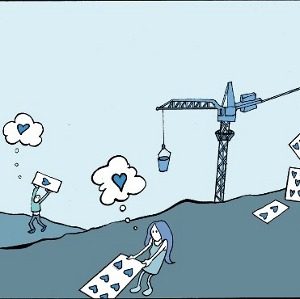
 In tempi in cui il PIL (Prodotto Interno Lordo) sembra essere l’unico indice di rilevanza nazionale, il primo ministro britannico David Cameron ha messo a punto, in collaborazione con l’Ufficio nazionale di statistica, una lista di fattori di felicità, sui quali si baserà – appunto – l’Indice generale di benessere (General Wellbeing Index, GWB).
In tempi in cui il PIL (Prodotto Interno Lordo) sembra essere l’unico indice di rilevanza nazionale, il primo ministro britannico David Cameron ha messo a punto, in collaborazione con l’Ufficio nazionale di statistica, una lista di fattori di felicità, sui quali si baserà – appunto – l’Indice generale di benessere (General Wellbeing Index, GWB).
