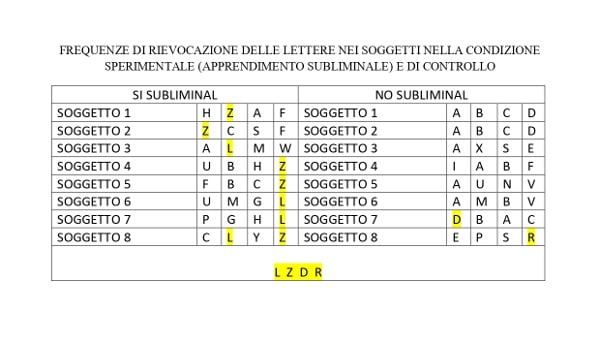La dipendenza patologica e il processo decisionale – Fatica a credito: storie parziali di dipendenza patologica
Ogni essere umano attribuisce un significato alle proprie esperienze anche mediante le informazioni somatiche che avverte in relazione al contesto, tutelando in prima istanza la propria sopravvivenza, e questo lo guida nel processo decisionale.
FATICA A CREDITO: STORIE PARZIALI DI DIPENDENZA PATOLOGICA – (Nr. 2) La dipendenza patologica e il processo decisionale
Tra le
droghe esogene e quelle endogene (ossia le sostanze prodotte normalmente dal nostro corpo) c’è una precisa corrispondenza.
La marijuana si sostituisce all’anandamide, un neurotrasmettitore coinvolto nei meccanismi di regolazione dell’appetito, della memoria, della riproduzione e della proliferazione cellulare.
La cocaina si sostituisce alla dopamina, neurotrasmettitore implicato nei processi di genesi e gestione del movimento e dell’umore;
L’eroina si sostituisce alle endorfine, coinvolte nei processi di gestione del dolore (ne innalzano la soglia), del comportamento, dell’apprendimento, delle emozioni e del sonno;
L’alcool si sostituisce all’acido gamma aminobutirrico, il principale acido inibitorio del sistema nervoso centrale, che svolge un ruolo chiave nella trasmissione degli stimoli ai neuroni ed è direttamente responsabile della regolazione del tono muscolare;
L’ecstasy pompa la serotonina e blocca la dopamina; l’effetto combinato porta da una sensazione di forza ad un collasso cerebrale fatto di ansia, depressione e incapacità di elaborare informazioni sensoriali.
Come sappiamo, le sostanze psicotrope provocano un’alterazione nel funzionamento della corteccia orbitofrontale, deteriorando le capacità cognitive superiori come la progettazione, la pianificazione di strategie efficaci per la soluzione di problemi e la saggezza di apprendere dagli errori.
I circuiti neuronali dopaminergici meso-cortico-limbici svolgono un ruolo rilevante nei meccanismi della ricompensa ed in tutte le condizioni cliniche in cui la capacità di provare piacere risulta alterata, anche il coinvolgimento funzionale di altri importanti sistemi neurotrasmettitoriali è stato evidenziato sperimentalmente.
Il cervello cognitivo è la parte più giovane e più piccola dell’encefalo ed ha a che fare prevalentemente con il mondo esterno, si occupa di capire come funzionano le cose, come realizzare gli obiettivi, come gestire il tempo e la processualità delle azioni.
I lobi frontali ci permettono di usare il linguaggio ed il pensiero astratto, sono in grado di assorbire ed integrare le informazioni che ricevono dando loro un senso.
I lobi frontali ci permettono di riflettere, di immaginare e creare scenari futuri, di prevedere le conseguenze dell’esecuzione o dell’omissione di un’azione.
Sono essenziali anche per la nostra capacità di instaurare relazioni armoniose con gli altri, ci consentono di capire le ragioni di chi ci sta intorno e di adattarci a percezioni, aspettative e valori diversi dai nostri, sono la sede dell’empatia.
I lobi frontali, nella maggior parte dei casi, ci danno la possibilità di non fare cose che potrebbero metterci in imbarazzo o cose che potrebbero danneggiare gli altri, essi sono determinanti nel depotenziare gli impulsi traducendoli in comportamenti socialmente accettabili.
Il cervello emotivo, invece, (composto dal sistema limbico) è il cuore del sistema nervoso centrale, il suo compito principale è quello di occuparsi del nostro benessere, di rilasciare una certa quantità di ormoni quando rileva un’opportunità speciale.
Il cervello emotivo provoca delle sensazioni viscerali che interferiscono su qualsiasi attività stia svolgendo la mente e ha un’enorme influenza sulle decisioni che prendiamo nel corso della nostra vita.
Essendo sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista biochimico più semplice del cervello cognitivo, valuta in modo molto più approssimativo le informazioni che riceve e giunge a conclusioni che possono essere anche in contrasto con la nostra parte razionale.
Potremmo dire che il suo scopo principale è quello di assicurare la sopravvivenza, quindi deve basarsi sulla rapidità decisionale e sull’accumulo di risorse immediate per far fronte a situazioni di pericolo reali o presunte.
Le informazioni sensoriali, le sensazioni, che riceviamo dal mondo esterno convergono nel talamo, un’area del sistema limbico, e vengono trasmesse sia verso l’amigdala, la parte più profonda del sistema limbico, sia verso i lobi frontali, dove raggiungono la consapevolezza.
Il neuroscienziato J. LeDoux definisce il percorso verso l’amigdala la via breve perché è estremamente veloce, e il percorso verso i lobi frontali la via lunga perché richiede diversi millisecondi in più per decodificare l’informazione (LeDoux, 1996).
L’amigdala ha la funzione di definire se un’informazione in entrata è pericolosa o meno, se è rilevante o no ai fini della sopravvivenza.
Svolge questo compito in collaborazione con l’ippocampo, il quale confronta la nuova informazione con le esperienze presenti in memoria per poterla connotare come sicura o come un allarme.
Se l’amigdala rileva un’informazione minacciosa, invia un messaggio istantaneo all’ipotalamo e al tronco dell’encefalo, dopodiché queste strutture secernono gli ormoni dello stress (cortisolo ed adrenalina) sollecitando una risposta del sistema nervoso autonomo e organizzando una risposta di tutto il corpo.
L’amigdala elabora le informazioni provenienti dal talamo più velocemente dei lobi frontali, quindi è questa struttura posta nella parte profonda del sistema limbico che decide se le informazioni in arrivo sono minacciose, lo fa prima ancora che i lobi frontali possano capire se esiste un pericolo reale.
Il nostro cervello, essendo molto più vecchio di noi che lo trasportiamo all’interno della scatola cranica, ha tutte le sue ragioni per funzionare così e per processare le informazioni in questo modo, la sopravvivenza della nostra specie (fino ad oggi…) non può che confermarlo.
In condizioni normali l’amigdala funziona abbastanza bene e riesce a captare in modo adeguato i segnali di pericolo, in condizioni alterate, però, aumenta la possibilità che possa interpretare in modo erroneo il significato di una situazione portando a conclusioni approssimative. Ad esempio, la capacità di costruire relazioni con gli altri dipende anche da quanto si è capaci di valutare con precisione se le loro intenzioni siano benevole o minacciose, un fraintendimento può condurre a incomprensioni anche dolorose nei rapporti familiari o lavorativi.
Per funzionare in modo efficace nell’interazione sociale è necessario possedere la capacità di valutare rapidamente come si sentono le persone, aggiustando continuamente il proprio comportamento.
Quando i sistemi di allarme governati dall’amigdala funzionano in modo difettoso, rispondere in modo aggressivo o sottomesso a espressioni facciali innocue o a commenti trascurabili diventa molto più probabile.
Se il compito dell’amigdala è quello di preparare semplicemente la risposta attacco/fuga e non quello di emettere giudizi, i lobi frontali hanno la funzione di procedere a valutazioni più accurate delle informazioni provenienti dal mondo esterno.
Le capacità esecutive della corteccia prefrontale consentono di osservare ciò che succede, di fare previsioni su ciò che potrebbe accadere e di stabilire come agire mediante scelte consapevoli.
Avere il tempo di rispondere permette al cervello esecutivo di inibire, organizzare e modulare le reazioni automatiche che sono state programmate dal cervello emotivo e questa capacità è indispensabile anche per preservare le relazioni con gli altri esseri umani.
Ad esempio, i lobi frontali ci dicono che la rabbia e le minacce altrui sono espressione del loro stato emotivo.
Nei casi in cui non si raggiunge un equilibrio tra l’amigdala e i lobi frontali, controllare le emozioni e gli impulsi diventa molto più difficile e ricorrere a risposte automatiche anche alla minima rilevazione di pericolo è molto più frequente.
Attraverso studi di neuroimaging si è rilevato che paura, tristezza e rabbia intense aumentano l’attivazione di aree sottocorticali e riducono l’attività in varie aree del lobo frontale.
Quando questo si verifica, le capacità inibitorie dei lobi frontali vengono meno e le persone perdono il controllo, danno risposte eccessive ai minimi segnali di potenziali minacce o hanno reazioni d’ira per la minima frustrazione.
Un contesto sociale ed un sistema relazionale in cui paura, tristezza e rabbia si impongono come elementi prevalenti, produrrà risposte sempre più governate dall’amigdala e sempre meno dai lobi frontali, in una sorta di circolo vizioso che si autoalimenta. E’ importante ricordare che le emozioni non sono contrapposte alla ragione, attraverso di esse assegniamo un valore all’esperienza e per questo sono alla base della ragione, è l’equilibrio tra cervello emotivo e cervello razionale che produce l’esperienza di sé.
Quando questi due sistemi sono in sintonia ci sentiamo noi stessi, ma quando ci troviamo in situazioni in cui è in gioco la nostra sopravvivenza, possono funzionare in modo disfunzionale o approssimativo.
Paura, tristezza e rabbia sono alcune delle emozioni che avvertiamo durante le relazioni con gli altri e che possono essere determinanti in molte delle decisioni che prendiamo.
Nel caso delle persone con una dipendenza patologica, la paura, la tristezza e la rabbia sono emozioni alquanto frequenti prima, durante e dopo un percorso terapeutico e sono facili da rintracciare in molti contesti e in molti momenti della storia individuale di queste persone.
La paura di non farcela, di non essere capaci di condurre una vita senza sostanze, la paura di provare emozioni a cui non si è più abituati o a cui si è anestetizzati, la paura di chiedere aiuto e la paura di non poter essere aiutati, la paura della normalità o di essere se stessi nelle relazioni sociali. La tristezza per aver perso credibilità, per l’incapacità di vedere un futuro possibile, per essere troppo in ritardo o per aver gettato occasioni e opportunità.
La rabbia per i limiti che un certo stile di vita ha prodotto, per il dover fare cose che non si vorrebbero fare.
Ma anche la tristezza e/o la rabbia per non poter più fare uso di sostanze, rinunciando ad un piacere e ad una soluzione che per diverso tempo si è dimostrata efficace, come se questi pazienti non appartenessero solo alle categorie diagnostiche del DSM ma anche del DSMM, cioè del Devo Smettere Mio Malgrado.
Come sappiamo, e come accennato in precedenza, le emozioni e i sentimenti hanno un ruolo dirimente nella maggiore parte delle scelte che facciamo e rappresentano un aspetto cruciale nel processo decisionale di un individuo.
Il processo decisionale, infatti, è particolarmente condizionato dalle risposte somatiche ed emotive avvertite a livello soggettivo e non necessariamente elaborate attraverso la consapevolezza. I cambiamenti fisiologici che si producono nell’organismo, in risposta all’esperienza emotiva, agiscono sui circuiti neurali influenzando le valutazioni e le decisioni.
Di fronte ad una scelta non attiviamo un processo di analisi per considerare minuziosamente i pro e i contro delle alternative ma, anche nel caso di problemi complessi o di situazioni con importanti risvolti personali o sociali, utilizziamo strategie decisionali che fanno riferimento agli esiti di esperienze passate e che possono avere analogie con l’esperienza presente.
Le vicissitudini che intercorrono nel corso della nostra vita lasciano tracce che prendono la forma di emozioni e sentimenti con connotazioni positive o negative, e svolgono un ruolo cruciale nel processo decisionale.
La mia decisione di fronte ad una situazione sarà condizionata dal tipo di emozione buona o cattiva che ho provato in situazioni che considero simili a quella in cui mi trovo.
Il neuroscienziato portoghese Antonio Damasio chiama queste tracce marcatori somatici (Damasio, 1995), cioè vissuti corporei o viscerali che diventano una sorta di etichetta delle esperienze vissute.
I marcatori somatici sono uno strumento automatico che facilita il compito di selezionare opzioni vantaggiose dal punto di vista biologico ed evolutivo.
Come sostiene Damasio, al contrario di quanto spiegava Cartesio, mente e corpo non sono entità separate, il cervello non può essere studiato senza tenere conto dell’organismo a cui appartiene e dei suoi rapporti con il contesto esterno.
Quando diciamo corpo intendiamo anche la testa, a meno che non si parli di Luigi XVI…
Integrando ciò che si è accennato dal punto di vista neurobiologico con l’estrema sintesi della descrizione del processo decisionale, possiamo dedurre che: se l’informazione proveniente dal mondo esterno è intercettata prima dal sistema limbico e poi dal sistema cognitivo (prima decido e poi capisco) e se le nostre decisioni prendono il via dal sistema emotivo prima che da quello razionale, allora come ci sentiamo, cioè quali suggerimenti ci propone il nostro corpo attraverso le sue manifestazioni somatiche in relazione al contesto in cui si trova, diventa un elemento di riflessione fondamentale per descrivere ed obiettivare comportamenti, atteggiamenti e relazioni tra individui.
Ogni essere umano attribuisce un significato alle proprie esperienze e lo fa anche mediante le informazioni somatiche che avverte in relazione al contesto, dalle emozioni che prova, tutelando in prima istanza la propria sopravvivenza e dando priorità alle segnalazioni, vere o presunte, di potenziali pericoli.
Le minacce alla sopravvivenza non provengono soltanto dalle circostanze concrete in cui emerge una questione di vita o di morte, ma possono riguardare anche eventi in cui viene messa in pericolo la sopravvivenza della propria identità, della propria reputazione o dei propri scopi esistenziali.
Quando questi aspetti vengono minacciati si attiverà il sistema di allerta del cervello che favorirà risposte emotive basate più sull’impulsività che sulla riflessione, privilegiando un ragionamento rapido attratto solamente da informazioni approssimative.
Per questo motivo può essere utile individuare quali sono le circostanze e i contesti a cui gli individui tendono a dare una connotazione minacciosa, un significato di pericolo.
Può essere utile capire e descrivere quali sono gli elementi che la società attuale traduce come minacciosi e quali sono le ragioni per cui anche situazioni generalmente innocue vengono descritte semanticamente in modo pericoloso.
Se, ad esempio, corrispondere ad un modello sociale prevalente diventa di vitale importanza, va da sé che non riuscire a farlo diventa una minaccia per la propria sopravvivenza e, di conseguenza, anche i tentativi di arrivare a quel modello non saranno governati da strategie razionali ma da risposte emotive approssimative o eccessive.
Se, ad esempio, esprimere le proprie opinioni diventa un esercizio per aver ragione dove la possibilità di un dibattito si traduce solamente in un conflitto da vincere, allora perdere potrebbe essere catastrofico, potrebbe danneggiare in modo irreparabile la propria reputazione.
Se, ad esempio, la spuntina blu di WhatsApp non è immediata, allora si tenderà a dare una connotazione di trascuratezza e non di distrazione al tempo di attesa per una risposta.
Ci troviamo a ridefinire il significato di termini e concetti.
Il concetto di umiltà che, da sentimento conseguente ad un comportamento improntato alla consapevolezza dei propri limiti e al distacco da ogni forma di orgoglio e sicurezza eccessivi di sé (Enciclopedia Treccani online), diventa soltanto un rischioso atteggiamento che prelude alla sottomissione.
Perfino l’idea di dover imparare produce la vergogna di non sapere già.
Anche l’aggressività, che è ormai una strategia per far vedere che ci si fa rispettare, diventa sinonimo di avere carattere e relega la calma e la cortesia a disdicevoli esibizioni di insicurezza.
— Ero in coda per entrare al museo, di fronte a me due genitori gentili e premurosi conversavano mentre il loro bambino fantasticava storie piratesche con il suo giocattolo tra le mani. Nell’incedere della storia che stava immaginando nella sua mente, probabilmente assalti a galeoni o ricerche di tesori nascosti nelle profondità dell’oceano, il suo giocattolo di Jack Sparrow cadde esattamente sopra il mio piede.
Mentre sorridevo per raccogliere il pirata di plastica notai la madre girarsi verso il figlio, guardare me, e richiamarlo con particolare energia ed autorità.
Pensai che se non ci fossi stato io, cioè qualcuno che facesse sentire la madre osservata, forse lei si sarebbe comportata diversamente con suo figlio, forse si sarebbe limitata a raccogliere il pupazzo e non avrebbe dissolto le sue fantasie o interrotto l’assalto ai galeoni. Forse la madre non si sarebbe sentita in dovere di dimostrare a me, l’osservatore, che era capace di far vedere a suo figlio chi è che comanda, che è assolutamente in grado di farsi rispettare, che suo figlio le ubbidisce.
Pensai che secondo lei, io, cioè un osservatore sconosciuto, dessi per scontato che è così che ci si fa rispettare.
Al termine della scena, mentre il bambino con poca fatica ritornava alle battaglie per i tesori nascosti, la madre si voltò e il suo viso sembrava quello di chi ha superato un esame.
Mi sembrò anche, però, che ci fosse come un’ombra di dubbio mentre ripassava nella sua mente le azioni che aveva commesso, come se si chiedesse perché si era sentita in dovere di comportarsi così.
(Non so se questo sia accaduto veramente oppure se sono io ad aver sperato che accadesse).