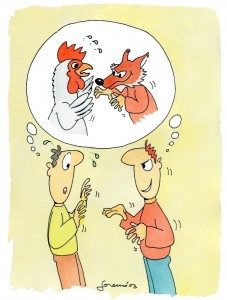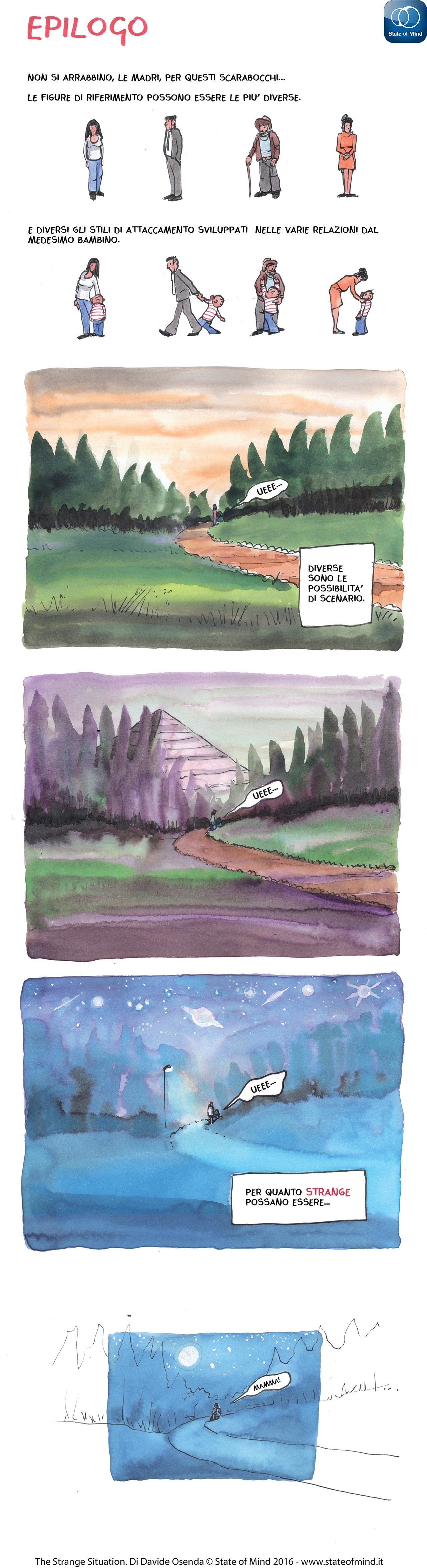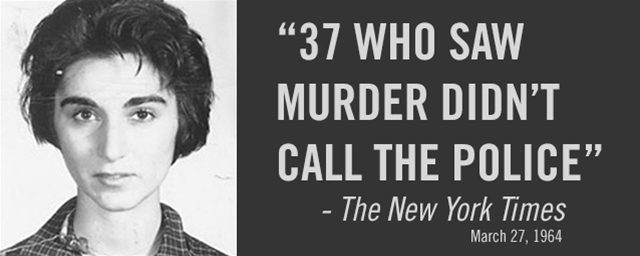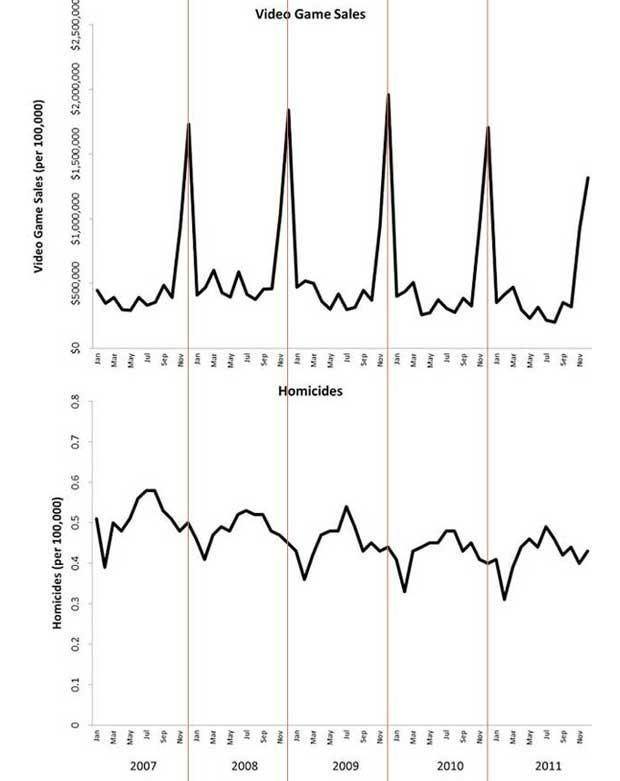Psicoterapia con pazienti stranieri secondo l’approccio cognitivo comportamentale: verso una prospettiva italiana
Una riflessione sull’efficacia della psicoterapia con pazienti stranieri, non fa solo riferimento ad un bisogno contingente al recente fenomeno migratorio italiano, bensì si rivolge alla realtà clinica che caratterizzerà l’utenza delle nostre strutture pubbliche e private da oggi agli anni a venire.
Simona Bianco, Claudia Emma Messore, Giulia Radice – OPEN SCHOOL Scuola di Psicoterapia Cognitiva e Ricerca
Psicoterapia con pazienti stranieri: introduzione
Negli ultimi anni in Italia il numero di persone migranti è aumentato notevolmente fino a superare, solo nell’ultimo decennio, i tre milioni di residenti stranieri (Caritas, 2010). Sebbene tra i cittadini stranieri prevalga una percezione positiva del proprio stato di salute (ISTAT, 2012), la salute mentale dei migranti è oggi, tanto in Italia così come in Europa, una problematica crescente, su cui vale la pena soffermarsi dal punto di vista clinico e sociale.
L’incontro tra servizi e pazienti stranieri conduce ogni giorno verso la rivelazione di nuove e peculiari espressioni di disagio psichico legate ad elementi culturali specifici (Tarricone et al. 2012) e obbliga a interrogarsi sull’efficacia e l’adeguatezza degli interventi proposti.
A differenza di altri paesi, coma la Francia, l’Inghilterra e soprattutto gli Stati Uniti, l’Italia si è trovata solo di recente a confrontarsi con il fenomeno migratorio e con la sua conseguente trasformazione identitaria, che ha portato il nostro paese a trasformarsi da luogo emigratorio a meta immigratoria, ed è anche per tale motivo che la letteratura italiana relativa alla psicoterapia con pazienti stranieri è meno florida rispetto a quella presente in altri paesi.
Obiettivo di questo lavoro è di operare una riflessione sulla psicoterapia con pazienti stranieri non-occidentali (Schraufnagel et al. 2006) secondo una prospettiva cognitivo comportamentale.
Una riflessione sull’efficacia della psicoterapia con pazienti stranieri non-occidentali ad orientamento cognitivo-comportamentale, non fa solo riferimento ad un bisogno contingente al recente fenomeno migratorio italiano, bensì si rivolge alla realtà clinica che caratterizzerà l’utenza delle nostre strutture pubbliche e private da oggi agli anni a venire.
Nella seguente review si è deciso di analizzare solo e unicamente studi inerenti i Disturbi d’Ansia e dell’Umore e pazienti stranieri. Tale decisione è stata dettata dalle seguenti ragioni: l’efficacia ampiamente riconosciuta l’approccio cognitivo comportamentale nel trattamento dei Disturbi d’Ansia e dell’Umore (Ruggiero & Sassaroli, 2013), la scarsità di dati relativi ad altri quadri psicopatologi. Inoltre, sebbene molti studi epidemiologici mostrino un eccesso di psicosi tra i migranti di prima e seconda generazione (Morgan, 2005), molti dei disturbi inizialmente diagnosticati come psicotici tendono a evolvere in quadri più coerenti con diagnosi di PTSD o depressione (Cremonese, 2014).
Psicoterapia con pazienti stranieri: precisazioni terminologiche preliminari
In primo luogo, prima di parlare di psicoterapia con pazienti stranieri, appare necessario operare una riflessione su alcuni termini, come razza, etnia, cultura e minoranza. Nonostante alcune differenze terminologiche possano talvolta apparire scontate, una chiara conoscenza della definizione di queste espressioni e del loro significato condiviso, diviene fondamentale all’interno della pratica clinica.
L’espressione
razza non indica una categoria di individui definita su criteri biologici, ma piuttosto un costrutto sociale usato per identificare ogni raggruppamento d’individui costituito in modo empirico sulla base di caratteri somatici esteriori comuni (razza, n.d.), come ad esempio, il colore della pelle.
Il termine etnia viene invece usato per indicare un gruppo di individui che condividono un medesimo patrimonio in termini di storia, lingua, rituali ecc. Si nota subito come i due termini qui sopra definiti siano solo parzialmente interscambiabili: individui della stessa razza possono appartenere a etnie differenti, sia in termini di storia sia di cultura (nativi hawaiani e i vietnamiti americani).
La parola cultura, invece, indica quell’insieme di credenze, norme e valori che determinano il significato attribuito alle esperienze ed eventi di vita. Ancora una volta tra i termini esiste solo una parziale sovrapposizione, per cui individui appartenenti alla medesima razza ed etnia, possono possedere caratteristiche culturali uniche (messicani vs cubani) (Schraufnagel et al. 2006).
All’interno di questo articolo si è quindi deciso di utilizzare il termine minoranza, inteso come gruppo di cittadini che nell’interno di uno stato si distinguono dalla maggioranza, secondo i casi, per la razza o per la lingua o per la religione, a cui s’accompagna molte volte una diversa coscienza nazionale (minoranza, n.d.), per indicare tutto ciò che si colloca al di fuori della cultura giudeo-cristiana occidentale euro-americana (non occidentale).
Va tuttavia rilevato che la scelta di tale termine ha un valore puramente di convenienza espositiva e che chi scrive riconosce i limiti dei termini adoperati.
Il rapporto tra cultura e malattia nella psicoterapia con pazienti stranieri
L’OMS definisce la salute mentale come:
Stato di benessere nel quale il singolo è consapevole delle proprie capacità, sa affrontare le normali difficoltà della vita, lavorare in modo utile e produttivo ed è in grado di apportare un contributo alla comunità” e chiarisce che “non c’è salute senza salute mentale
(OMS, 2005).
Questa definizione universalmente condivisa può tuttavia declinarsi in molti modi differenti. Immaginiamo di trovarci davanti una persona in evidente stato di sofferenza psicologica e di porle le domande elaborate da Kleinman (1980) per la comprensione del modello esplicativo di malattia del paziente:
- Quale pensa che sia la causa del suo problema?
- Perché pensa sia accaduto?
- Cosa pensa che la malattia causi alla sua persona?
- Quanto è grave la sua malattia? Durerà molto o poco tempo?
- Di quali trattamenti avrebbe bisogno?
- Cosa si aspetta di ottenere da questi trattamenti?
- Qual è il problema principale che questa malattia le ha causato?
Come ci risponderebbe un nostro connazionale italiano? Certo le risposte possibili potrebbero essere tante, ma se ripetessimo l’esercizio un paio di volte e confrontassimo poi le risposte, potremmo verosimilmente scoprire alcuni punti in comune tra queste.
Se invece, nel ripetere l’esercizio, ponessimo nella pratica clinica tale domanda a un italiano e, allo stesso tempo, la ponessimo in contesti di psicoterapia con pazienti stranieri come, per es., un brasiliano, un nepalese e un etiope? Molto probabilmente le risposte ottenute da soggetti delle differenti nazionalità sarebbero molto diverse Tuttavia, ognuna di queste risposte sarebbe parimenti valida ai fini dell’obiettivo comune: la salute.
L’espressione di un disagio e l’idea di salute dipendono in gran misura dal modo in cui l’individuo interpreta gli eventi intorno a sé, la propria storia di vita e le relazioni causa-effetto che attribuisce agli eventi (Biorci 2009). In questo processo la cultura di appartenenza gioca un ruolo fondamentale.
Per Kleiman (1980) il modello esplicativo che il paziente produce della propria malattia è il risultato dell’insieme di nozioni e itinerari che egli stesso attiva a partire dall’esperienza della malattia e dalla ricerca della cura, dalle ipotesi e dalle cause di malattia messe in campo nei contesti familiari e sociali di appartenenza. L’analisi delle differenze e le riflessioni sul legame tra cultura e malattia mentale hanno coinvolto molti studiosi e visto la nascita dell’etnopsichiatria intesa come disciplina di studio sistematico delle teorie e delle pratiche psichiatriche di un determinato gruppo etnico che si occupa delle interpretazioni tradizionali delle malattie mentali e delle procedure di guarigione tradizionali (Tseng, 2001).
Il rapporto tra psicopatologia e immigrazione
In merito alla relazione tra psicopatologia e immigrazione, ci sono principalmente due linee di ricerca: una prende in considerazione l’immigrazione come fattore di rischio epidemiologico e ne studia l’impatto sull’incidenza dei disturbi mentali, l’altra studia la relazione tra cultura e psicopatologia.
La migrazione è stata identificata sia come fattore protettivo sia come fattore di rischio per alcuni disturbi psichiatrici. In Nord America, l’effetto migranti sani (la scoperta che persone recentemente immigrate sono più in salute rispetto alla popolazione di nativi) è stato ampiamente riportato tanto per ciò che concerne la salute mentale (Aglipay et al. 2012), quanto rispetto a quella somatica (Ng, 2011). D’altro canto, studi europei hanno riportato una maggiore prevalenza di disturbi mentali nella popolazione di migranti (Missinne e Bracke, 2010); risultati simili sono stati trovati anche in America del Nord ma solo per specifici sottogruppi di migranti (Cislo et al. 2010).
Anche le Linee Guida Canadesi per la Salute degli Immigrati (Kirmayer et al. 2011) affermano che la migrazione può essere considerata un fattore di rischio per la depressione (e probabilmente di altri disturbi mentali) se associata ad esperienze avverse. Ulteriori possibili fattori di rischio per l’insorgenza di disturbi depressivi e d’ansia nei migranti potrebbero essere individuati, come ipotizzato anche da Cimino (2015), da un maggiore carico famigliare e sociale, un elevato numero di figli da crescere, violenze domestiche, uno scarso livello di integrazione sociale e incertezze legate al futuro. Possiamo certamente osservare che gli studi fino ad ora condotti non permettano di chiarire definitivamente il peso della variabile migrazione all’interno dell’insorgenza di una condizione di disagio psicofisico. D’altra parte si potrebbe ipotizzare che sia il ritrovarsi a far parte di una minoranza, più che l’atto migratorio in sé a determinare la comparsa di uno stato di malessere.
In un altro filone di ricerche, la cultura è stata descritta come un fattore che influenza l’espressione sintomatica del disturbo mentale, in particolare dei disturbi ansioso-depressivi. Sebbene la ricerca epidemiologica cross-culturale abbia confermato la presenza di depressione maggiore e di disturbi ansiosi in tutto il mondo, l’espressione e l’interpretazione sintomatica e la risposta sociale a tali patologie varia ampiamente attraverso i differenti contesti culturali (Kirmayer et al. 1995). In generale, sebbene esista una gamma di emozioni universali, ci sono sentimenti più complessi che fanno riferimento a tratti dell’interazione sociale e a contesti specifici che variano a livello cross-culturale.
Tale variazione può influenzare l’esperienza e l’espressione di forme di disforia quali depressione e ansia, che hanno connotazioni cultura-specifiche. In generale, secondo la psichiatria evolutiva, la depressione è connessa alla risposta alla mancanza di relazioni interpersonali, status sociale o incentivi, mentre l’ansia è maggiormente correlata all’anticipazione di minacce al corpo o alla salute propria o altrui (Kirmayer, 2001). Le emozioni collegate a tali risposte sono elaborate in modalità distinte per contesti culturali e sociali che influenzano i sistemi neurali, la rappresentazione psicologica e i pattern interazionali nel corso di vita (Harrè et al. 1995).
In molte culture i disturbi dell’umore e disturbi d’ansia non sono visti come problemi relativi alla salute mentale, bensì difficoltà di ordine sociale o morale (Kyrmayer et al. 1989); si potrebbe dunque ipotizzare che una differente attribuzione di significato clinico alla sintomatologia ansioso depressiva possa condurre a un minor accesso di pazienti stranieri ai servizi di salute mentale e quindi al trattamento.
È infine molto interessante riportare quando notato da Nazroo e colleghi (2005), secondo cui una recente storia di immigrazione si condurrebbe maggiormente verso la tendenza alla manifestazione di disturbi somatici funzionali come equivalenti di sintomi ansioso-depressivi, mentre una più remota storia di migrazione comporterebbe, come correlato del processo di acculturazione e di adattamento al paese di accoglienza, una maggiore espressività della sofferenza psichica secondo le tradizionali tipologie della cultura occidentale rappresentati da sintomi ansiosi e depressivi. Per esempio, rispetto all’espressione dei disturbi depressivi e ansiosi, studi che mettono a confronto gruppi provenienti da background culturali differenti sia negli stessi paesi sia tra paesi differenti, hanno rilevato, nella presentazione della depressione, una maggiore frequenza di lamentele somatiche, una minor discriminazione tra disturbo ansioso e depressivo, e un più basso livello di sentimenti di colpa nelle popolazioni non occidentali (Caplan et al. 2010).
Ancora, in uno studio del 2013, Saraga et al. hanno messo a confronto 85 immigrati e 34 controlli afferenti all’Unità per i Disturbi d’Ansia e dell’Umore dell’Ospedale Universitario di Losanna, ed hanno rilevato che in pazienti con criteri DSM IV per il disturbo depressivo maggiore, la presentazione clinica dei migranti era caratterizzata da comorbidità con più diagnosi, in particolare ansia, disturbi somatoformi e PTSD, e da un decorso più grave e cronico non remissivo.
I fenomeni migratori ci permettono così di produrre nuove indagini, fornendoci informazioni interessanti sulla mutevolezza dell’espressione del disturbo mentale in funzione del luogo in cui si vive.
La psicoterapia con pazienti stranieri: l’approccio cognitivo-comportamentale
Come già detto precedentemente, l’esperienza migratoria rappresenta, per i pazienti stranieri, uno choc culturale ed identitario in cui il soggetto si trova di fronte alla sfida di dover ridefinire il proprio progetto di vita, di delinearne le coordinate nello spazio e nel tempo e ciò, secondo Cimino (2015), lo esporrebbe a un maggiore rischio di sviluppare disturbi mentali gravi. Questi dati hanno portato a riconsiderare il ruolo degli eventi di vita stressanti nello sviluppo e nella risposta alla cura, alle quali in precedenza veniva attribuita un’eziologia differente (Boydell, 2013).
Si può quindi affermare che le persone non esprimano il loro disagio secondo una modalità fissa e predeterminata dalla cultura di origine, ma possano modificare l’espressione del proprio malessere conformemente agli standard del paese ospitante.
Considerando queste evidenze, si potrebbe quindi ipotizzare che non sia necessario utilizzare una terapia transculturale, oppure una terapia ad hoc per ogni cultura, bensì un approccio maggiormente validato in occidente, con alcuni accorgimenti cultura-specifici. Ne è un esempio la Culturally Adapted Cognitive Behavior Therapy, (CA-CBT).
La Psicoterapia Cognitivo Comportamentale (CBT), come illustrato dall’Organizzazione Mondiale di Sanità, ha un ruolo elettivo nel trattamento dei disturbi d’ansia, disturbo ossessivo compulsivo (NICE 2004) e della depressione (OMS, 2012)
L’aspetto teorico cardine della CBT pone in interconnessione, pensieri (beliefs), emozioni e comportamenti. Il disturbo mentale e le problematiche della sfera emotiva sono visti come la conseguenza di pensieri disfunzionali che persistono nel tempo a causa di meccanismi di mantenimento (Semerari, 2000). Il soggetto che interpreta la realtà mediante pensieri disfunzionali e idee irrazionali, proverà quasi certamente sofferenza e in alcuni casi svilupperà psicopatologia. L’obiettivo della Psicoterapia Cognitivo Comportamentale è, quindi quello di individuare i pensieri disfunzionali per poi sostituirli con pensieri maggiormente adattivi e funzionali per il soggetto attraverso tecniche specifiche.
Il modello di malattia alla base della CBT, e dell’approccio cognitivo comportamentale in generale, è di stampo prettamente occidentale (Rathod et al. 2009). Molti elementi della cura, come ad esempio l’aspetto individuale e di lavoro, che il paziente deve fare per costruire in collaborazione con il terapeuta un nuovo benessere, riflettono la cultura all’interno della quale la CBT opera.
Un approccio di questo tipo alla malattia e alla cura potrebbe andare in contrasto, per esempio, con alcuni modelli di vita orientale centrati principalmente sul gruppo e sulla famiglia piuttosto che sul singolo. Anche la modalità collaborativa con cui terapeuta e paziente avanzano nella comprensione comune del disagio può apparire estremamente pragmatica e di difficile comprensione per alcune culture, che concepiscono il rapporto tra curante e curato in ottica di subordinazione del secondo nei confronti del primo (Rathod, 2009). Tuttavia è possibile adottare alcuni accorgimenti attraverso cui rendere la CBT fruibile anche quando l’idea di malattia, cura e psicoterapia con pazienti stranieri sia estremamente differente dal punto di vista culturale del terapeuta.
Ad esempio nella Chinese Taoist Cognitive Psychotherapy, (CTCP), che rappresenta un tentativo di incorporare i principi del Taoismo all’interno di una terapia cognitiva, il terapeuta si focalizza inizialmente sull’identificazione di stressors attuali e sulla valutazione dei beliefs, del sistema di valori, del conflitto e dello stile di coping, per poi assumere successivamente un ruolo più didattico: ad esempio, il terapeuta CTCP utilizza all’incirca cinque ore per illustrare al paziente i 32 caratteri taosti (Zhang et al.. 2002). Per comprendere meglio il ruolo didattico assunto dal terapeuta nella CTCP può essere utile far riferimento a uno dei principi terapeutici suggeriti da Hwang et al.. (2006) per la psicoterapia con pazienti stranieri cino-americani: i terapeuti possono guadagnare la fiducia del paziente presentando se stessi come figure autorevoli e in grado di fornire aiuto.
Ciò deriva dal fatto che nella cultura cinese la gerarchia dei ruoli, la struttura sociale e le figure autoritarie vengono viste con estremo rispetto (Lin, 2007; Zhang et al. 2002), molto più che nelle culture euro-americane. Per mantenere tale autorità il terapeuta potrebbe dover assumere un ruolo più proattivo, rivolgendo al cliente suggerimenti e indicazioni precise nell’insegnamento delle competenze e delle pratiche terapeutiche utili per il raggiungimento di un immediato sollievo sintomatico (Hwang et al. 2006). Tale modalità di conduzione terapeutica appare sotto molti punti di vista distante a quella abitualmente adottata dai terapeuti CBT occidentali.
Ancora, Organista e Muñoz (1997), forniscono una dettagliata serie di indicazioni utili per facilitare lo sviluppo di una buona relazione nella psicoterapia con pazienti stranieri latini/ispanici. In primo luogo, è necessario conoscere e aderire ad alcuni values specifici, tra cui l’espressione di rispetto nei confronti del paziente, esprimibile tramite l’uso di forme di cortesia quali señor o señora e il mantenimento di un atteggiamento orientato al para servirle (per servirla). Gli autori proseguono espongono le difficoltà nella psicoterapia con pazienti stranieri ispanici, soprattutto nell’applicare il modello ABCDE di Ellis.
Infatti, sebbene acquisiscano subito il concetto di pensiero positivo e pensiero negativo, la difficoltà di tradurre in spagnolo l’acronimo ABCDE rende spesso impraticabile questa tecnica. Si potrebbe tuttavia obiettare che tali difficoltà possano associarsi anche a eventuali barriere linguistiche. Ancora, Organista e Muños, suggeriscono di esplorare insieme al paziente le sue credenze religiose, anche quando questi riferisce di aver preferito l’atto del pregare allo svolgimento degli homework.
Si può quindi asserire che i beliefs culturali del paziente relativi alla malattia mentale, alla cura e alla psicoterapia cognitiva-comportamentale debbano essere considerati ai fini dell’efficacia della terapia stessa. Seppur tale affermazione trovi una ragione d’essere in ogni situazione terapeutica e di fronte a qualsiasi paziente, l’importanza del processo di modellamento o di adattamento (culturale) appare ancora più fondamentale all’interno di situazioni cliniche in cui la valutazione dei belief, dei processi di pensiero e delle modalità di gestione, valutazione ed espressione delle emozioni, necessita, da parte del clinico, di un ulteriore sforzo di decentramento al fine di gestire in modo opportuno -e non come un ostacolo- le differenze culturali che intercorrono nella psicoterapia con pazienti stranieri. Tali differenze, durante il trattamento, possono divenire più o meno evidenti e possono più o meno diventare oggetto di analisi, se non addirittura il focus della terapia.
Psicoterapia con pazienti stranieri: evidenze cliniche
La letteratura italiana riguardante la salute mentale delle minoranze presenti sul nostro territorio è ancora esigua e sono praticamente nulli i contributi specificatamente derivanti da terapeuti con formazione cognitivo comportamentale.
I dati a sostegno della valenza clinica delle terapie cognitivo comportamentali culturalmente adattate (CA-CBT) di seguito riportati fanno prevalentemente riferimento a studi condotti sul territorio americano, per cui eventuali riflessioni tratte dal lettore dovranno tenere conto di alcune premesse fondamentali: (a) tra Italia e Stati Uniti esistono profonde differenze di accessibilità e strutturazione dei servizi -pubblici e non- di salute mentale, (b) il background culturale americano –inteso come variabile ambientale- influenza in maniera unica la psicologia dei soggetti considerati (così come unica è l’influenza del background culturale italiano), (c) i soggetti considerati, pur facendo parte di minoranze etniche, sono nati e cresciuti sul suolo americano (afro americani, cinesi americani, latino/ispanici americani ecc).
Trattamento dei disturbi d’ansia per la psicoterapia con pazienti stranieri
Studi su soggetti afro americani con Disturbo di panico sono stati condotti da Carter et al. (2003) e da Friedman et al. (2006) I primi hanno selezionato un campione di 25 donne afro americane, istruite e appartenenti a una classe socio economica medio-alta, con sintomatologia tipo attacco di panico e agorafobia; il campione venne diviso casualmente in due gruppi: gruppo sperimentale CBT (11 sedute di gruppo) e gruppo di controllo lista di attesa.
Gli autori hanno riscontrato che le donne sottoposte a trattamento CBT, al termine delle 11 sedute mostravano una forte riduzione della sintomatologia ansiosa e depressiva, mentre i soggetti inseriti nel gruppo lista di attesa non presentavano miglioramenti. Al follow up il 54% delle donne appartenenti al gruppo CBT venne identificato come recovered e il 17% come migliorato. Tra i soggetti inseriti nel gruppo lista di attesa, il 95% non mostrò diminuzione dei sintomi. Al di là dei risultati, che, seppur promettenti, appaiono meno forti rispetto a quelli solitamente ottenuti con gruppo di pazienti euro-americani (Carter et al. 2012), l’aspetto forse più interessante dello studio proposto da Carter e colleghi, risiede, a nostro avviso, negli adattamenti al setting e al focus terapeutico operati dai ricercatori.
Come riportato dagli autori stessi, questo studio differisce dagli altri in quattro modi specifici:
- Il ricorso a un trattamento di gruppo per via del forte senso comunitario e di aggregazione presente all’interno della cultura afro americana;
- La creazione di gruppi etnicamente omogenei;
- Il ricorso esclusivo a terapeuti afro americani;
- L’inclusione, per tutto il corso della terapia, di temi legati alla razza e al rapporto tra questi e la malattia.
Durante il trattamento, gran parte del lavoro cognitivo fu orientato verso il belief secondo cui provare emozioni intense sia una manifestazione di debolezza personale. Inoltre, periodiche discussioni di gruppo venivano incentrate sul ruolo che l’appartenenza etnica può avere sull’esacerbazione dei sintomi e sull’aderenza al trattamento. Molto frequentemente le partecipanti discutevano dell’associazione tra lo stress causato dall’essere l’unica donna di colore sul posto di lavoro e il livello generale di ansia, o ancora come l’essere afro-americano possa influenzare la buona realizzazione di alcuni esercizi richiesti dalla terapia (per esempio esercizi di esposizione in vivo che prevedano il camminare in un negozio affollato o attraverso il quartiere). Secondo gli autori, questi adattamenti etnicamente specifici, nella psicoterapia con pazienti stranieri, risultarono efficaci nel ridurre i sintomi di panico.
Friedman et al. (2006) scelsero invece un campione misto (afro americani ed euro americani) con sintomi da attacco di panico (con o senza agorafobia). I soggetti furono sottoposti a un trattamento CBT di 16 sedute individuali. Tutti i soggetti mostrarono una simile e significativa riduzione della sintomatologia ansiosa, mentre si osservò una differenza significativa nell’ambito della sintomatologia depressiva, per cui i soggetti afro americani manifestarono ridotti miglioramenti rispetto ai soggetti euro americani.
Al contrario dello studio precedente, Friedman e colleghi non apportarono nessuna modifica culturalmente sensibile alla struttura del trattamento, mostrando quindi, apparentemente, la validità dell’approccio CBT anche quando a questo non si operano adattamenti etnici. È tuttavia da notare, come rilevato dagli autori stessi, che la maggior parte dei terapeuti coinvolti nello studio possedeva una buona formazione clinica con soggetti appartenenti a diverse etnie. Di conseguenza, sebbene non fosse stato esplicitamente proposto un lavoro incentrato sulle problematiche culturali, è probabile che tale aspetto fosse stato implicitamente considerato da parte dei terapeuti, esplicitamente esperti nella psicoterapia con pazienti stranieri appartenenti a minoranze. (Friedman et al. 2006).
Alfonso e Dziegielewki (2001) riportano l’efficacia positiva di un trattamento self-help CBT di nove settimane attraverso su un singolo soggetto latino con disturbo da attacco di panico. Sebbene la validità empirica dello studio sia quasi nulla, può qui essere utile per introdurre due forme di espressione dell’ansia caratteristiche delle popolazioni latine e/o ispaniche: Ataques De Nervios e Susto. Gli Ataques De Nervios (ADN) possono essere descritti come degli improvvisi episodi di ansia accompagnati da grida incontrollabili, attacchi di pianto, tremori, sensazione di calore nel petto che sale verso la testa e esperienze dissociative.
Questa specifica forma di espressione ansiosa sembra essere particolarmente diffusa tra gli individui di origine portoricana (Cintrón et al. 2005). Il Susto tradotto letteralmente è la paura o mal di paura e può essere descritto come la malattia che viene con la paura. Tradizionalmente la sua eziopatogenesi è legata a un’esperienza traumatica (da cui il nome) che conducono la persona a sviluppare disturbi del sonno, forte ansia, perdita di interessi. Sebbene sia considerata una sindrome culturalmente determinata, ovvero una condizione che ha un significato limitato al di fuori di contesti culturali specifici, è comunque ampiamente riconosciuta tra molti gruppi latini del Nord e Centro America, tanto da essere stata inserita all’interno dell’ultima edizione del Manuale Diagnostico dei Disturbi Mentali (DSM 5) (APA, 2013).
La differente modalità espressiva dell’ansia all’interno delle popolazioni latino/ispaniche, inoltre, inficia sull’attendibilità di alcuni degli strumenti statistici maggiormente diffusi per la valutazione della sintomatologia ansiosa (Carter et al. 2012). Hirai, Stanley e Novy (2006), per esempio, hanno valutato le proprietà psicometriche di Beck Anxiety Inventory (BAI), Penn State Worry Questionnaire (PSWQ), Anxiety Sensitivity Index, Worry Scale, Body Sensations Questionnaire, Trait Anxiety Scale su un campione composto di soggetti latini/ispanici (Messicani, portoricani, cubani ecc) con diagnosi di disturbo d’ansia generalizzato (GAD).
Gli autori hanno notato che all’interno delle popolazioni ispaniche/latine, il test più attendibile appariva essere il BAI, probabilmente a causa della forte componente fisiologica con cui questi soggetti tendono a esprimere la propria preoccupazione. Al contrario, test come il PSWQ risultavano poco utili, in quanto, esplorando le componenti più cognitive del disturbo, non fornivano una completa immagine della sintomatologia ansiosa del campione considerato. Nonostante questo e altri studi mostrino la presenza di profonde differenze tra individui euro americani e latino/ispanici nell’espressione delle componenti ansiose dello stato psicopatologico, sono ancora molto scarsi gli studi focalizzati sull’esito dei trattamenti orientati secondo una prospettiva CBT.
Nel contesto del Disturbo da stress post traumatico (PTSD), i più grandi contributi vengono sicuramente dagli studi condotti su immigrati e rifugiati politici. La maggior parte di questi studi è stata condotta su individui di origine asiatica.
Otto, Hinton e altri autori hanno focalizzato il loro lavoro sulla costruzione di un trattamento CBT culturalmente modellato e specificatamente rivolto a soggetti cambogiani e vietnamiti con Disturbo da stress post traumatico (Carter et al. 2012). Nei loro scritti tra i vari suggerimenti compaiono indicazioni relative a modifiche di setting, ad esempio spostando la terapia all’interno di un tempio buddista, e di gestione della sintomatologia ansiosa focalizzandosi principalmente sulle manifestazioni somatiche e sulle credenze culturali relative alla sua origine.
Per esempio, molti individui cambogiani con PTSD non solo mostrano un’alta comorbilità con Disturbo di panico, ma questo tende a manifestarsi in attraverso forti preoccupazioni per eventuali manifestazioni somatiche di dolore al collo, portando a quello che Hinton e colleghi (2005) definiscono neck-focused panic attack. Nel neck-focused panic attack, il primo sintomo a manifestarsi è una forte tensione ai muscoli del collo, spesso provocato da uno stato d’ansia. Tradizionalmente, secondo la cultura buddista, il collo è il luogo in cui risiede il chi (vento, soffio vitale).
Uno stato di dolore o tensione al collo è quindi vissuto con grande preoccupazione da questi individui, preoccupazione che può condurre a sua volta alla manifestazione di altri sintomi somatici, quali palpitazioni, vista annebbiata e vertigini (Hinton et al. 2005). Gli autori, utilizzando tali adattamenti all’interno di un trattamento CA CBT della durata di 12 sedute, in associazione a una terapia farmacologica e a un programma di incontri con un socialworker, osservarono un miglioramento della sintomatologia ansiosa e di quella correlata al PTSD dopo appena tre settimane (Hinton et al. 2005; Carter et al. 2012).
Sempre Hinton e colleghi (2012) hanno poi applicato un trattamento CA CBT a un campione di donne latine con diagnosi di PTSD e utilizzato tecniche improntate sulla mindfulness e sull’accettazione nel trattamento del PTSD in soggetti latini, cambogiani e vietnamiti (Hinton et al. 2004; Hinton et al. 2013) con buoni risultati.
Sempre all’interno del trattamento dei disturbi d’ansia vale la pena citare lo studio condotto da Zhang et al. (2002). A differenza delle ricerche precedenti, i soggetti qui considerati erano tutti nati e cresciuti nelle zone urbane della Cina. Zhang e colleghi hanno assegnato casualmente i soggetti selezionati con diagnosi di Disturbo d’Ansia Generalizzato (GAD) a tre gruppi sperimentali. I soggetti appartenenti al primo gruppo ricevevano unicamente una terapia farmacologica (benzodiazepine); ai soggetti del secondo gruppo veniva proposta una terapia CBT adattata in chiave taostia (Chinese Taoist Cognitive Psychotherapy, CTCP), il terzo gruppo prevedeva una combinazione dei due trattamenti.
I risultati mostrarono che sebbene tutti e tre i gruppi, durante il periodo di trattamento subirono un miglioramento della sintomatologia ansiosa, il gruppo che ottenne i migliori risultati, sia in termini di rapidità sia in termini di durata, fu il terzo. Infatti, mentre il primo gruppo migliorò molto rapidamente (ma altrettanto rapidamente tornò a manifestare la sintomatologia presente prima del trattamento), il secondo gruppo ottenne risultati più permanenti, ma con più gradualità temporale.
Trattamento dei disturbi dell’umore nella psicoterapia con pazienti stranieri
La letteratura inerente applicazione di un trattamento CBT specificatamente rivolto alle minoranze etniche con disturbi dell’umore risulta ad oggi molto scarsa. I pochi studi disponibili riguardano prevalentemente le minoranze ispaniche e latine.
Prima di avanzare nell’esposizione della review è necessario chiarire che sebbene tra latini e ispanici intercorrano delle differenze di significato culturale e identitario (Hayes-Bautista et al.. 2002) di seguito saranno utilizzati allo stesso modo per descrivere tutte le persone provenienti dal Centro e Sud America. Secondo Miranda (1976) tra le principali aspettative che i latini mostrano nei confronti di un trattamento psicologico si trovano: sollievo sintomatologico immediato, indicazioni e consigli e approccio incentrato sul problema. La CBT sembrerebbe rispondere bene a tali attese. Inoltre, secondo Organista e Muñoz (1997) l’utilizzo di strumenti quali manuali, homework e diari aiuterebbe i pazienti ispanici ad alleviare le problematiche legate allo stigma.
Secondo Interian et al. (2008), gran parte degli studi condotti su pazienti latini affetti da depressione, conferma l’efficacia di terapie orientate secondo un approccio cognitivo comportamentale. Tra queste riportiamo Comas-Diaz (1981), Rosselló e Bernal (1999), Interian et al. (2008) e Heilmann et al.. (2011).
Comas-Diaz (1981) selezionò un gruppo di 26 donne portoricane, successivamente assegnate casualmente a uno dei seguenti gruppi: gruppo terapia cognitiva, gruppo terapia comportamentale, gruppo lista d’attesa. I risultati mostrarono un forte miglioramento sia dei soggetti appartenenti al gruppo cognitivo (64%) sia a quelli del gruppo comportamentale (51%). A differenza degli studi in precedenza esposti, nessuna modificazione o adattamento culturale fu adottato durante il trattamento, sebbene, come evidenziato anche da Comas-Diaz, la scelta di condurre le terapie all’interno di un gruppo possa aver influenzato il positivo outcome terapeutico.
È infatti probabile che le pazienti si sentissero accolte all’interno del gruppo terapeutico rivedendo in questo una sorta di famiglia estesa. È inoltre d notare che tutte le donne selezionate erano madri single con un livello di istruzione medio di circa 6 anni.
Rosselló e Bernal (1999) focalizzano invece la loro attenzione su un gruppo di soggetti adolescenti nati e cresciuti in Porto Rico. Gli autori assegnarono casualmente ognuno dei 71 adolescenti con diagnosi di Disturbo Depressivo Maggiore (DSM III TR) (APA, 1987) a tre condizioni: trattamento CBT, trattamento ITP (Terapia Interpersonale) e lista di attesa. Ancora una volta i soggetti sottoposti a trattamento mostrarono maggiori miglioramenti rispetto a quelli inseriti nella lista d’attesa. Confrontando i due gruppi trattati, i migliori risultati, in termini di risoluzione della sintomatologia, vennero osservati nel gruppo ITP, dove l’82% dei soggetti risultava guarito dopo il trattamento, contro il 59% degli adolescenti sottoposti a CBT. Ancora, seppure gli autori non riferiscono di aver operato un qualsiasi adattamento culturale, è possibile ipotizzare che la concordanza etnica tra pazienti e terapeuti possa aver influenzato i risultati raggiunti.
Interian et al. (2008) selezionarono un campione di 29 individui ispanici con depressione maggiore di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Vennero esclusi dallo studio i soggetti già in fase di trattamento psicoterapeutico, con diagnosi di disturbo bipolare, che facevano uso di sostanze o che mostravano rischio suicidario. I partecipanti presero parte ad un ciclo di 12 sedute individuali di culturally adapted CBT. Tutte le sedute vennero condotte in spagnolo; al fine di comprendere il ruolo dei fattori culturali, parte della terapia fu dedicata a esplorare da quanti anni i partecipanti risiedevano negli Stati Uniti e come si erano adattati al loro arrivo, quale era l’attuale situazione famigliare, e se e come si erano sentiti supportati dalla comunità. Buona parte dei partecipanti affermò di vedere la terapia come una distrazione e che proprio grazie a questo che trovavano sollievo.
Forte rilevanza venne anche data ai values culturali che secondo i pazienti rendevano più difficoltoso il processo di cambiamento (familismo ecc). I risultati mostrano una riduzione significativa del 57% dei punteggi ottenuti alla Beck Depression Inventory al termine del trattamento e del 54% al follow up di 6 mesi. I sintomi ansiosi (Beck Anxiety Inventory) e quelli somatici (Patient Health Questionnarie-15) apparvero ridotti rispettivamente del 67% e del 42% al termine del trattamento e del 64% e 37% al follow up. Tutte le differenze risultarono statisticamente significative.
Tra gli studi da segnalare si riporta quello condotto da Heilmann e colleghi (2011) su un campione di donne latino-americane di seconda generazione. Gli autori, programmando un intervento comprendente strumenti quali Schema Therapy, Interviste Motivazionali (Motivational Interviewing) e collaborative-mapping della durata di otto sedute di due ore ciascuna, osservarono un significativo miglioramento sia della sintomatologia depressiva, che delle capacità di resilienza. I miglioramenti ottenuti furono mantenuti al follow-up di un anno.
Psicoterapia con pazienti stranieri: conclusioni
La globalizzazione e la possibilità di spostarsi sempre più facilmente (ma non sempre senza grandi o piccole sofferenze), porta sempre più persone a muoversi verso nuove mete geografiche. Nel caso dell’Italia, questo ha determinato una crescita esponenziale delle minoranze, di persone con credenze, valori, significati e prospettive diverse dalle nostre. Pensare che ciascuna di queste persone sia portatrice di sofferenza, ci condurrebbe ad abbracciare l’ennesimo superficiale pregiudizio. Tuttavia, il dolore è universale e ciò ci impone la responsabilità, sia come professionisti della salute che come esseri umani, di sviluppare competenze, esperienze, tecniche e metodi che possano migliorare la loro qualità di vita.
Al termine di questa review è nostro avviso che la CBT possegga le qualità adeguate per essere utilizzata anche con individui appartenenti a minoranze, quando opportunamente modificata e adattata alle specifiche caratteristiche dell’utenza considerata.
Secondo Mazzetti (2003) nella psicoterapia con pazienti stranieri il professionista della salute può incorrere in due atteggiamenti speculari, ossia di sopravvalutazione e sottovalutazione delle differenze culturali. Il modello della mente alla base della CBT assumendo che le strutture della mente umana sono universali, così come i suoi meccanismi di funzionamento, permetterebbe al clinico di ridurre il rischio di incentrare il trattamento esclusivamente sugli aspetti culturali (sopravvalutazione delle differenze culturali). (Mazzetti, 2003).
Nel contempo, l’assunto per cui il contenuto dei beliefs sia unico e individuale consentirebbe di contenere l’atteggiamento di sottovalutazione delle differenze culturali. Gli essere umani non sono tutti uguali ciascuno di noi vive all’interno di un sistema di riferimento culturale proprio e singolare; è proprio questo a generare infinite credenze di malattia, cura e trattamento.
È chiaro che tutti i contributi qui riportati rappresentano solo delle linee guida e che, d’altro canto, la cultura entra in gioco anche quando paziente e terapeuta appartengono alla stessa etnia e nazione, in quanto si può non condividere parte dell’identità culturale, come età, credenze religiose, ideologia politica. Ernesto De Martino, etnoantropologo italiano, nel 1962 propone di affrontare l’alterità in un’ottica di etnocentrismo critico ovvero un incontro alla frontiera, dove il mettere in discussione le proprie modalità di interpretazione del mondo diventa funzionale alla conoscenza di sé e dell’altro (Cremonese, 2014); a nostro parere l’adattamento culturale della CBT dovrebbe avvenire tenendo sempre presente questo pensiero .
Risulta quindi evidente la necessità di creare un buon corpus di ricerca clinica specificatamente incentrato sulla realtà italiana.