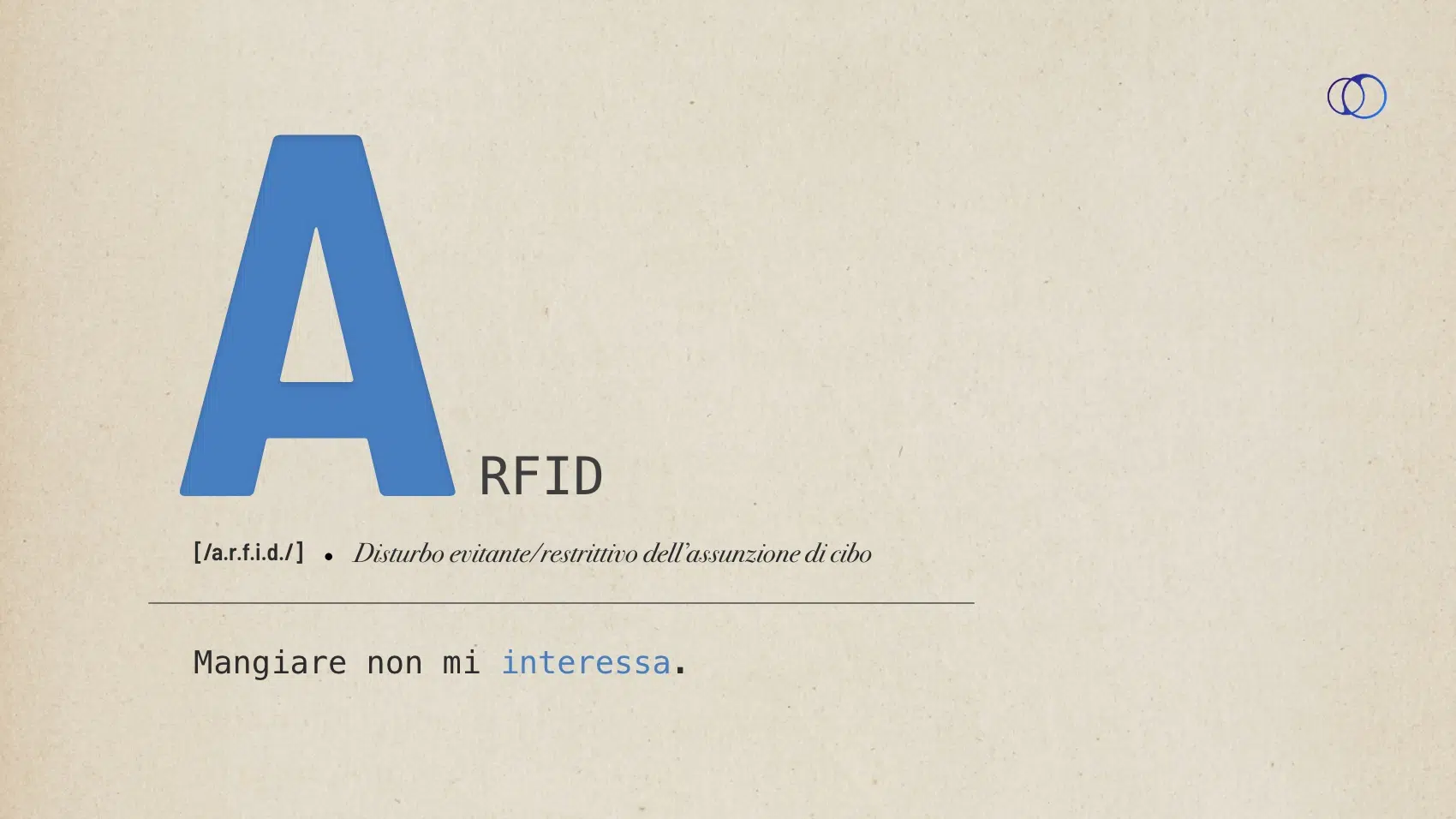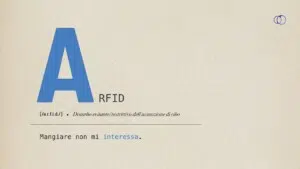Da cosa può dipendere il disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo?
Il gruppo di ricerca di Jennifer J. Thomas ipotizza che il disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo (ARFID) dipenda dalle anomalie nell’appetito omeostatico, nella sensibilità sensoriale e nella reattività alla paura, caratteristiche alla base delle tre presentazioni primarie del disturbo ARFID, rispettivamente: mancanza di interesse per il cibo, sensibilità sensoriale e paura delle conseguenze avverse.
La diagnosi di ARFID
Il Disturbo Evitante/Restrittivo dell’assunzione di cibo (ARFID) è caratterizzato dall’evitamento o restrizione nell’assunzione di cibo e nell’assorbimento di un adeguato apporto calorico, e da un mancato interesse nell’alimentazione. Di seguito vengono riportati i criteri diagnostici (American Psychiatric Association, 2013):
- Un’anomalia dell’alimentazione e della nutrizione (ad es. assenza di interesse per l’alimentazione o per il cibo; evitamento basato sulle caratteristiche sensoriali del cibo che si manifesta attraverso una persistente incapacità di assumere un adeguato apporto nutrizionale e/o energetico associata con una o più delle seguenti:
- Significativa perdita di peso o nei bambini incapacità a raggiungere il peso relativo alla crescita
- Significativa carenza nutrizionale
- Dipendenza dalla nutrizione enterale o da supplementi nutrizionali orali
- Marcata interferenza col funzionamento psicosociale
- Il disturbo non è connesso con la mancanza di cibo o associato a pratiche culturali.
- Il disturbo non si manifesta esclusivamente nel corso di anoressia o bulimia nervosa e non vi è evidenza di anomalia nel modo in cui è percepito il peso e la forma del proprio corpo.
- L’anomalia non è meglio attribuibile a una condizione medica o ad un altro disturbo mentale. Se il disturbo alimentare si manifesta nel corso di un altro disturbo, la sua importanza supera quella del disturbo di base e richiede attenzione clinica.
La prevalenza dell’ARFID è stata valutata solo in studi retrospettivi e i risultati preliminari indicano che i pazienti con questo disturbo tendono ad essere più giovani rispetto a quelli con anoressia nervosa e bulimia nervosa e che, rispetto a questi ultimi, il disturbo sembra colpire un maggior numero di maschi. Inoltre, l’ARFID presenta una frequente comorbilità con i disturbi d’ansia e, in alcuni casi, con il disturbo da deficit di attenzione/iperattività e i disturbi dello spettro autistico.
All’interno di questo articolo vorrei approfondire il tema relativo alle cause, e quindi indagare quali sono i fattori scatenanti di questo disturbo.
Un modo semplice per provare a rispondere alla domanda “perché qualcuno sviluppa l’ARFID?” è illustrato dal modello “biopsicosociale”, un approccio alla comprensione della salute e della malattia proposto da George Engel nel 1977. Essenzialmente, questo approccio propone che la salute mentale e la malattia derivino dalla complessa interazione tra fattori biologici, psicologici e sociali.
Ma in che modo questi fattori interagiscono tra di loro, quando si parla dell’ARFID? In primo luogo esiste quella che viene chiamata “vulnerabilità individuale”, il che significa che ognuno di noi è più o meno predisposto e vulnerabile allo sviluppo di determinati disturbi. In parte questo è determinato dalla nostra storia famigliare e dal nostro temperamento (e quindi dal nostro patrimonio genetico), in parte è determinato dalle nostre scelte, azioni e scelte di stile di vita. Esiste poi il “contesto personale”, che comprende l’insieme delle persone e degli ambienti in cui viviamo (la nostra famiglia, le interazioni con gli amici, sul lavoro, la comunità religiosa e culturale in cui cresciamo); anche quest’ultimo è unico per ogni individuo e interagisce con i fattori di vulnerabilità personale, portando alla maggiore o minore probabilità di sviluppare dei disturbi mentali. Infine, ad interagire con le caratteristiche individuali e il contesto di vita, esistono gli eventi “trigger”: si tratta di eventi, interni a noi o esterni a noi, che contribuiscono allo sviluppo o meno di determinate problematiche.
L’ARFID può esprimersi con motivazioni differenti e questo ha permesso di identificare tre diversi sottotipi: (i) il cibo viene evitato per un’apparente mancanza d’interesse per il mangiare o il cibo, si tratta di un disturbo emotivo di evitamento del cibo; (ii) l’evitamento del cibo è sensoriale, cioè legato alle sue proprietà sensoriali: l’aspetto, il colore, l’odore, la consistenza, il gusto, la temperatura; (iii) l’evitamento del cibo è dovuto alla paura che mangiare possa avere conseguenze negative, come il non riuscire a deglutire e soffocarsi, il vomitare, dolori addominali e diarrea, reazioni allergiche.
Quali fattori possono essere legati allo sviluppo e al mantenimento dell’ARFID?
Scarso interesse per il cibo o il mangiare
L’interesse per il cibo e il mangiare costituisce una problematica complessa e include una serie di componenti. Per i nostri scopi, può essere utile considerare alcuni motivi che portano a questo scarso desiderio, per esempio quelli legati al cattivo riconoscimento della fame, al non “desiderare” il cibo e quelli legati, per esempio, a quando il mangiare richiede un eccessivo sforzo.
Regolazione alterata dell’appetito
Esistono ovviamente delle differenze individuali nell’appetito fin dalla nascita, con alcuni bambini descritti come molto affamati e altri che segnalano di aver fame meno spesso. Nel normale sviluppo alimentare, il bambino adatta il suo apporto alimentare in base alle sue esigenze energetiche, contando sull’intervento di un caregiver in grado di rispondere ai suoi segnali di richiesta. Tuttavia, vi sono alcuni fattori che possono interrompere questo processo di normale regolazione dell’appetito, come ad esempio una prolungata nutrizione tramite sondino a causa di una problematica medica.
Ridotto desiderio di mangiare
Ognuno di noi ha familiarità con un certo grado di variazione nel proprio desiderio di mangiare determinati cibi o, più in generale, di mangiare. Ci sono momenti in cui percepiamo il bisogno di mangiare o non mangiare un determinato cibo, momenti in cui abbiamo più o meno appetito. Queste oscillazioni sono però temporanee; al contrario, nelle persone con ARFID il desiderio ridotto di mangiare può essere presente per più tempo e in misura estrema, e questo aspetto può derivare da tre fattori: l’umore, l’arousal e l’ipoalimentazione abituale.
- Umore: imparare a gestire l’esperienza emotiva fa parte del normale sviluppo, ma per alcuni bambini questa abilità risulta più difficile, sulla base della loro vulnerabilità personale e delle caratteristiche ereditarie. Considerando dunque che una certa esperienza emotiva o un determinato umore possono ridurre il desiderio di mangiare, bisogna dunque leggere questi aspetti come possibili fattori che contribuiscono all’evitamento o alla restrizione dei cibi.
- L’arousal: per arousal si intende lo stato di attivazione psicofisiologica di un organismo. L’eccessiva attivazione compromette alcune delle nostre capacità di elaborare le cose come siamo soliti fare e riduce le nostre capacità di funzionare bene, anche nei comportamenti di base come dormire, mangiare, pensare. Le alterazioni nei livelli di arousal sono molto comuni nei bambini con ARFID (dalle ricerche emerge una correlazione tra ARFID e disturbi del neurosviluppo come l’autismo e l’ADHD).
- Ipoalimentazione abituale: l’ipoalimentazione occasionale solitamente genera l’effetto opposto, ovvero un maggior desiderio di mangiare, questo perché il nostro corpo ci manda segnali che ci ricordano l’importanza di nutrirci. Tuttavia, questo non succede nel caso di una ipoalimentazione abituale. Ci sono diversi motivi per cui questo potrebbe capitare: quando non si mangia abbastanza, si diventa stanchi e irritabili, e questo potrebbe influenzare l’umore e limitare il senso di fame. Un altro effetto comune dell’ipoalimentazione è la tendenza a diventare costipati, e questo può creare disagio con gonfiore addominale e sensazione di pienezza, i quali possono demotivare le persone a mangiare. Nel caso di una ipoalimentazione abituale, il corpo sembra rallentare e farsi bastare il poco che riceve, inviando solo deboli segnali per richiedere nutrimento (se lo stomaco riceve costantemente piccole quantità di cibo, ne richiederà sempre meno, sentendosi subito sazio anche dopo esigue quantità di cibo).
Difficoltà oro-motorie o di deglutizione
È importante prendere in considerazione il fatto che mangiare possa rappresentare un’attività faticosa per alcune persone; alcuni bambini con ARFID fanno più fatica con alcune consistenze, con il mordere o il masticare, e questo può scoraggiarli in generale dal mangiare. Queste difficoltà possono essere correlate a problemi strutturali o alla mancanza di pratica e l’esito sarà la riduzione dell’interesse a mangiare in generale.
Condizioni mediche o malattie
È risaputo che sentirsi male si associa spesso alla riduzione dell’interesse per il mangiare; alcune condizioni mediche sono associate alla necessità di attuare specifiche raccomandazioni sull’alimentazione o di limitare alcuni alimenti nella dieta (ad esempio nel caso di diabete insulino-dipendente o celiachia). In questi casi, l’evitamento e la restrizione sono prescrizioni mediche, non si tratta quindi di ARFID. Ci sono però bambini che presentano in anamnesi disturbi medici complessi che possono portare a mangiare meno; questo può accentuare lo scarso interesse per il cibo, che deriva da associazioni negative che il bambino fa con il cibo e il mangiare.
Assunzione di determinati farmaci
L’ultimo motivo per cui ci sono persone che potrebbero avere uno scarso interesse per il mangiare è il fatto di assumere determinati farmaci; alcune medicine infatti comportano una riduzione (o in alcuni casi un aumento) dell’appetito, come effetto collaterale. I farmaci noti per ridurre l’appetito come effetto collaterale includono alcuni di quelli usati per il trattamento di altri disturbi, tra cui anche l’ADHD.
Evitamento basato su aspetti sensoriali del cibo o del mangiare
In che modo esattamente la sensibilità sensoriale causa problemi al comportamento alimentare? Alcuni di noi hanno una sensorialità più acuta in una o più delle vie legate ai 5 sensi; le nostre risposte agli stimoli che riceviamo ed elaboriamo usando i nostri sensi si collocano su un continuum che va da molto piacevole a molto spiacevole. Un’emozione che è spesso associata a questo lato spiacevole è il disgusto, emozione che ha origine dal bisogno dell’uomo di tenersi lontano da cose che potrebbero essere pericolose.
Nell’ARFID spesso il disgusto svolge un ruolo significativo: i bambini si lamentano se diamo loro qualcosa di diverso rispetto ai loro cibi preferiti, che suscita in loro l’emozione di disgusto per caratteristiche legate all’odore, al sapore, alla consistenza, all’aspetto. Alcuni bambini possono eventualmente provare ad assaggiarlo, avendo poi reazioni spiacevoli come nausea, conati di vomito, piangere o arrabbiarsi, e possono decidere di non ingerire più quel cibo (risposta dell’evitamento). Il problema in questo caso è dunque che la sensibilità acuta di queste persone alle differenze nel gusto, vista, odore, consistenza, temperatura o suono del cibo innesca in automatico la risposta del disgusto e il conseguente evitamento e rifiuto.
Evitamento legato alla preoccupazione per possibili conseguenze negative del mangiare
In precedenza abbiamo parlato dell’emozione di disgusto, all’interno di questo paragrafo trattiamo di un’altra emozione, quella della paura in relazione ad un’esperienza avversa precedente.
Come il disgusto, la paura è un’emozione primaria e da una prospettiva evoluzionistica risulta vitale per la sopravvivenza. Quando sperimentiamo paura, il nostro corpo diventa più vigile e pronto all’azione; gli ormoni che vengono rilasciati nel corpo quando sperimentiamo questa emozione lo preparano ad una reazione nota come “attacco o fuga” (“rimarrò fermo e combatterò, affronterò il pericolo, oppure fuggirò per mettermi in salvo”). In relazione alla nostra discussione, questo si traduce in: “mi opporrò di provare qualcosa di diverso nonostante i ripetuti tentativi o farò in modo di evitare qualsiasi situazione/alimento che non mi fa sentire al sicuro”.
Esploriamo dunque più a fondo le cause più comuni dell’evitamento o della restrizione basate sulla paura nei bambini.
Perché succede?
Possono esserci una serie di motivazioni, alcune relative a episodi riferibili a esperienze dirette del bambino, altre relative a cose che può aver appreso o visto dagli altri, cioè tramite un’esperienza indiretta. Se qualcuno di noi ha avuto una brutta o spiacevole esperienza che è stata associata al provare paura, cercherà generalmente di evitarla in futuro. Quindi, esperienze avverse precoci legate al cibo o al mangiare, in alcuni bambini, continueranno a contribuire alla paura legata al cibo, anche dopo diversi anni, mantenendo un comportamento di evitamento. Per esempio, alcuni bambini con allergie significative possono rifiutare una gamma di alimenti molto più ampia di quella che devono escludere dalla loro dieta per ragioni mediche, per la paura di poter stare comunque male. O ancora, il verificarsi di episodi come soffocamento, la sensazione di non riuscire a respirare o a deglutire o un attacco di gastroenterite, che hanno suscitato paura e preoccupazione, possono aver contribuito al mantenimento di questa emozione e a conseguenti comportamenti di evitamento.
Considerazioni conclusive
In questa discussione abbiamo quindi considerato una vasta gamma di fattori che possono contribuire allo sviluppo dell’ARFID, esplorando gli aspetti che possono influenzare il nostro interesse per il cibo e il mangiare rendendo l’esperienza del mangiare piacevole o spiacevole e discutendo il ruolo delle emozioni di disgusto e paura nel mantenere l’evitamento e la restrizione.
Per rispondere dunque alla domanda “Cosa causa l’ARFID?”, sembra ragionevole pensare che esistono più fattori contribuenti, che tendono a variare tra gli individui.
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association.
- Bryant-Waugh, R. (2021). Arfid: disturbo evitante restrittivo dell’assunzione di cibo. una guida per genitori e famigliari. Positive Press.
- Bryant-Waugh, R. (2013). Avoidant restrictive food intake disorder: An illustrative case example. International Journal of Eating Disorders, 46, 420-423.
- Golding, J., Steer, C., Emmett, P., Bartoshuk, L. M., Horwood, J., & Smith, G. D. (2009). Associations between the ability to detect a bitter taste, dietary behavior, and growth. Annals of the New York Academy of Sciences, 1170(1), 553–7.
- Holsen, L.M. , Lawson, E.A, Blum, J., Ko, E., Makris, N., Fazeli, P.K., Klibanski, A., & Goldstein, J.M. (2012). Food motivation circuitry hypoactivation related to hedonic and nonhedonic aspects of hunger and satiety in women with active anorexia nervosa and weight-restored women with anorexia nervosa. Journal of psychiatry & neuroscience, 37(5), 322.
- Kauer, J., Pelcha, M.L., Rozin, P., & Zickgraf, H.F. (2015). Adult picky eating. Phenomenology, taste sensitivity, and psychological correlates. Appetite, 90, 219–28.
- Kreipe, R. E., & Palomaki, A. (2012). Beyond picky eating: Avoidant/restrictive food intake disorder. Current Psychiatry Reports, 14, 421–431.
- Lang, P.J., & McTeague, L.M. (2009). The anxiety disorder spectrum: Fear imagery, physiological reactivity, and differential diagnosis. Anxiety, Stress, & Coping, 22(1), 5–25.
- Mancioppi, S. (2019). Il disturbo selettivo dell’alimentazione. State of Mind.
- Thomas, J. J., Lawson, E. A., Micali, N., Misra, M., Deckersbach, T., & Eddy, K. T. (2017). Avoidant/restrictive food intake disorder: a three-dimensional model of neurobiology with implications for etiology and treatment. Current psychiatry reports, 19, 1-9.