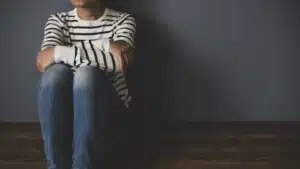Il disturbo dello spettro autistico (ASD) è un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo che sono caratterizzati da un esordio precoce nei primi anni dello sviluppo.
Il disturbo dello spettro autistico (ASD Autism Spectrum Disorder), rientra nella sezione del DSM-5 (APA, 2014) dei disturbi del neurosviluppo ed è codificato con il numero 299.00, che corrisponde al codice F84.0 del manuale ICD-10 (WHO, 2007). Nel DSM IV-TR e nelle versioni precedenti era invece classificato come disturbo pervasivo dello sviluppo (APA, 2001). Il disturbo dello spettro autistico (ASD) è un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo che sono caratterizzati da un esordio precoce nei primi anni dello sviluppo e per essere diagnosticati devono essere presenti entro i tre anni.
Sono caratterizzati da tre aree sintomatologiche che, prima dell’avvento del DSM-5, ricoprivano la triade. (i) In primo luogo, è presente una compromissione qualitativa dell’interazione sociale. (ii) In secondo luogo, abbiamo la compromissione qualitativa della comunicazione ovvero i bambini avranno difficoltà a capire quello che l’altro dice e a far capire all’altro quello che pensano e come si sentono. (iii) Infine, si caratterizzano per modalità di comportamento, interessi e attività ristretti, ripetitivi e stereotipati caratterizzati dalla sameness, ovvero per loro tutto deve sempre essere identico a se stesso e nulla può essere cambiato perché il cambiamento e l’uscire dalle stereotipie e le routine genera frustrazione e intolleranza. Con l’avvento del DSM-5 le aree divengono due dove il deficit comunicativo e quello di reciprocità sociale vengono uniti nel “deficit di comunicazione sociale” e viene confermato il gruppo dei comportamenti ripetitivi (APA, 2014). Le persone con ASD possono avere un quoziente intellettivo (QI) minore di 70, oppure essere ad alto funzionamento (HFA) e dunque con un quoziente intellettivo oltre il 70, un linguaggio verbale adeguato e un soddisfacente funzionamento adattivo generale, caratterizzato però da abilità bizzarre, innate, con limitato utilizzo pratico (Vicari & Caselli, 2017).
I termini adolescenza e pubertà sono spesso utilizzati in riferimento al periodo di transizione dall’infanzia all’età adulta (Gabriels & Bourgondien, 2007); questa transizione include la maturazione sessuale delle caratteristiche fisiche come ad esempio la crescita scheletrica, lo sviluppo degli organi riproduttivi e le caratteristiche sessuali secondarie (Gabriels & Bourgondien, 2007). La sessualità comprende molto di più del comportamento sessuale, infatti essa include anche: l’immagine di sé, le emozioni, i valori, le abitudini, le credenze, i comportamenti e le relazioni (Koller, 2000).
Questo periodo, dunque, si associa altamente alle competenze sociali, che nei soggetti con disturbi dello spettro autistico risultano compromesse (Chan & John, 2012). Spesso le persone con autismo si ritrovano ad affrontare barriere legate all’espressione stessa della propria sessualità (Koller, 2000). Inoltre, la letteratura sulla sessualità degli individui con il disturbo dello spettro autistico, suggerisce che gli ostacoli riscontrati includono: miti sociali, conoscenza insufficiente, sconforto personale e limitato accesso a risorse educative disponibili e appropriate (Koller, 2000).
Negli adolescenti con sviluppo tipico, i cambiamenti cognitivi coinvolgono un aumento nelle capacità per il pensiero astratto, riflessione e comprensione sociale su cosa le altre persone possano pensare o provare. Allo stesso tempo, è possibile intravedere che i cambiamenti psicologici e sociali si riflettono nel maggior coinvolgimento degli adolescenti stessi nello sviluppo di amicizie e incontri sentimentali e questi li aiutano a dare un senso alle proprie transizioni fisiche, ai propri bisogni e desideri (Gabriels & Bourgondien, 2007). D’altro canto, gli individui con disturbo dello spettro autistico sperimentano tutti gli aspetti di maturazione fisica e sessuale sopra menzionati, all’incirca nello stesso periodo della popolazione generale, tenendo in considerazione però che la natura delle compromissioni core dell’autismo possono impedire il progredire dello sviluppo cognitivo e psicosociale che coincide tipicamente con la maturazione fisica (Gabriels & Bourgondien, 2007). Le comuni caratteristiche dell’autismo come, per esempio, il fallimento nello sviluppo del linguaggio o altre forme di comunicazione sociale, permangono in adolescenza e la problematica si riscontra nella difficoltà ad acquisire e comprendere le regole alla base dell’interazione sociale e nello sviluppo dell’empatia (Koller, 2000). La presenza di anomalie comunicative per lo sviluppo sessuale nelle persone con autismo include l’abilità di etichettare o parlare di termini sessuali pur avendo poca o nessuna comprensione del loro significato, avendo la tendenza a ripetere semplicemente i termini sessuali precedentemente sentiti, indipendentemente dal contesto sociale (Gabriels & Bourgondien, 2007). I deficit a livello sociale nelle persone con autismo possono interferire non solamente nell’area delle abilità individuali nello sviluppo di relazioni di amicizia e sentimentali, ma anche nell’abilità individuale di utilizzare il giudizio sociale per determinare cosa dovrebbe essere svolto in un setting pubblico e cosa privatamente, come e perché gestire la propria igiene personale e come evitare lo sfruttamento sessuale da parte degli altri (Gabriels & Bourgondien, 2007). Di conseguenza a quanto appena riportato, gli adolescenti con autismo sono esposti ad un maggior rischio di problemi legali derivanti da comportamenti inappropriati.
I genitori di adolescenti con disturbi dello spettro autistico sono preoccupati che i loro figli possano comportarsi inadeguatamente con gli altri e questo potrebbe condurre a problemi legali, incluso essere etichettati come giovani “sex offenders” (Chan & John, 2012).
In aggiunta ai deficit sociali e comunicativi è inoltre da tenere in considerazione il deficit del comportamento, dal momento che gli individui con autismo tendono ad avere un repertorio comportamentale limitato. Il loro coinvolgimento in attività auto-stimolative, come la masturbazione, può divenire una delle poche attività che una persona con autismo è in grado di svolgere, di conseguenza questo può impattare sul tempo speso per altre attività. Tuttavia, il tempo speso per la masturbazione può essere ridotto insegnando al ragazzo altre attività d’interesse (Gabriels & Bourgondien, 2007).
Un’altra problematica riscontrata è che bambini e adolescenti con una diagnosi di disturbo dello spettro autistico sono esposti ad un rischio maggiore per l’abuso emotivo, fisico e sessuale. A seconda del livello di severità dell’autismo, queste persone potrebbero avere bisogno di assistenza nelle attività quotidiane, che può includere il fatto che i loro corpi vengano toccati da adulti per soddisfare i loro bisogni personali. Tuttavia, spesso questi ragazzi non vengono educati sulla prevenzione degli abusi sessuali, ed è proprio questo a porli in una condizione di maggior rischio (Chan & John, 2012). A fronte di tutte queste problematiche, negli adolescenti con autismo è fondamentale sviluppare e allenare le competenze sociali; è necessario valutare le risorse della comunità per indirizzare i genitori verso uno specialista comportamentale o psicologo in grado di utilizzare metodi di insegnamento speciali al fine di aiutare i ragazzi con autismo ad apprendere comportamenti appropriati (Chan & John, 2012).
Per i giovani con disturbo dello spettro autistico con un QI <70, al di sotto della media, le aspettative romantiche e sessuali dei genitori erano correlate alla gravità del disturbo e all’educazione sessuale e relazionale da parte dei genitori. Sia la gravità dell’ASD che l’educazione relazionale e sessuale giocano un ruolo primario nel fatto che i genitori comunichino sulla sessualità con i giovani con ASD e sugli argomenti che scelgono di trattare. A causa dei sintomi del loro bambino, i genitori di giovani con ASD hanno aspettative incerte o basse sul fatto che il loro bambino si innamorerà, si sposerà o avrà un rapporto sessuale e questo influisce a sua volta, sulla misura in cui i genitori forniscono ai loro figli un’educazione sessuale e relazionale completa (Ballan, 2012).
Ricerche recenti suggeriscono che gli individui con ASD potrebbero non ricevere un’educazione sessuale e relazionale efficace dai loro genitori o da altre fonti credibili (Mehazabin & Stokes, 2011). Ad oggi, ci sono pochi studi empirici che esaminano i fattori legati alla comunicazione sessuale genitore-figlio nell’ASD. Quello che però risulta chiaro è che i caregiver svolgono un ruolo fondamentale nell’educare i giovani con autismo sul sesso e le relazioni (Teti, et al., 2018) e allo stesso tempo famiglie delle persone autistiche necessitano di supporto per trasmettere conoscenze e valori legati alla sessualità (Holmes, et al., 2020). Di conseguenza l’obiettivo finale dovrebbe essere quello di rendere l’autismo un problema di diversità e non di disabilità, arrivando ad una progettazione di un intervento su misura anche per la salute sessuale dei soggetti con disturbo dello spettro autistico.
In conclusione, i soggetti con disturbo dello spettro autistico risultano essere particolarmente vulnerabili nel periodo adolescenziale, è importante tenere a mente che nonostante essi abbiano bisogni speciali, risultano avere lo stesso sviluppo sessuale e sociale dei loro coetanei con sviluppo tipico.
È fondamentale, dunque, essere consapevoli di queste loro vulnerabilità e diverse capacità di apprendimento e dare loro il supporto di cui hanno bisogno per affrontare con successo l’adolescenza; questo può realizzarsi lavorando collaborativamente con i genitori/caregivers e gli specialisti dei programmi di supporto (Chan & John, 2012).
HAI UNA DOMANDA? 9998 Clicca sul pulsante per scrivere al team di psicologi fluIDsex. Le domande saranno anonime, le risposte pubblicate sulle pagine di State of Mind.
La rubrica fluIDsex è un progetto della Sigmund Freud University Milano.