Cristiana di San Marzano.
Gianrico Carofiglio è stato magistrato, deputato e ora è soltanto scrittore. Un autore molto prolifico, in dodici anni ha pubblicato una decina di libri, che ogni volta scalano le classifiche dei più venduti. L’ultimo, La regola dell’equilibrio, esce lunedì 10 per Einaudi Stile Libero e riporta in scena come protagonista l’avvocato Guido Guerrieri.
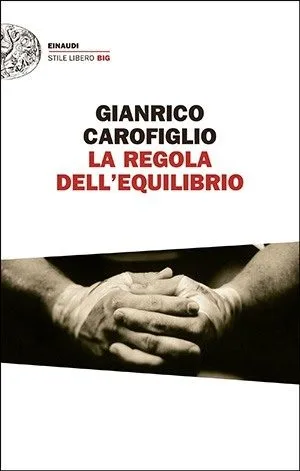
La nostra conversazione parte però da un altro libro, il recente La casa nel bosco, scritto con il fratello Francesco, architetto, illustratore e anche lui scrittore. Un memoir a quattro mani che ci consente di aprire una finestra sul suo percorso adolescenziale. Leggendo il libro che ha scritto con suo fratello sembra che da giovani, fra i due, lei fosse il più estroverso?
Non sono naturalmente estroverso, anzi forse è vero il contrario. Però ho sempre avuto voglia di entrare in contatto con gli altri e quando ero ragazzo avevo difficoltà piuttosto serie a farlo, per la mia timidezza. Ci ho lavorato su parecchio, e credo di essere migliorato, col tempo.
Eppure, come si racconta nel libro, lei è descritto come un attaccabrighe.
Non so se è la definizione esatta. Attaccabrighe è uno che se le va a cercare. Può darsi che qualche volte l’abbia fatto, ma in generale io in realtà tendevo a non tirarmi indietro, ad accettare le provocazioni. Anche questo era una conseguenza della timidezza, dell’insicurezza, il bisogno di dimostrare qualcosa.
Poi a un certo punto ha cominciato a studiare karate.
Avevo 14 anni, e fu una delle strategie per cercare di liberarmi dell’insicurezza di cui dicevo.
Quindi aveva già messo a fuoco questo suo problema.
Molti ragazzini insicuri hanno questo tipo di desiderio. Sono convinti che praticando una disciplina di combattimento diventeranno fisicamente forti, se non imbattibili e questo curerà la loro insicurezza. Certo, può anche accadere, ma in maniera diversa da come uno se lo immagina. Studiando una disciplina di combattimento con consapevolezza si capisce non solo che l’invincibilità non esiste, ma che in generale la cosa più saggia è evitare di combattere. Diciamo che io ci ho messo un po’ di tempo a capirlo e sono stato un po’ rissoso per qualche anno
Fino ai 18, 20 anni.
Qualche propaggine anche oltre (ride).
Forse aveva qualche problema con la rabbia.
Non parlerei di rabbia, era il contrasto fra la paura, che è emozione sana perché aiuta a fuggire situazioni di pericolo, e il bisogno di dimostrare qualcosa. Qualcosa che all’epoca era impreciso per me stesso, ma che mi induceva a rimanere e raccogliere le provocazioni . No, non era rabbia, mi sento di dirlo con sicurezza: tutte le volte che ho fatto a botte non ho mai inferito su chi cadeva a terra.
Spesso si pensa che chi fa arti marziali abbia un problema di aggressività repressa.
C’è di tutto fra chi le pratica, meglio evitare generalizzazioni. Diciamo che studiarle con consapevolezza, con un bravo maestro, senza nessuna esaltazione della violenza e dello scontro, può aiutare la comprensione di certe dinamiche interiori e indirizzare l’attitudine al conflitto in qualcosa di innocuo e addirittura positivo. A me le arti marziali, senza girarci troppo intorno, hanno cambiato la vita.
In che senso?
Ho imparato a fare a botte e poi ho capito che fare a botte non era una buona idea. Può produrre conseguenze imprevedibili e a volte devastanti. Come dicono certi maestri giapponesi, la miglior vittoria è il combattimento che non hai fatto.
Nel corso della sua vita ha poi messo a punto da cosa aveva origine il conflitto che la portava a doversi misurare con un’altra persona, ad accettare provocazioni?
Ero un bambino goffo e timido, avevo paura di tutto e spesso gli altri ragazzini, più svelti di me, mi prendevano in giro. L’incipit di un libro che prima o poi scriverò è: “da bambino avevo paura di tutto”.
Suo fratello invece?
Lui era più fluido, socialmente più adeguato e fisicamente più abile.
I vostri erano genitori molto attenti?
Sì, però hanno sempre giudicato poco rilevante l’educazione fisica. Un’idea sbagliata, direi. Quindi ho fatto tutto da solo.
Badavano di più all’educazione intellettuale.
Sicuramente. Il fatto che io volessi fare sport era considerato bizzarro. Quando poi ho addirittura cominciato a fare agonismo loro davvero non capivano.
Ha mai avuto esperienze di psicoterapia?
Ho attraversato un periodo in cui stavo molto male, ero molto infelice. Non so se fosse una forma depressiva, difficile dirlo, e del resto non vorrei medicalizzare quella che forse era semplice tristezza. In quel periodo, che poi portò al cambiamento più rilevante della mia vita, cioè a scrivere il primo romanzo, sono andato da un medico, che era anche psicoterapeuta, e ho fatto qualche incontro. Tre volte al mese per tre o quattro mesi, mi diede anche un blando aiuto farmacologico. Ma non la definirei una psicoterapia, che forse implica una continuità.
È stato comunque un aiuto?
Difficile dire che cosa abbia aiutato, io credo che la svolta ci sia stata con l’inizio della scrittura. Credo che quel malessere intenso fosse un segnale del corpo e della psiche che dicevano: insomma non perdere altro tempo, c’è una cosa che vorresti fare, falla! Altrimenti ti farai scorrere tutta la vita tra le mani. E la cosa che volevo, da molto tempo, era scrivere.
Perché lei ha cominciato tardi il mestiere dello scrittore.
Avevo scritto dei saggi, ma il mio primo romanzo è uscito nel 2002 e avevo da poco compiuto 41 anni.
Come è successo che aveva deciso di entrare magistratura?
Sbaglio o è un lavoro che fruga nelle vite altrui per scoprire la verità?
È un modo un po’ ruvido di metterla, per dirla più dolcemente spesso capita di andare a guardare in ambiti privati. E anche scoprire la verità è una frase grossa, la metterei così: cercare di avvicinarsi il più possibile a quello che è successo. Il massimo che possiamo fare è avere delle ricostruzioni accettabilmente approssimative di quello che è successo nel passato. Nel mio penultimo romanzo, Una mutevole verità, il protagonista è un maresciallo dei carabinieri che fa una riflessione proprio su cosa significa ricostruire la verità. L’investigatore, come anche lo scrittore, deve costruire una buona storia, plausibile, che per quanto riguarda l’investigatore ricostruisca in maniera plausibile i fatti del passato.
Ricostruire la verità, per uno che lo fa di mestiere, presuppone che abbia ricostruito o per lo meno cercato la verità anche dentro se stesso?
No, certamente no. A parte il fatto che tendo a escludere che sia possibile un’operazione del genere. Bisogna avere obiettivi e prospettive molto più limitati. Essere consapevoli dei limiti delle nostre capacità, consapevoli che anche nella persona più attrezzata tecnicamente e culturalmente il pregiudizio può interferire con la ricostruzione obiettiva dei fatti del passato. Bisogna cercare di tener conto il più possibile dell’effetto distorsivo che deriva dal fatto che noi siamo punti di vista. Ricorda il film Rashomon? Uno deve ricordarlo sempre quando fa l’investigatore o il giudice, deve sempre controllare quali sono le alternative, per poi magari decidere che la prima ipotesi è quella buona. O che quella più adeguata è un punto di mezzo. Quella che noi consideriamo la verità del passato in realtà è solo il risultato di un punto di vista, di un modo di raccontarcelo. Pensi a questa frase che ora le propongo: si può dire che un fatto è vero? é una frase priva di senso, i fatti sono o non sono, noi possiamo dire che un enunciato fattuale, cioè che una storia è vera o no, se corrisponde a come sono andate le cose. È nell’equivoco del fatto vero che si nasconde la presunzione di oggettività che invece non esiste.
Quindi chi indaga in ogni campo, e includo il campo psicologico e medico, deve mettere da parte se stesso.
Deve essere consapevole che egli stesso è un fattore di interferenza, di cui bisogna tener conto. Le citazioni sono sempre un po’ pretenziose, però in fisica c’è il principio di indeterminazione di Heisenberg, che scoprì che non si possono osservare le particelle subatomiche senza interferire sul loro funzionamento, nel momento in cui le osservi sono diverse, l’osservazione interferisce. Questo vale per cose molto meno matematizzabili delle entità fisiche. Uno deve sapere che il punto di vista è decisivo, e quindi cercare poi di non farsene travolgere. Dipende poi su quali elementi si indaga. Se dobbiamo esaminare il filmato di una telecamera lo spazio di soggettività è inferiore a quello che si avrà nella valutazione di un racconto di una persona che usa le sue parole, elabora il suo ricordo, caratterizzato dalle emozioni, dalla paura, dal desiderio. Questo approccio alla verità approssimativo vale a maggior ragione se uno si occupa della psiche altrui. Una volta uno psicanalista molto famoso mi invitò come scrittore a un seminario che teneva ai suoi allievi. Venne fuori un sogno che io avevo scritto in un romanzo, ma che era inventato, e questi si lanciarono in interpretazioni da sganasciarsi dalle risate. Io li lasciai fare, dando anzi ulteriori indizi che potevano essere considerati sintomi, e loro senza un filo di dubbio si lasciarono andare a diagnosi ridicole. Pericolosissimo.
Non è che lei quando ha fatto la sua psicoterapia era un po’ prevenuto verso la categoria…
No, quel signore era bravo, equilibrato, senza verità categoriche. Diceva cose sensate. Einstein sosteneva che il buonsenso è il genio in abiti da lavoro. Nel mio romanzo Il silenzio dell’onda (storia di un maresciallo dei carabinieri che attraverso i colloqui con il suo psichiatra racconta il passato), il personaggio che più mi è piaciuto raccontare è quello dello psichiatra, uno così mi piace eccome. Sono affascinato da quelle professioni, se fatte nel modo giusto, non da stregoni o da detentori di un sapere magico. Quando mi capita di incontrare qualcuno che ha questo tipo di approccio, laico, dubitante, sono affascinato perché so che quando ci si muove in questo modo, per tentativi, facendo anche errori, e sapendo che li si dovranno poi correggere, si scoprono cose incredibili. Vale per tanti campi. È la stessa tecnica di un bravo investigatore.
Tornando al periodo in cui è stato male, ha poi capito cosa la bloccava nella scrittura se questa era la sua aspirazione?
Non so darle una risposta. Me lo sono chiesto più volte, ma senza troppo accanimento, non ho una visione deterministica delle cose. Probabilmente bisognava aspettare che arrivasse il momento giusto.
Poi ha cominciato e non si è più fermato, possibile che la sofferenza si sia incanalata nella scrittura?
Di certo non ho scritto per curarmi, ma se è vero che la sofferenza derivava dal non scrivere, l’avere scritto ha in parte curato quella sofferenza e poi ha messo in moto un cambiamento.
Ha ancora periodi di sofferenza?
Spesso, tutti quanti ne abbiamo, però quel tipo di sofferenza no.
E quando le capita di soffrire, c’è un luogo dal quale nasce questa desolazione?
Un luogo interiore?
Certo.
Non uno specifico, me ne vengono in mente tanti. Per esempio a volte mi fa diventare triste la sofferenza di altre persone cui voglio bene, che vorrei aiutare e mi accorgo che non posso. Ho sempre avuto la pessima abitudine di dare consigli, appunto perché vorrei aiutare, poi ho capito che non serve a nulla. Quello a volte mi da un senso di grande frustrazione. Ecco, a me sarebbe piaciuto fare lo psicoterapeuta, mi piacerebbe aiutare le persone. E una delle enormi fonti di soddisfazione della scrittura è quando uno ti dice, e mi è capitato: “Ero davanti alla sala operatoria dove mio marito subiva un intervento delicatissimo. La notte è passata senza che me ne accorgessi perché stavo leggendo un suo libro. Non potrò mai smettere di ringraziarla per questo”. So anche che diversi psicoterapeuti e psichiatri hanno ‘prescritto’ ai pazienti come percorso di superamento dei loro problemi la lettura di Testimone inconsapevole, e questo mi ha fatto piacere.
Ricorre a delle strategie per non stare nel luogo del dolore?
Sono posti che non amo in generale, ma penso anche che non si deve avere il terrore della sofferenza come della tristezza. Arriva. Il crogiolarsi, l’autocommiserarsi lo trovo insopportabile. Può capitare, e se avverto un momento in arrivo, sì, attuo delle strategie, a cominciare dalla gratitudine.
Cosa intende?
Forse rischio di apparire retorico, però io sono un convinto fautore, in modo laico, dell’importanza etica e dell’utilità pratica della gratitudine. Si fermi un attimo a pensare a tutte le cose – cose semplici, che diamo per scontate – di cui possiamo essere grati in questo preciso momento. Se sei triste e pensi che potresti essere cieco, o non avere l’uso delle gambe o cose simili, e pensi come sarebbe la tua vita senza vista, senza gambe, in questo momento, riesci a cogliere meglio le proporzioni delle cose e delle sofferenze. La gratitudine è un ottimo strumento, intanto per evitare quella cosa tossica che è la lamentela, l’autocommiserazione, poi per attenuare di molto quando capita, e capita, la tristezza, la sofferenza.
Altre strategie?
Lei mi sembra una persona molto razionale, o che comunque cerca di superare con la razionalità i momenti più difficili.
Cerco di usare lo strumento della ragione nei limiti in cui funziona, consapevole che sono limiti circoscritti. Ci sono molte cose che sfuggono del tutto al controllo razionale ed è bene saperlo con chiarezza.
Ma le emozioni le lascia fluire?
Come no, me le vivo. Ma ripeto, a volte si confonde il vivere le emozioni con questa concentrazione su se stesso, questa confabulazione continua che francamente mi sembra ridicola. Se uno si ferma un attimo a riflettere si rende conto che spesso sono banali le preoccupazioni che ci sembrano fondamentali, si tratta di sbarazzarci di questa tirannia. Io per primo, a volte mi preoccupo di cose di cui mi vergogno due minuti dopo. Ora sono diventato più rapido a sbarazzarmene, però le penso. A volte mi accorgo di avere dei desideri meschini, come tutti. Poi mi fermo – sei ridicolo, mi dico – e lascio perdere.
D’obbligo una domanda sulla sua esperienza in Parlamento.
Psicopatologicamente vuol dire?
Sì.
Beh, interessante. Purtroppo la politica, oggi forse più che in passato, è una pratica che anche nelle persone perbene e competenti – naturalmente ce ne sono – tende a produrre un involgarimento. Nei cinque anni che sono stato là ho visto persone normali all’inizio che erano diventate veramente pessime alla fine. Il potere, o anche solo la vicinanza al potere, ha una capacità corruttiva, nel senso della corruzione del carattere. Le eccezioni sono piuttosto rare.
Lei è uno scrittore di successo.
Non mi piace la parola successo
Beh, allora diciamo che vende tantissime copie dei suoi libri. Non le viene mai l’ansia di non riuscire più a fare i numeri che ha fatto finora nelle vendite?
Se mi viene l’ansia me la faccio passare continuando a lavorare. Se pensi di non sbagliare mai sei spacciato. É inevitabile e utile per tutti sbagliare, anzi uno dovrebbe moltiplicare gli errori perché in questo modo riduce il rischio degli errori gravi. Moltiplicare le manovre di assestamento. Io cerco di scrivere onestamente, di raccontare storie dove ci siano personaggi in cui sia facile immedesimarsi, non esiste l’algoritmo del successo in generale, tantomeno letterario. Però mi dicono che in tanti soffrono di questo, io soffro di tanti difetti, che non le dirò perché me ne vergogno, ma non di questo.
Mi dica uno di questi difetti.
La vanità. Ce l’ho e non mi piace. Ci sono momenti in cui con grande fastidio mi accorgo di essere assorbito da me stesso. Per fortuna in quei momenti mi sento ridicolo. Il senso del ridicolo, lo ripeto, è un grande antidoto, una grande medicina.
La prossima settimana: Intervista con Cristina Comencini.
LEGGI ANCHE:






