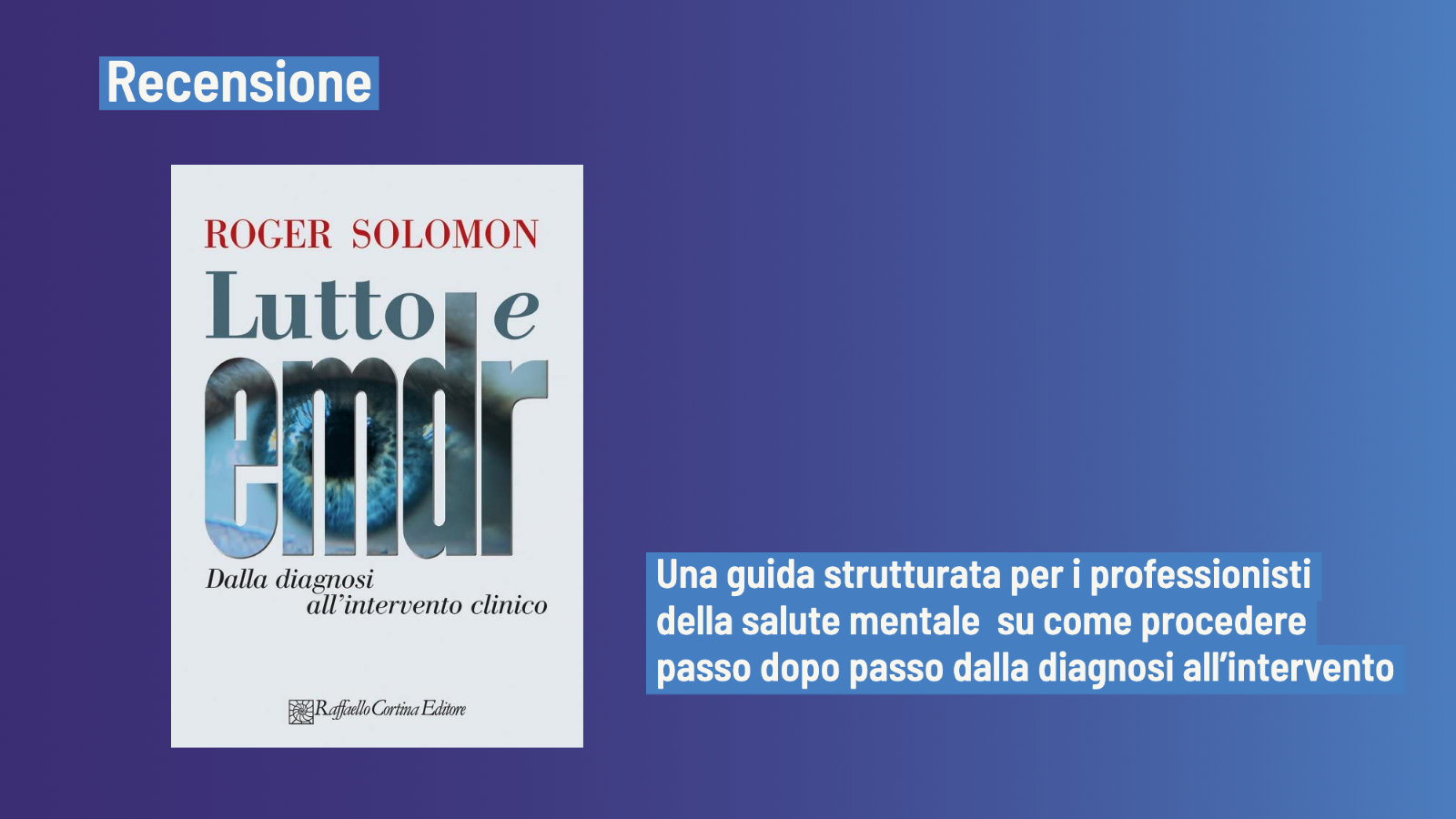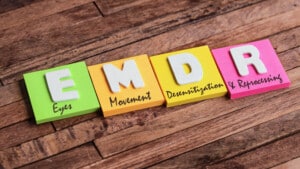La narrazione di un paziente sottoposto a trapianto cardiaco: temi e piani di vita semi-adattivi
Il presente articolo ha lo scopo di raccogliere in letteratura ciò che allo psicoterapeuta può essere utile conoscere quando all’attenzione clinica si presentano persone che chiedono un aiuto a seguito di un evento acuto che cambierà inevitabilmente molti aspetti della vita: il trapianto cardiaco.
Elisa Covini, Antonia Pierobon – OPEN SCHOOL Psicoterapia Clinica e Ricerca
Possiamo collocare all’interno della disciplina nota come psicologia della salute, l’insieme degli interventi di competenza dello psicologo nel percorso di ricovero delle persone affette da una malattia organica. Alcune condizioni cliniche (come ad esempio le malattie croniche) comportano nelle persone un forte cambiamento nello stile di vita, nelle relazioni, negli scopi che fino a quel momento potevano essere messi in discussione con più o meno flessibilità.
È proprio questa flessibilità, questa capacità di adattamento alle condizioni di vita che cambiano, che aiuta le persone a modificare gli schemi e a ricostruire un futuro adattandosi agli eventi ambientali (Dobbie et al., 2008, Pierobon et al., 2011).
Il presente articolo ha lo scopo di raccogliere in letteratura ciò che allo psicoterapeuta può essere utile conoscere quando all’attenzione clinica si presentano persone che chiedono un aiuto a seguito di un evento acuto che cambierà inevitabilmente molti aspetti della vita: il trapianto cardiaco. Entreremo quindi più in dettaglio in merito alle caratteristiche del trapianto cardiaco e presenteremo un caso clinico con lo scopo di esplicitare il lavoro terapeutico che ha permesso di organizzare in modo più funzionale piani di vita narrati in modo confuso, caotico e disorganizzato anche sul piano temporale.
L’intervento dello psicologo nei casi di trapianto cardiaco
Con il termine patologia cardiaca racchiudiamo una serie di condizioni cliniche che hanno caratteristiche, non solo mediche, ma anche psicologiche differenti. Nelle condizioni cliniche per le quali si richiede trapianto cardiaco, l’attività dello psicologo agisce su più livelli:
La diagnosi
L’attesa dell’intervento chirurgico
La gestione della convalescenza post-trapianto cardiaco.
Nelle prime due fasi descritte, il nostro intervento si basa su aspetti di accettazione della malattia cronica presente, di mantenimento dell’aderenza alle prescrizioni cliniche e di preparazione all’intervento. La fase del post-trapianto cardiaco implica elevate quote di stress e può condurre alla comparsa di aspetti psicopatologici, caratterizzati da sintomi ansiosi e depressivi specie nei pazienti di giovane età e con disturbi psichiatrici in anamnesi (Dew & DiMartini, 2005; Conway et al., 2013).
In particolare, si è stimato che la frequenza per diagnosi psichiatriche è del 12% per PTSD e del 41% per Depressione Maggiore dove, inoltre, la presenza di un episodio depressivo in anamnesi pre-trapianto è un fattore di rischio indipendente e significativo di neoplasie post-trapianto (Favaro et al., 2011). Altri studi invece più specificatamente hanno dimostrato come l’incidenza di Depressione Maggiore è del 15 % nel primo anno post-intervento e del 30% nei tre anni successivi al trapianto cardiaco (Zipfel et al., 2002; Owen et al., 2006). È inoltre utile tenere in considerazione quali sono i fattori che incrementano lo stress psicologico: in letteratura emergono l’utilizzo di strategie di coping passive, basso supporto sociale e carente senso di controllo (Dew&DiMartini, 2005).
Il modello LIBET applicato nei casi di trapianto cardiaco
La concettualizzazone del caso è sviluppata utilizzando il modello LIBET (Life themes and plansImplications of biasedBeliefs: Elicitation and Treatment, Sassaroli & Ruggiero, 2012). Innanzitutto consideriamo il ruolo che un evento significativo può avere in relazione ai piani di vita del paziente. Vale a dire l’insieme degli scopi che l’individuo persegue a lungo termine, che gli consentono di dare una direzione, un senso e un ordine alla sua vita, indaghiamo come questi si siano strutturati e comprendiamo come per un certo periodo abbiano aiutato la persona ad evitare di trovarsi nel luogo doloroso. Alcuni eventi di vita possono comportare la rottura del piano, specie se precario e se inflessibile: l’esperienza clinica ci suggerisce che il trapianto cardiaco può essere annoverato tra questi.
Nella fase post-trapianto cardiaco è utile valutare attentamente questi aspetti e indagare i piani di vita e ridefinire il sé dell’individuo, incrementando innanzitutto le risorse a disposizione. Infatti dalla letteratura emerge che per incrementare il benessere psicologico post-trapianto cardiaco sia utile potenziare le risorse quali la percezione di controllo sulla propria salute, l’ottimismo e il confronto con altri pazienti che condividono la medesima esperienza. È inoltre efficace sostenere il supporto sociale per facilitare il passaggio verso una nuova ritrovata indipendenza (Conway et al., 2013). Questo ci potrebbe condurre, nell’ottica del modello LIBET, ad intervenire favorendo la costruzione di piani di vita più funzionali in questa direzione.
Trapianto cardiaco: il caso di Roberto
Roberto ha 50 anni, è sposato e ha tre figli, ha lavorato come impiegato in un’azienda ed è appassionato di meccanica. È affetto da Cardiomiopatia Dilatativa da una decina d’anni. Nella fase successiva al trapianto cardiaco le aree di valutazione coinvolgono lo stato emotivo, i disturbi di rilevanza psichiatrica pregressi e attuali, l’aderenza alle prescrizioni cliniche, il ritorno a lavoro, la sfera sessuale (Sommaruga et al., 2003).
Al primo accesso al Servizio di Psicologia, presso la Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS, Istituto Scientifico di Montescano (PV), Roberto osserva gli operatori, non racconta molto di sé, evita il contatto visivo. Gli chiediamo di descriversi e scopriamo, attraverso la scrittura, buone capacità metacognitive ed il bisogno di raccontare il vero Roberto. Così inizia il percorso che, a pochi giorni dal trapianto cardiaco, lo porta a raccontare e raccontarsi ed emergono così i piani di vita che fino a quell’evento erano stati presenti nella vita di Roberto, piani che hanno comportato un costo emotivo e che hanno anche permesso di non accedere al tema di vita di tipo ansioso, che sottende un senso di inadeguatezza e fragilità.
Nel primo colloquio il paziente narra una storia familiare di perdita legata a numerosi lutti dovuti alla malattia cardiaca di origine genetica. Si è strutturato un progetto di intervento, finalizzato all’incremento del benessere psicologico per mezzo di una narrazione coerente di sé e della propria storia, che includesse due percorsi: il primo legato alle fasi di elaborazione del lutto (KublerRoss, 1976) o in questo caso di perdita di funzionalità legata alla malattia ingravescente (negazione-distacco/rabbia/contrattazione-patteggiamento/depressione/accettazione), il secondo focalizzato sul riconoscimento dei piani semiadattivi, su come questi si siano strutturati e su quali risorse poter attivare allo scopo di mettere in atto strategie più efficaci.
Decidiamo insieme a Roberto di lavorare sul riconoscimento del piano di vita controllante e ipercompensativo, appreso dai genitori, da piccolo. Il bisogno di tenersi in movimento e di non fermarsi davanti alle difficoltà l’ha spinto a fare sempre di più, a sfruttare il tempo a disposizione per aiutare gli altri e per dedicarsi alle sue passioni. È sempre stato un abile lavoratore e un amico sul quale poter contare, non ha mai fallito. Roberto si descrive come ‘spensierato, altruista e determinato‘ raccontando così lo sviluppo del piano: in età giovane Roberto era calmo tranquillo e socievole, amico di tutti. Lavora con voglia e intraprendenza per migliorare capacità e salario, ha hobby e sport di tutti i generi. Con la notizia della malattia cardiaca arriva la mazzata; nella vita di Roberto qualcosa inizia ad incrinarsi, inizia ad isolarsi, ad avvicinarsi a quel tema doloroso che fino ad allora aveva tenuto distante:
Non me la sento di dire che era una cosa che mi è appartenuta perché il mio isolarmi e il mio non lamentarmi erano funzionali a non far trapelare i miei stati di salute agli altri per non destare preoccupazioni o paure nei miei cari.
Roberto si descrive nel limbo perché la percezione interna permane consona allo stato di salute (Roberto sofferente), ma il paziente evita di manifestare all’esterno aspetti legati al tema per non per perdere il ruolo (Roberto isolato e freddo). Mantiene l’iperattività su un piano sociale e lavorativo e si isola dai propri e altrui bisogni affettivi con stati emotivi caratterizzati da tristezza, rabbia, distacco verso l’esterno. Osserviamo in questa fase la messa in atto di un piano prudenziale di evitamento. In questo limbo ci sono rari ma intensi episodi di irascibilità, nel momento in cui Roberto rabbioso non riesce a controllare la ribellione interna tra il vissuto e la negazione esterna di malattia.
Roberto distingue bene infatti quella che è la sofferenza psichica da quella fisica dicendo:
La sofferenza fisica ognuno di noi l’affronta in qualche modo, invece quella psichica può essere più difficile: il mio pensiero al riguardo è che se un individuo si lascia sopraffare, entra in una situazione pericolosa carica di incertezze.
Il percorso psicologico ha portato a raggiungere l’obiettivo prefissato: dare voce al dialogo interno di Roberto, a quello che diceva tra sé e sé e non faceva trapelare, ad una narrazione più coerente con la propria storia di vita. In termini più tecnici, l’intervento si è bastato sull’integrazione dell’approccio terapeutico cognitivo-comportamentale in ambito riabilitativo cardiologico con il modello LIBET.
In particolare, accanto alla critica logica ed empirica delle credenze distorte si è aggiunta l’attenzione per gli stati ritenuti intollerabili del tema di vita e la pianificazione di un impegno a perseguire un piano di vita più funzionale. Molta attenzione è stata dedicata all’accoglimento validante delle emozioni del paziente e alla condivisione degli stati emotivi e dei pensieri che l’hanno accompagnato e lo accompagneranno in un momento di rottura e di rinascita della sua vita.