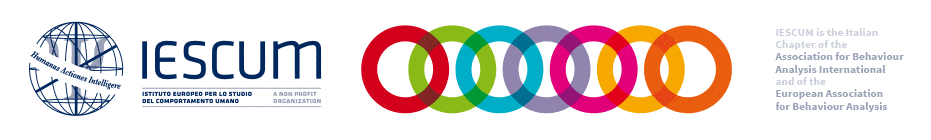Omogenitorialità: questioni e temi connessi al rapporto tra genitorialità e omosessualità
Omogenitorialità: si toccano diversi temi interessanti come la definizione di famiglia, la natura dell’omosessualità e l’impossibilità biologica di concepire autonomamente un figlio. Si fa riferimento alla scienza (quasi parlando per essa) sostenendo che i bambini abbiano bisogno di entrambe le figure, altrimenti svilupperanno patologie e problematiche psicologiche. L’impressione è che ci si preoccupi davvero molto, forse perché ciò che non si conosce spaventa, e si dà per scontato che terrorizzi tutti.
Daniela Beltrami, Vania Galletti, OPEN SCHOOL STUDI COGNITIVI MODENA
Parafrasando gentilmente Umberto Eco: grazie ai social network tutti possono dire tutto, subito e senza filtri. Una scocciatura che può regalarci importanti spunti di riflessione.
Recentemente, su uno dei più utilizzati social network in Italia è comparsa una fotografia raffigurante una coppia che abbraccia il figlio appena nato, ancora imbarazzata nella presa, ma visibilmente emozionata; i neogenitori sono a petto nudo per “favorire il contatto della pelle del bimbo con la loro”. Un’immagine in bianco e nero, semplice, pulita, che ritrae l’immensità – non altrimenti descrivibile – dell’istante in cui un neonato prende contatto con gli occhi di coloro che lo spingeranno, porgendo soltanto un dito, a camminare, parlare, osservare e vivere. Niente di più bello e sorprendente, insomma, eppure il post è stato bombardato da una granata di commenti piuttosto coloriti di varia natura.
Omogenitorialità: le questioni e i dubbi
Nel tentativo di capire quale sia il dettaglio che ci sfugge, e che stimola diverse persone a vedere “schifo”, “paura”, “egoismo” (ecc.) in quell’immagine, proseguiamo la lettura dell’articolo di riferimento: innanzitutto Milo (così si chiama il neonato) è nato da una madre surrogata, pratica considerata illegale in Italia (anche se è lecito ricondurre in patria pargoli avuti di soppiatto all’estero); inoltre, la coppia di genitori ritratta, è composta da Bj e Frankie, due omosessuali canadesi, e l’articolo s’intitola “La commozione dei neopapà che abbracciano il figlio”. I commentatori contrari non si risparmiano e volano dichiarazioni interessanti: la famiglia è fatta da una madre e un padre (in realtà c’è chi sostiene che sia un “nucleo sociale rappresentato da due o più individui che vivono nella stessa abitazione e, di norma, sono legati tra loro col vincolo del matrimonio, con convivenza, o da rapporti di parentela e di affinità”, ma chiaramente l’interpretazione è libera; Fabietti & Remotti, 1997); ad un bambino servono entrambe le figure; l’uomo è disposto a tutto pur di soddisfare le sue voglie, ma se due uomini non possono procreare un motivo ci sarà; cosa diremo a quel bambino quando chiederà di sua madre? E così via.
Con l’ omogenitorialità si toccano diversi temi interessanti come la definizione di famiglia, la natura dell’omosessualità e l’impossibilità biologica di concepire autonomamente un figlio. Si fa riferimento alla scienza (quasi parlando per essa) sostenendo che i bambini abbiano bisogno di entrambe le figure, altrimenti svilupperanno patologie e problematiche psicologiche. Addirittura ci si preoccupa di rispondere in qualche modo alle domande che questi giovani potranno fare rispetto al genitore biologico mai conosciuto, più di quanto si sia mai fatto per le adozioni da parte di coppie eterosessuali.
Insomma, l’impressione è che ci si preoccupi davvero molto, forse perché ciò che non si conosce spaventa, e si dà per scontato che terrorizzi tutti. Considerando la “normalità” dal punto di vista numerico, le classi scolastiche multietniche che oggi popolano l’Italia fino a qualche anno fa erano considerate “anormali”. Del resto, già colpisce positivamente che non vi siano commenti omofobi: ben lungi da essere considerata “normale”, nel 2015 l’omosessualità è accettata senza giudizio (almeno dalle giovani leve).
Omogenitorialità in Italia
In Italia l’argomento omogenitorialità (anche detto omoparentalità o in inglese “gay parenting“) è piuttosto nuovo, ma nel mondo se ne parla già da un po’. Nel 2000, negli Stati Uniti, il 33% delle coppie lesbiche e il 22% di quelle gay dichiaravano di avere almeno un figlio minorenne; nel 2005 i figli di coppie omosessuali erano circa 270.313, nel 2010 oscillavano tra 600 mila e 4 milioni (Weber, 2010). Oggigiorno le coppie dello stesso sesso possono accedere all’adozione di minori in ben ventuno Paesi (Spagna, Francia, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svezia, Norvegia, Danimarca, Austria, Islanda, Malta, Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina, Brasile, Uruguay, Sudafrica, Australia e Nuova Zelanda), mentre possono adottare i figli del partner in Germania, Finlandia e Groenlandia.
In Italia la situazione è diversa: possono fare ricorso alle tecniche di fecondazione assistita solo persone coniugate o coppie di fatto (quindi esclusivamente eterosessuali); possono adottare solo persone coniugate (quindi eterosessuali). A differenza di ciò che accade in altre parti del mondo, le coppie omosessuali in Italia non sono riconosciute come famiglia e non sono legittimate ad avere figli, anche se oltre il 49% vorrebbe poter adottare un bambino (ricerca finanziata dell’Istituto Superiore di Sanità). Spesso per giustificare questa realtà, ci si appella alla scienza: ma cosa dice la scienza in proposito?
Le ricerche sulla omogenitorialità
Nel 2005 l’APA (associazione che rappresenta gli psicologi negli USA) sulla base delle ricerche condotte sulla omogenitorialità sentenzia: [blockquote style=”1″]Non esiste un solo studio che abbia rilevato che i figli di omosessuali sono svantaggiati in qualche aspetto significativo rispetto ai figli di genitori di eterosessuali [/blockquote](APA, 2005); nel 2012 ha confermato: [blockquote style=”1″]Non ci sono evidenze scientifiche che l’efficacia parentale sia correlata all’orientamento sessuale: i genitori omosessuali sono alla pari di quelli eterosessuali nel fornire un ambiente supportivo e sano ai loro bambini.[/blockquote] Sembrerebbe un epilogo piuttosto netto, eppure le critiche non tardano ad arrivare. Il problema principale è che molti degli studi considerati sono stati supportati da programmi politici e presentano importanti difetti metodologici (omogeneità dei campioni e assenza di adeguati gruppi di controllo, debole validità statistica, dati contradditori, assenza di studi longitudinali, ecc.; Belcastro et al., 1993; Patterson, 1995; Marks, 2012). Sulla base di questi limiti, Marks (Marks, 2012) afferma: [blockquote style=”1″]dichiarazioni forti, incluse quelle fatte dall’APA, non sono sperimentalmente giustificate.[/blockquote]
Prima di addentrarci nella letteratura scientifica, scandagliamo alcune delle problematiche sulla omogenitorialità sopra elencate:
– i campioni sono poco numerosi (Huggins, 1989; Bailey et al., 1995; Golombok & Tasker, 1996; Tasker & Golombok, 1995; Javaid et al., 1993), sono omogenei e dunque scarsamente rappresentativi della popolazione di riferimento; la maggior parte delle famiglie che prendono parte agli studi hanno a capo [blockquote style=”1″]madri lesbiche bianche, ben istruite, relativamente benestanti (…)[/blockquote] (Patterson, 1995);
– difficilmente si hanno a disposizione gruppi di figli adulti (quasi sempre si tratta di bambini o ragazzi) e scarseggiano gli studi longitudinali; questo impedisce considerazioni a lungo termine;
– capita che i figli inclusi nei gruppi sperimentali siano stati adottati e dunque siano più a rischio di sviluppare problematiche psicosociali (difficile è la costituzione di gruppi di controllo);
– spesso manca un gruppo di controllo adeguato: ad es. gli omosessuali che decidono di diventare genitori sono molto motivati, quindi non dovrebbero essere messi a confronto con genitori biologici;
– spesso vengono utilizzate misure “self-report” (questionari compilati dai genitori): spinti a dimostrare che gli omosessuali sono capaci di crescere bambini sani e felici, alcuni potrebbero desiderare di presentare se stessi e le loro famiglie nella miglior luce possibile (Gartrell, 1996); [blockquote style=”1″]secondo le madri, i figli delle madri lesbiche sono migliori a scuola e mostrano meno problemi rispetto ai pari[/blockquote] (Gartrell, 2010);
– è difficile controllare variabili quali l’instabilità di coppia e lo stress ambientale, fattori che non dipendono dalle scelte sessuali ma dal contesto; ecc.
Questi limiti sono spesso specificati al termine degli studi, e le conclusioni ne tengono conto, contestualizzando i risultati ed esprimendo la necessità di ulteriori ricerche. Analizziamo ora i risultati ottenuti.
Gli studi condotti sulla omogenitorialità (per lo più madri lesbiche con precedenti esperienze di famiglie etero; Gartrell & Bos, 2010; Stacey & Bilbarz, 2001) si sono focalizzati principalmente sulle abilità genitoriali e il benessere psicologico dei bambini (APA, 2005; Short et al., 2007).
a) Abilità genitoriali nelle famiglie omogenitoriali
La maggior parte delle ricerche (Perrin & Siegel, 2013) rivela che non vi sono differenze significative tra le abilità di parenting di coppie omosessuali ed eterosessuali (Bos et al., 2004; Morse et al., 2007; Patterson, 2007). Tuttavia, le coppie dello stesso sesso (per lo più lesbiche) riportano un livello d’impegno genitoriale più elevato e percepiscono la diade come maggiormente stabile (Baiocco et al., 2013), nonostante lo scarso sostegno da parte della famiglia d’origine (Kurdek, 2004); sono più propense a risolvere i problemi e ad affrontare tematiche conflittuali contribuendo a mantenere più alta la stabilità di coppia (Gottman et al., 2003), la genitorialità e le decisioni importanti (Farr & Patterson, 2013; Patterson, 2000).
Ciò che distingue i due gruppi, ma non dipende dalle abilità di parenting, é l’impatto del cosiddetto “minority stress” sul benessere individuale, dovuto alla stigmatizzazione subita dalla comunità LGBT (Lingiardi, 2012; Lingiardi et al., 2012). L’esposizione a tale stress risulta significativamente correlata a maggiori difficoltà rispetto all’esperienza dell’essere genitori (Armesto, 2002; DeMino et al., 2007). Infatti, le coppie omosessuali riferiscono sicurezza rispetto alle proprie competenze genitoriali, esprimendo la convinzione che l’aspetto importante risiede nella qualità della relazione e non nell’orientamento sessuale (Chan et al., 1998; Patterson, 2006), tuttavia riportano alcune difficoltà (Baiocco, 2013) tra cui: il mancato riconoscimento del partner (e dei suoi diritti) come genitore biologico del bambino e il bisogno di fornire spiegazioni rispetto alla propria famiglia; la sensazione di essere privati dallo Stato di alcuni fondamentali diritti (riconoscimento della coppia e matrimonio, tutela rispetto a discriminazioni lavorative e fiscali, maternità/paternità, ecc.).
Lesbiche e gay sentono la necessità di sensibilizzare le persone alla realtà omogenitoriale e agli effetti dell’omofobia. Tali richieste sono riportate in letteratura (APA, 2005; Patterson, 2009; Short et al., 2007) e sono motivate dalla paura che la discriminazione, da loro sperimentata, possa nuocere ai figli.
b) Benessere psicosociale dei figli di genitori omosessuali
In nessuna delle aree analizzate relativamente al benessere dei bambini (identità sessuale, sviluppo cognitivo, emotivo e psico-sociale) sono state rilevate differenze significative. La maggior parte dei figli di omosessuali si dichiara eterosessuale (APA, 2005; Gartrell et al., 2010), non presenta problemi psicologici, cognitivi o comportamentali (Bos, 2004; MacCallum & Golombok, 2004; Stacey & Biblarz, 2001; Tasker, 2010) e vive relazioni non problematiche (Patterson, 2009). Stacey & Biblarz (2001) evidenziano una maggior apertura mentale rispetto allo sviluppo psicosessuale (maggior desiderio di sperimentare rapporti omosessuali e minor aderenza ai tradizionali ruoli di genere). Nuovamente, sembra che un fattore in grado di far scricchiolare il benessere psicologico di questi giovani sia la stigmatizzazione sociale (Bos, 2004; MacCallum & Golombok, 2004; Short et al., 2007; Weber, 2010). Gli episodi di discriminazione preoccupano molto anche i genitori, soprattutto i papà (forse indeboliti dalla lotta con stereotipi squalificanti che li descrivono come meno portati alla genitorialità).
I bambini cresciuti da coppie dello stesso sesso, quindi, non svilupperebbero problematiche legate all’orientamento sessuale dei genitori, ma potrebbero soffrire a causa di esperienze dirette o indirette di stigmatizzazione omofobica (Van Gelderen, et al., 2015). Uno dei pochi studi che ha mostrato effetti negativi sul benessere dei figli (Regnerus, 2012) è stato fortemente criticato subito dopo la pubblicazione a causa di anomalie metodologiche.
c) Mamma e papà a confronto
Molti di coloro che si oppongono alla omogenitorialità sostengono che i bambini necessitino di un padre ed una madre per uno sviluppo ottimale (Biblarz & Savci, 2010).
Interessante, a tal proposito, è il Comunicato Stampa approvato dal Direttivo dell’Ammissibilità dell’adozione di minori da parte di una singola persona (2011):
[blockquote style=”1″]le affermazioni secondo cui i bambini per crescere bene avrebbero bisogno di madre e padre non trovano riscontro nella ricerca internazionale sul rapporto fra relazioni familiari e sviluppo psico-sociale. Ciò che è importante (…) è la qualità dell’ambiente familiare che i genitori forniscono, indipendentemente dal fatto che siano conviventi, separati, single, dello stesso sesso. I bambini hanno bisogno di adulti in grado di garantire cura e protezione, insegnare il senso del limite, favorire tanto l’esperienza dell’appartenenza quanto quella dell’autonomia, negoziare conflitti e divergenze, superare incertezze e paure, sviluppare competenze emotive e sociali. [/blockquote]
Gli studi non mostrano che, a confronto con altre forme di famiglia, quelle condotte da genitori biologici e sposati siano le migliori, ma che una coppia di genitori compatibili è meglio di un singolo genitore, indipendentemente dal sesso, dallo stato civile, dall’identità sessuale o biologica (Biblarz & Stacey, 2010).
Inoltre, sembra che mamme e papà omosessuali non possano essere sovrapposti a mamme e papà eterosessuali; una coppia genitoriale formata da due lesbiche non equivale ad una mamma sola, e lo stesso discorso può essere fatto per i papà. Vediamo in che modo.
Nel confronto con i padri, le mamme generalmente trascorrono più tempo con i figli (Brewaeys et al., 1997; Fulcher et al., 2008; Vanfraussen et al., 2003a), tendono a giocare di più e a disciplinarli di meno (Golombok e al., 2003), si mostrano maggiormente calorose e comunicative (Bos et al., 2007; Golombok et al., 1997).
La madre facente parte di una coppia lesbica è libera nell’espressione della femminilità (dunque incorpora le caratteristiche sopra elencate), ma è portata ad assumere tratti più maschili a livello di disciplina e finanza (Reinmann, 1998; Sullivan, 2004) scatenando liti più dure ma meno frequenti (Golombok et al., 1997; MacCallum & Golombok, 2004). All’interno della coppia omosessuale, la mamma biologica si assume più responsabilità rispetto al figlio e ottiene maggior intimità (Bos et al., 2007; Wainright et al., 2004), scatenando, a volte, la gelosia della partner (del resto è come se la coppia fornisse al pargolo una doppia dose di genitorialità femminile). Forse grazie alle figure maschili delle quali la madre si circonda, sembra che crescere senza un padre non impedisca lo sviluppo di caratteristiche mascoline, ma promuova quello di caratteristiche femminili e di una maggior flessibilità di genere (Fulcher et al., 2008; MacCallum & Golombok, 2004), scoraggiando la differenziazione tra maschi e femmine in termini di superiorità (Bos et al., 2006).
Gli studi sui gay, come già ampiamente ribadito, sono piuttosto rari. Possiamo comunque dire che i papà omosessuali non danno vita ad una coppia genitoriale caratterizzata da una doppia dose di mascolinità, bensì adottano pratiche più “femminili”. Il modo in cui un gay fa il genitore si avvicina maggiormente a quello di una lesbica piuttosto che a quello di un padre sposato (Biblarz & Stacey, 2010);
[blockquote style=”1″]essendo gay non sono una madre, ma mi sembra di avere più in comune con una mamma che con un papà. (…) In molti modi, nonostante sia uomo, sono un padre ma anche una madre (Mallon, 2004).[/blockquote]
Dato che il percorso che porta un gay a diventare papà necessita di molta più motivazione di quella di un etero o di una lesbica, i gay che decidono di diventare padri sono un gruppo selezionato e ristretto (Stacey, 2006).
Presi adeguatamente in considerazione i numerosi limiti metodologici e di campionamento degli studi riportati, possiamo concludere in questo modo: sembra che l’identità sessuale dei genitori non abbia effetti significativi sulla relazione genitore-figlio, sull’orientamento sessuale e sul benessere psicosociale e cognitivo del bambino (Crowl et al., 2008; Rosenfeld, 2010; Stacey & Biblarz, 2001; Tasker, 2005; Wainright & Patterson, 2008); anzi, i figli di coppie omosessuali (soprattutto lesbiche, che vengono viste più disponibili e supportive dal punto di vista emotivo; MacCallum & Golombok, 2004; Vanfraussen et al., 2003a), presentano addirittura più elevati livelli di benessere psicologico e atteggiamenti più liberi, flessibili e meno conformisti (Biblarz & Stacey, 2010); questo può essere dovuto al fatto che i genitori omosessuali sono un gruppo selezionato di individui estremamente motivati che si impegnano molto nel compito genitoriale, inventandosi un ruolo apparentemente in grado di sopperire alla mancanza della figura materna o paterna. Sicuramente sono necessari studi longitudinali e più appropriati dal punto di vista metodologico.
Conclusioni
Ad oggi l’unico dato che si pone a sfavore del omogenitorialità sembrerebbe essere rappresentato dall’impatto negativo che le esperienze di stigmatizzazione omofoba (che vedono omosessuali e prole più a rischio; Tasker, 2010) potrebbero avere sul benessere psicologico dei bambini. Tali esperienze, tuttavia, non dipendono strettamente dal omogenitorialità, ma dalla sensibilizzazione e dall’accettazione sociale.
Siccome questo pare essere l’unico rischio effettivamente rilevato da decenni di studi scientifici (altri dati contrastanti sono stati duramente criticati, etichettati come transitori o non riconducibili ad un effetto diretto della genitorialità; Vanfraussen et al. 2002; Bos et al., 2008; Tasker & Golombok, 1997; Golombok et al., 1997), è forse il caso di fare qualcosa? Se i nuclei familiari che si allontanano dal modello tradizionale (padre/madre/figlio) sono vissuti come pericolosi e destabilizzanti (Ciriello, 2000), è forse il caso di fare qualcosa?
Se nel Rainbow Europe Package 2015 (che valuta lo stato dei diritti delle persone LGBT in Europa rispetto a: eguaglianza/discriminazione, famiglia, libertà di associazione ed espressione, riconoscimento legale del genere e asilo), l’Italia si è posizionata al 34° posto su 49 paesi europei, è forse il caso di fare qualcosa?
Nonostante i dati parlino chiaro pur essendo ricavati da studi limitati, possiamo avere dubbi o perplessità, quantomeno perché, come detto all’inizio dell’articolo, si tratta di un ambito poco conosciuto, in corso di studio. Tuttavia, anche se l’Italia non riconosce l’ omogenitorialità le coppie omosessuali come famiglia e non permette l’adozione a coppie che non siano coniugate, dobbiamo tenere in considerazione l’evidenza che, di fatto, in Italia vivono figli di omosessuali. Nel 2005, il 17.7% dei gay e il 20.5% delle lesbiche con più di 40 anni aveva almeno un figlio. In virtù dell’obiettivo primario che è sempre “il bene superiore del minore”, dei minori che ci sono oggi prima di quelli che eventualmente popoleranno il domani, è nostro dovere combattere il rischio di stigmatizzazione con tutti gli strumenti possibili. E potremmo farlo con il totale supporto delle coppie omosessuali che sono, più di noi, terrorizzate dall’idea che la discriminazione possa nuocere ai loro figli.
Nel 2014, il Tribunale dei Minori di Roma, acconsentendo alla [blockquote style=”1″]www.studiolegalecarsana.eu[/blockquote](Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender) tra due donne, ha lanciato sicuramente un primo messaggio positivo.
Per concludere le questioni sollevate dalla omogenitorialità, http://thekids.gabrielaherman.com/ è un interessante progetto di una fotografa di NY che ha scelto di incontrare persone cresciute con due madri, due padri o un solo genitore gay, e raccontare le loro storie:
[blockquote style=”1″]Forse è ora di chiederlo ai bambini. (The Kids)[/blockquote]