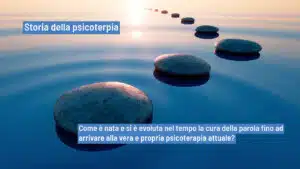Lettera di accompagnamento e conflitto di interesse
Si dichiara che il presente lavoro originale è inedito e l’Autore si impegna a cedere alla Rivista online “State of Mind” il copyright e i diritti in caso di accettazione del lavoro suddetto per la sua pubblicazione.
L’Autore dichiara inoltre di non avere conflitti di interesse riguardo alla paternità o alla pubblicazione di questo articolo.
Riassunto
Nella nostra prassi di terapeuti, la cosa a mio parere più importante è la vera comprensione del paziente, che non va mai data per scontata (data la sua intrinseca difficoltà) e che prelude ad una cura efficace. Comunque, l’intuizione aiuta a raggiungere tal fine. Per tendere al nucleo esplicativo dell’intuizione, ci può aiutare il considerare e l’integrare il pensiero Occidentale con quello Orientale. Le associazioni libere, l’attenzione liberamente fluttuante, ma anche le domande sistematiche del terapeuta possono aiutare a intuire e a comprendere il paziente. L’intuizione è un “ponte” che collega, almeno in parte, la Terapia a Seduta Singola (TSS) alla psicoanalisi. Per intuire bisogna “eclissare” temporaneamente il proprio Sé, diventando il paziente stesso, ma senza fondersi con lui. Durante la TSS, da un’intuizione scaturisce un’interpretazione precoce. Tale interpretazione va comunicata solo se il paziente è adatto e pronto a riceverla, come avviene nella maggior parte dei casi, dopo una breve preparazione preliminare del paziente stesso ad ascoltarla. Fatto ciò, di solito la loro reazione è positiva e produttiva, perchè nel primo incontro (che spesso è anche l’ultimo) il paziente è più aperto, bisognoso, motivato, data l’urgenza di ricevere qualsiasi intervento che lo faccia sentire meglio nel più breve tempo possibile. Forse, un’interpretazione intuitiva precoce differisce per qualità, potenza ed effetto da un’interpretazione più tardiva, dove magari giocano un ruolo maggiore i processi secondari del pensiero, oltre a quelli primari, del terapeuta. In sintesi, il terapeuta “regredisce” temporaneamente al suo puro inconscio intuitivo, più “istintivo”, più “animale”; poi ritorna repentinamente al proprio Sé, “partorendo” l’interpretazione precoce del caso clinico.
L’importanza di comprendere il paziente
È mia abitudine partire sempre dall’assunto che non si debba dare mai per scontata la vera comprensione del paziente, che è la cosa più importante. Noi moriamo senza comprendere noi stessi. Figuriamoci se possiamo presumere di comprendere veramente il paziente, anche usando l’intuizione. L’intuizione è certamente un’abilità che aiuta a tal fine, ma a volte capita che, nonostante ciò, non lo si riesca a comprendere per niente o solo in parte. Reik (psicologo, allievo e pupillo di Freud, purtroppo solo in parte tradotto in italiano) sosteneva che è meglio non comprendere affatto il paziente piuttosto che capirlo male, per danneggiarlo meno.
Molto interessante sulla comprensione è l’elaborazione antropologica (antropologia come sistema di interpretazione) del concetto di inconscio collettivo da parte di Levi-Strauss, nella sua introduzione al libro “Teoria generale della magia” di Mauss (1965), dove disserta sui rapporti tra soggettività, comprensione ed inconscio, quest’ultimo inteso come luogo di incontro tra osservatore e osservato, come un sistema simbolico collettivo. Tutto ciò che viene osservato fa parte dell’osservazione e, in una scienza in cui l’osservatore ha la stessa natura del suo oggetto, l’osservatore stesso è una parte della sua osservazione. Il soggetto è capace di oggettivarsi, senza giungere mai ad abolirsi come soggetto. Riferendosi all’apprendimento soggettivo tra etnografo e indigeno, scrive: “Questa difficoltà, dato che, per ipotesi, le soggettività sono incomparabili e incomunicabili, sarebbe insormontabile, se l’opposizione tra me e gli altri non potesse essere superata su un terreno che è anche quello su cui l’oggettivo e il soggettivo si incontrano, cioè a dire l’inconscio”. “L’inconscio sarebbe così il termine mediatore tra me e gli altri. Approfondendo i suoi dati, non ci prolunghiamo, se così si può dire, nel senso di noi stessi: raggiungiamo un piano, che non ci sembra estraneo, perché racchiude il nostro io più segreto, ma (molto più normalmente) perché, senza farci uscire da noi stessi, ci pone in coincidenza con forme di attività che sono, insieme, nostre e altrui, condizioni di tutte le vite mentali di tutti gli uomini e di tutti i tempi”. Ma occupiamoci ora dell’intuizione da un punto di vista qualitativo e della conseguente interpretazione precoce nel corso della TSS.
L’intuizione
Per tendere ad una maggiore comprensione del concetto di intuizione, ci può essere d’aiuto considerare e integrare il pensiero Occidentale con quello Orientale.
Jung (1993) afferma che chi intuisce carica anche l’oggetto intuito di un influsso inconscio. Non si possono infatti separare le forme epistemologiche (in questo caso partecipative) di comprensione dell’altro e di se stessi dalle forme conseguenti di terapia.
A mio parere, l’intuizione può essere considerata come una forma di intelligenza del preconscio e degli strati più superficiali dell’inconscio, un “pensare” del processo primario.
Gigerenzer (2009) afferma che un buon sistema “percettivo”, intuitivo, come anche l’intelligenza stessa, deve andare oltre l’informazione ricevuta e perciò oltre la logica. Deve saper collegare, saper connettere.
Winnicott (1995) sostiene che il pensiero logico richiede molto tempo e può non arrivare mai allo scopo di comprendere veramente il paziente, mentre il lampo dell’intuizione non richiede tempo e arriva al punto immediatamente.
Reik (Gherardi, 2019) dà importanza all’intuizione congetturale e alla successiva comprensione razionale del paziente, valorizzando la soggettività del terapeuta, la sua auto-osservazione interna e la sua “response” globale al paziente. Rifacendomi sempre a Reik (Gherardi, 2020), la naturale tendenza del paziente all’espressività e la spontanea controtendenza del terapeuta ad una sana curiosità, catalizzano un’accelerazione interattiva del processo comprensivo e terapeutico già durante il primo incontro.
Secondo me, l’intuizione può essere ricercata non solo con le associazioni libere e l’attenzione liberamente fluttuante, ma anche con la ricerca sistematica attiva del terapeuta, soprattutto attraverso lo strumento delle domande. La dinamica interattiva tra i due Attori, determinata anche dai numerosi cicli di domanda-risposta, sempre più mirati, può portare all’intuizione esplicativa del caso.
Per Berne (1992) la diagnosi è un processo configurativo (che riguarda l’aspetto, la forma). I processi diagnostici preliminari nei clinici esperti si basano sull’analisi di configurazioni subconsce, al di sotto del livello di coscienza, e non, come nei principianti, sulla sintesi consapevole (aggiuntiva) di mosaici di osservazioni.
Greenson (1960) correla e traccia, al tempo stesso, le differenze tra l’intuizione e l’empatia. Sia l’una che l’altra danno a una persona un talento per la psicoterapia e i terapisti migliori sembrano possederle entrambe. L’empatia è un “requisito di base”, mentre l’intuizione è un “extrabonus”.
La TSS si discosta molto da quanto avviene nel contesto psicoanalitico (Gherardi, 2023). Un’ipotetica convergenza parziale di questi due opposti apparenti potrebbe risiedere nell’utilizzo dello strumento intuitivo in entrambe le tecniche. L’intuizione è il “ponte” che collega, almeno parzialmente, la TSS con la psicoanalisi.
Vari psicoanalisti come Reik, Berne, Bion, ecc. hanno sottolineato l’importanza dell’uso dell’intuizione per cogliere la verità del paziente, ponendo l’intuizione al centro del trattamento psicoanalitico.
Anche i cognitivisti si occupano da tempo dei processi cognitivi duali, intuitivi e logico-analitici e le ricerche neuro-psicoanalitiche di Schore (2022) dimostrano che l’emisfero destro (sede biologica dell’inconscio anche relazionale, degli affetti, dell’intuizione terapeutica, della creatività), si allinea, si sintonizza intuitivamente, si sincronizza, entra in risonanza con l’emisfero destro del paziente durante la seduta. Tale fenomeno viene facilitato anche dalla minore inibizione di tale emisfero da parte di quello sinistro (più cognitivo, analitico e verbale), in entrambi gli Attori.
Questo meccanismo neurobiologico potrebbe, a mio parere, facilitare l’ ”eclissi” temporanea del nostro Sè, che crea inferenze sull’intuizione dell’altro.
Schore (2022) sostiene che ciò permetterebbe di liberare gli idiomi (cioè le particolarità) personali dell’essere e del relazionarsi e, quindi, solo con l’intuizione i clinici possono entrare veramente in sintonia con l’unicità dell’individuo, del momento e della “chimica” della specifica diade terapeuta-paziente.
Intuizione e “non-Io”
Il poeta tedesco Rueckert ha scritto: “Quando l’amore nasce, muore il Sé, l’oscuro tiranno”. Tale sorta di “morte”, di “eclissi” temporanea del Sé del terapeuta lo fa “diventare” temporaneamente il paziente, con una immedesimazione “unipatica”, partecipativa. Partecipare significa diventare uno con un’attività, con un coinvolgimento totale. Si diventa uno con l’esperienza, dimenticando completamente se stessi. Si concentra completamente l’attenzione sull’attività, ignorando le distrazioni (apparentemente, sembra esattamente il contrario dell’attenzione liberamente fluttuante di Freud).
Nishida (2001) afferma che il filosofo nega la coscienza che fonda se stessa nello scindersi del mondo. Dogen (un importante pensatore buddhista giapponese del XIII secolo) afferma: “Imparare il Sé è dimenticare il Sé. Dimenticare il Sé è essere risvegliati da tutte le cose”. Noi cogliamo il vero Sé laddove neghiamo il Sé astratto-cosciente e diventiamo uno, corpo e mente. Così scompare il soggetto nella prassi filosofica: “Si supera l’ego cosciente e si pensano i fatti, diventando i fatti che si stanno pensando”. L’intuizione attiva è quindi un “vedere diventando le cose, agire diventando le cose”. Questa idea si può far risalire alla dottrina buddhista del muga (“non-Io”) secondo la quale l’Io è illusorio e la saggezza coincide con la caduta dell’illusione di essere un Io, cioè di possedere un’esistenza indipendente dal mondo interrelato (fine dell’Io).
Lao-tsu (2004), nel suo libro del Tao, concepisce l’intuizione come una forma di intelligenza, complementare alla ragione. L’uomo saggio sa che deve svuotarsi del proprio Io (perdita di Sé) per essere specchio dell’universo.
Trentini (2008) sostiene che i bias egocentrici determinano inferenze inappropriate, per cui bisogna imparare a modulare gli effetti inferenziali indotti dalla prospettiva egocentrica nelle interazioni con gli altri.
Grotstein (2004), che concepisce l’intuizione come una coscienza inconscia, cita le due tecniche epistemologiche di Bion: quella cartesiana (dove c’è una separazione tra soggetto e oggetto) e quella dove il soggetto “diventa” l’oggetto, ma senza fondersi con lui.
Stitzman (2004) concepisce l’intuizione come un potente strumento della fede (che presuppone l’esistenza di una verità), un “senso analitico”. Lo Zen parla di uno stato mentale denominato “Satori”, a cui è associato un particolare senso, il “Prajna”, che potrebbe essere considerato l’intuizione stessa e, quindi, lo stato psicoanalitico per eccellenza. Un’esperienza comprensibile direttamente. “Satori” potrebbe essere lo stato mentale dove, attraverso il “Prajna”, si può conoscere gli oggetti senza conoscerli, ma attraverso l’essere un tutt’uno con loro, all’unisono. Dobbiamo rinunciare a tutta la sicurezza che noi abbiamo in quanto soggetti, tollerando tale frustrazione, per essere in comunicazione diretta con il contenuto del paziente (essere sola fede). La verità del paziente ci arriva così come una sorpresa, una rivelazione, in quanto siamo all’unisono con lui e l’intuizione ci permette di vedere il paziente per quello che è veramente, senza il bisogno di ciò che deriva dai fatti percepiti dal nostro apparato sensoriale.
Interpretazione precoce
Da quanto mi risulta, non c’è una letteratura scientifica sull’interpretazione precoce nella TSS. Personalmente, mi sono già inizialmente occupato dell’importanza di tale interpretazione, che scaturisce nel corso della TSS grazie ad un’intuizione del terapeuta (Gherardi, 2019). L’interpretazione è al centro del processo di cambiamento terapeutico (cogliendo il significato latente delle comunicazioni del paziente e rendendo conscio il suo inconscio). Può essere un punto di forza della TSS quando il paziente è pronto e disponibile a tale tipo di intervento precoce, un punto di debolezza quando è il contrario perché, in tali casi, anche se intuisci tempestivamente il nocciolo del problema, ti accorgi che non glielo puoi interpretare subito e lo devi tenere dentro di te come congettura, senza una possibilità di verifica immediata col paziente, per non danneggiare né lui né il rapporto terapeutico. Nella mia prassi clinica, quando ho un’intuizione durante la TSS (di solito mi capita in 3 pazienti su 10), a volte mi rendo conto che non posso interpretare immediatamente e quindi mi astengo. In tutti gli altri casi, chiedo prima al paziente se si sente di ascoltare la mia interpretazione precoce e ricevo, nella maggioranza dei casi, un parere favorevole, un permesso da parte loro. In pratica, un po’ li prepari per non essere brusco e “traumatico” e loro mostrano di solito una curiosità ed un coraggio a sentirsi dire cosa il terapeuta ha così velocemente e profondamente compreso di loro. Nella TSS, sono infatti aperti, bisognosi, motivati e sentono l’urgenza di essere alleviati al più presto dalle loro sofferenze. Dopo l’interpretazione, si possono mostrare a volte sorpresi, ma in realtà non lo sono, perché, con la tua interpretazione, hai come sfondato una porta aperta. Spesso sono d’accordo con le tue ipotesi, ma, ogni tanto, giustamente, le mettono parzialmente in discussione o sono in totale disaccordo. Possono quindi manifestare resistenze al trattamento, ma può anche essere che la tua interpretazione sia non centrata o sbagliata completamente.
Tra comprensione e cura
Forse, comprendere veramente noi stessi e gli altri è un’utopia, anche se, in teoria, dovremmo essere noi gli specialisti di tale comprensione e della cura conseguente. La nostra intuizione inconscia usa sempre un’intelligenza ed un linguaggio simbolico, ma, a differenza del conscio, i simboli che mette in collegamento sono più distanti e meno facilmente collegabili tra loro. Il “salto” simbolico, associativo, è più lungo e di più difficile comprensione rispetto alle situazioni più comuni. Usando la metafora del ponte, tale ponte ha una sola arcata o ha, in tutti i casi, meno arcate di un ponte comune (pensiero conscio). L’interpretazione precoce scaturisce direttamente dall’intuizione nel corso della TSS. La qualità e forse anche la potenza e l’effetto di tale interpretazione si distinguono da un’interpretazione più tardiva, magari raggiunta con un mix di processo primario e secondario del pensiero, oppure solo con l’utilizzo del processo secondario. L’interpretazione precoce della TSS è appunto intuitiva, più “impulsiva”, “istintiva”, “animale”. Quindi, ha una genesi, un “parto” ed un effetto diversi da altri tipi di interpretazione. In sintesi, l’intuizione è un processo primario, una forma di conoscenza dell’altro (e di noi stessi in rapporto con l’altro) che avviene direttamente, tramite una “percezione” inconscia dell’inconscio del paziente e del nostro, dopo che è stato influenzato dal suo. Tale “percezione” pragmatica dell’oggetto è già potenza in atto, un atto terapeutico. Il terapeuta, per riuscire in ciò, più che utilizzare uno split, una dissociazione fisiologica del proprio Io per affinare le proprie abilità introspettive per la comprensione del paziente, deve “eclissare” temporaneamente tutto il proprio Sé, ritornando puro inconscio, che contiene ancora attivo il suo intuito animale residuato dal passato (come sostiene anche Reik). Con tale strumento arcaico, ma potente e preciso, il terapeuta comprende e cura, tornando repentinamente al proprio Sé da cui è partito, comunicando al paziente con processi cognitivi secondari quell’interpretazione intuitiva precoce, esplicativa e curativa del caso.