
Il film racconta la storia di Yvon, un operaio che subisce un’ingiustizia; da vittima diventa prima un ladro e poi un crudele assassino. All’inizio di tutto è l’odiosa insensibilità di due genitori nei confronti del figlio adolescente cui rifiutano di dare del denaro in più per ripagare un piccolo debito contratto con un compagno di scuola (in una scena velocissima, ma in cui Bresson riesce a descrivere complesse dinamiche relazionali). Il ragazzo allora chiede aiuto a un amico. Questi lo induce a spacciare assieme a lui una banconota falsa da 500 franchi. Il negoziante che la riceve la rifila a Yvon con l’aggiunta di altre due. Quando Yvon prova innocentemente a pagare un conto al ristorante con le banconote, viene denunciato e poi condannato. Invece di scagionarlo, infatti, l’impiegato del negozio testimonia il falso e conferma l’accusa. Passando di mano in mano, in chi lo riceve a turno il biglietto è dunque ogni volta l’occasione di un’amara scoperta. Si generano così le tensioni che imprimono alla storia i suoi primi scatti narrativi.
Il denaro mette a nudo le pulsioni più inconfessabili. Mogli e mariti che si dilaniano in tribunale per spartirsi i beni, fratelli che si odiano per l’eredità, amicizie che naufragano su litigi da pochi spiccioli: questo lo vediamo tutti i giorni. Attribuiamo al denaro un potere diabolico. Tuttavia, enfatizzarne il ruolo nel film sarebbe fuorviante. Come nei romanzi di Balzac il denaro qui è solo il reagente che l’autore usa per indagare la natura più intima dei rapporti umani. Visti nelle loro sfumature più tenui, essi svelano una trama meccanica, arida, automatica. Nel suo laboratorio di visioni Bresson scopre che ognuno è irrimediabilmente solo e al tempo stesso intrappolato in una rete simbolica (sociale). La chiave del film, ammesso che ce ne sia una, non è tanto nel racconto di Tolstoj, Denaro falso, cui si ispira direttamente, quanto piuttosto in un altro racconto dello scrittore russo La morte di Ivan Il’ič.
La solitudine, l’odio e la violenza, sembra dirci Bresson, sono alimentati da una generale mancanza di empatia, comprensione e accettazione dell’altro. È ineluttabile che le relazioni umane siano così? Sono tutte così? Sì e no. Forse è solo questione di soglie critiche. L’unica cosa che può fare da freno all’odio è ovviamente l’amore. Sull’amore primario dei genitori per i figli e viceversa si basa secondo Freud (1895) il fondamento dell’etica. Siccome per diventare adulto il bambino dipende così a lungo dai genitori e all’inizio si trova in uno stato di assoluta impotenza (Hilflosigkeit), ecco che questo vincolo, quando le cose vanno bene, si trasforma nella legge interiore che gli permetterà di essere a sua volta capace di amore, compassione e giustizia. Bisogna capire però il significato psicologico dell’odio e il perché della sua necessità.
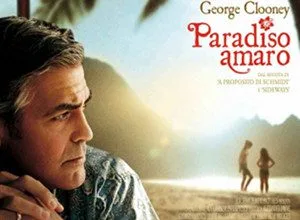
LEGGI ANCHE: ARTICOLI SULL’ATTACCAMENTO
L’oggetto nasce nell’odio, scrive Freud. L’odio è il primo e anche l’ultimo dei sentimenti: “Avevo poco calore in me. Poca carne mi era rimasta attaccata alle ossa. Questa carne bastava solo per provare rabbia, l’ultimo dei sentimenti umani. Non era l’indifferenza, ma la rabbia l’ultimo sentimento umano, quello più vicino alle ossa”: è la voce dell’io narrante de I racconti della Kolyma, di Varlam Salamov (1991, p. 285), lo scrittore che Solgenitzin ha eletto a suo maestro, e splendido autore della memorialistica sui lager di Stato in Russia. Che la rabbia sia l’ultimo e il più tenace dei sentimenti umani, quello che rimane quando tutti gli altri si sono spenti, si potrebbe dire anche per Yvon. Alla fine la sua non è che cieca rabbia. Ma se è l’ultimo sentimento a restare, vuol dire che la rabbia è l’estremo baluardo psicologico per tenersi in vita. Come la sete segnala il bisogno d’acqua, così la rabbia segnala il bisogno di riconoscimento e insieme cerca di ottenerlo. Purtroppo, a volte ciò avviene in modo sbagliato o addirittura tragico.
Così ho inteso una brillante intuizione di Peter Fonagy (2001), secondo cui certi gesti estremi di violenza hanno il fine di far superare un senso di vergogna intollerabile ridando per un attimo alla persona la capacità di agire e di farsi vedere da tutti. Così accade alla fine del film. In quest’ottica, tre momenti sono particolarmente significativi. In tutti i casi Yvon è sotto gli occhi di tutti e si vergogna: quando viene giudicato in tribunale; alla mensa del carcere, quando, dopo essere stato abbandonato dalla moglie, si chiede “Perché tutti mi guardano?”; e poi al bar dove si consegna alla polizia (significativamente, in questa scena Yvon si vede anche riflesso in uno specchio; vd. Civitarese 2012). L’ultima situazione però è la sola in cui non subisce passivamente l’azione ma ne è l’agente. Alla fine si capisce che il movente dei suoi delitti, e di quelli degli altri, non è il denaro. Neppure sarebbe primario il desiderio “privato” di vendicare l’ingiustizia subita, ma il bisogno di riequilibrare la bilancia del proprio narcisismo; di riguadagnare la stima degli altri, fosse pure commettendo un crimine. Sappiamo per esempio che a volte chi ha sofferto un’offesa non vorrebbe affatto vendicarsi, ma lo fa perché glielo impone il sistema socio-culturale in cui vive.
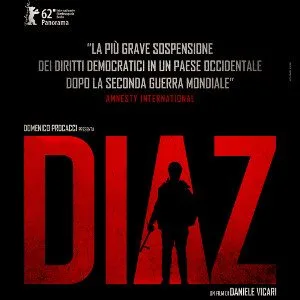
Veniamo ora allo stile. Risalta nel film il ricorrere di alcune figure retoriche: metonimia, iperbole ed ellissi. Passiamole in rassegna rapidamente nell’ordine.
Le inquadrature non riguardano mai primi piani, ma spezzano lo spazio e frammentano il corpo, restituendoci visioni di oggetti e gambe, o mani. Esse segnalano così che tra le persone c’è una prossimità che è “metonimica” in quanto materiale/fisica, ma che esprime invece una distanza affettiva/psicologica. Poi, il biglietto che passa di mano in mano, per contatto, e che in tal modo metaforizza il contagio psichico (che intenderei sia come partecipazione di ciascuno alla mente del gruppo sia, in senso negativo, come trasmissione di una malattia, in questo caso della falsità morale). Ancora, il sangue sulle mani di Yvon è l’unico indizio che ci racconta l’uccisione degli albergatori. Infine, quando il padre della vedova che lo accoglie in casa suona al pianoforte la Fantasia cromatica di Bach, il bicchiere che si infrange a terra prefigura l’esplosione finale di violenza e la definitiva crisi psichica del protagonista.
L’iperbole si presenta invece nella vertiginosa intensificazione drammatica che caratterizza la serie delle azioni criminali: lo spaccio della banconota falsa, poi di tre banconote false, la falsa testimonianza, la rapina, l’omicidio, il massacro (che è già di persé un’iperbole). Il denaro in questione, poi, già per definizione simbolo del negativo, essendo anche concretamente falso, lo è due volte, è iper-falso.
Lo stile sobrio, giansenista, di Bresson, che tanto apprezziamo in Quattro notti di un sognatore, o nel Processo di Giovanna D’Arco, qui si fa ancora più scarno, austero, freddo. Lo sguardo che egli porta sugli uomini e sulle cose è quanto mai concentrato, preciso, realistico, severo, nudo, secco, gelido. Bresson tende ad astrarre, a semplificare per formulare dei concetti generali. Per esempio, in trasparenza possiamo leggere che il suicidio è una forma di omicidio, che ubbidisce cioè allo stesso bisogno di farsi “vedere”; poi, che sotto il sottile strato di civiltà c’è la natura e le sue pulsioni primitive: l’epilogo si svolge infatti in campagna; infine un’altra generalizzazione sta forse nel fatto che in L’argent non ci sono tanto singoli personaggi o un vero protagonista ma l’umanità in se stessa. Infatti nella prima parte il film è apertamente corale, perché intreccia più storie, ma resta tale anche quando viene in primo piano la storia di Yvon. Per così dire “così fanno o sono tutti”.

È il cinema, come è stato definito, del dépouillement, dell’ascesi. Ma qui, in L’argent, lo stile svolge una funzione più centrale che negli altri film perché serve ad attirare l’attenzione sull’impoverimento emotivo e psicologico di tutti i personaggi.
È impossibile empatizzare con questi personaggi. Per quanto buona volontà ci si voglia mettere, non ci riusciamo. Io non ci riesco. Il film mette in scena emozioni, ma non le fa provare o, meglio, fa provare fastidiosamente la loro assenza. I personaggi sono “stilizzati”, dei manichini, non hanno vero spessore, mancano di una vera interiorità. Neppure la terribile storia di Yvon riesce a coinvolgere. È insensata, non perché non abbia un senso ma perché questo senso è tutto cerebrale e nello spettatore non è mediato da una vera identificazione.
Questo però è interessante. Mai come in questo film la poetica di Bresson è un poetica dell’ellisse, di ciò che viene tolto, che manca, che non si vede. Una poetica che qui si fa essa stessa iperbolica perché non è più solo un modo dell’espressione, tra i tanti possibili, improntato a rigore, essenzialità e intensità, cosa presente in tutti i suoi film. La mancanza di una colonna sonora rende lo sguardo più acuto. È chiaro, come ho già detto, che lo stile scarno, geometrico, purista implica una ricerca di astrazione e di verità (per definizione la verità è essenziale), ma il fatto è che qui alla fine resta solo la verità dello stile. Che idea farcene? Moravia, che come sappiamo, amava enormemente il cinema, ha scritto in proposito un commento affilato: “Bresson vede ‘il bene’ nel sostrato Attico della civiltà francese, cioè nella tradizionale mescolanza di rigore, moderazione e razionalismo, il segno distintivo del genio nazionale. In altre parole, ‘il bene’ sarebbe lo ‘stile’. Ciò porta alla curiosa conclusione che il male esiste nella vita, e il bene nel modo in cui è rappresentata. La vera ascia, macchiata di sangue, con cui l’assassino fa fuori le sue vittime è un oggetto funesto; ma l’immagine dell’ascia è in qualche modo benefica. In breve, lo stile esorcizza il male” (1998, p. 408, trad. dell’autore).
È vero: se pensiamo alla letteratura francese in generale e specialmente a quella del ‘700, alle Le relazioni pericolose di Chorldelos de Laclos, oppure a La principessa di Clèves di Madame de La Fayette, cioè a come questi autori scavano impietosamente nei sentimenti umani, non facciamo fatica a trovare un’aria di famiglia con i personaggi del film, che si muovono come delle pedine sulla scacchiera di un gioco dalle regole inesorabili.
Bresson procede per via di levare. Riduce a un terzo i personaggi di Tolstoj. Poi, soprattutto, elimina la parte del racconto dove si descrive la redenzione del protagonista e imbastisce una storia cupa, disperata (e disperante). Ma non smette di credere nello stile. Al solito, però, stile è sostanza dell’espressione. Questa “sostanza” si può formulare in questi termini: non si dà nessuna redenzione se non nell’arte. Ma che cos’è l’arte? Rispetto a Moravia, da analisti, possiamo fare un passo in più. Scrive Bion (1992, p. 152): Il “leader intellettuale [e intende: l’artista] è un individuo che è in grado di digerire i fatti, cioè i dati sensoriali e poi di presentare i fatti indigeriti in un modo che renda possibile a quelli che sono più deboli nell’assimilare di andare avanti da quel punto. Quindi l’artista aiuta il non-artista a digerire, per esempio, la Viuzza di Delfi [Vermeer] facendo del lavoro sulle proprie impressioni sensoriali e poi ‘pubblicando’ il risultato, cosicché altri, che non erano in grado di ‘sognare’ la Viuzza stessa, possono ora digerire il lavoro pubblicato di qualcuno che era in grado di digerirla”.
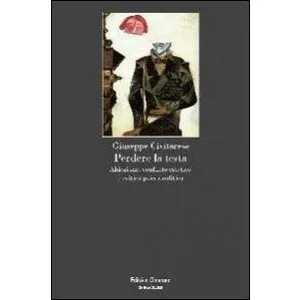
Non è lo stile in sé come estetismo che redime, ma lo stile in quanto espressione della partecipazione autentica dell’autore a una certa esperienza emotiva universale e della sua capacità, attraverso la sua opera, di diventare – come si dice nell’Iliade – il “seno che fa scordare le angosce”, cioè che trasforma il male (la traumaticità del reale) in significato e in questo modo lo trascende. Si capisce che il diavolo (il denaro), come racconta l’etimologia (διαβάλλω: «gettare attraverso»), è il contrario della capacità di costruire simboli. Iperbole ed ellissi sono così i corrispettivi di un’oscillazione tra pieno e vuoto o, meglio, tra un troppo pieno e un troppo vuoto della presenza emotiva dell’Altro. La metonimia esprime una prossimità fisica ma non necessariamente psicologica. Che cosa se non la descrizione di come una relazione affettiva può fallire e condurre invece alla violenza? Un seno c’è ma è svuotato. Un genitore c’è ma è emotivamente assente; chiude la porta, come succede nella prima scena e poi a ripetizione nel seguito del film. Oppure c’è ma è troppo preso dal bisogno di coltivare un’immagine idealizzata di sé nel proprio ruolo di genitore, e allora è come se non ci fosse.
In conclusione, L’argent è un film che fa riflettere sulle distorsioni nei legami d’amore che portano alla dissociazione tra corpo e mente, tra emozione e ragione. Ci fa vedere come si producono e ci dà un’idea di come si possono curare. La soluzione che indica nella sua stessa natura di opera d’arte – e non è detto che ci riesca! questo attiene al giudizio degli spettatori – è nel ricomporre questa dissociazione nello stile della narrazione, nell’esperienza estetica cui tende sempre il sognare se lo intendiamo come una specie di funzione poetica della mente.
BIBLIOGRAFIA:
- Bion, W.R., (1992). Cogitations, Armando, Roma 1996.
- Civitarese, G., (2012).Perdere la testa. Abiezione, conflitto estetico e critica psicoanalitica. Clinamen, Firenze 2012.
- Fonagy, P., (2001). The roots of violence in the failure of mentalization. Lavoro letto al Centro Milanese di Psicoanalisi, 18-5-2001.
- Freud, S., (1895). Progetto di una psicologia. Opere, vol. 2, Boringhieri, Torino.
- Moravia, A., (1998). L’Argent. In J Quandt, a cura di, Robert Bresson, Cinematheque Ontario Monographs. Toronto, pp. 407-408.
- Salamov, V., (1991). I racconti della Kolyma. Adelphi, Milano 1995.
VISUALIZZA IL PROFILO DELL’AUTORE – VISITA IL SITO WEB DELL’AUTORE

