Psicopatia, PTSD e genesi di condotte antisociali.
Psicopatia, comportamento criminale ed esperienze traumatiche. Rischio e recidiva.
 In occasione della prima conferenza della Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (SISST), tenutasi il 19 Novembre presso l’Università Cattolica di Milano e di cui si è parlato nell’articolo “Violenza sulle donne: dinamiche di vittimizzazione”, uno dei workshop pomeridiani, tenuto da Vittoria Ardino, Vincenzo Caretti e Caterina Zaiontz, ha riguardato le sindromi post-traumatiche e dell’adattamento in contesti forensi.
In occasione della prima conferenza della Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (SISST), tenutasi il 19 Novembre presso l’Università Cattolica di Milano e di cui si è parlato nell’articolo “Violenza sulle donne: dinamiche di vittimizzazione”, uno dei workshop pomeridiani, tenuto da Vittoria Ardino, Vincenzo Caretti e Caterina Zaiontz, ha riguardato le sindromi post-traumatiche e dell’adattamento in contesti forensi.
Il lavoro dei tre relatori ha evidenziato come le sindromi post-traumatiche possano costituire un importante fattore di rischio per il comportamento criminale e una barriera per la riabilitazione degli autori di reato e come il ciclo trauma-disturbi dell’adattamento (incluso l’adattamento al contesto carcerario) sia un elemento fondamentale nel mantenimento della recidiva. Vorrei qui soffermarmi su uno degli aspetti emersi da questo interessante workshop: il ruolo delle esperienze traumatiche nello sviluppo di “carriere” criminali con particolare attenzione alla discussa diagnosi di psicopatia.
La psicopatia è un disturbo deviante dello sviluppo. Se lo sviluppo è un processo dinamico, frutto di traiettorie diverse, complessità di incontri tra fattori di rischio e fattori di protezione, la psicopatia è un processo verso la perdita definitiva del sentimento umano, del sentimento di essere nel mondo degli umani.
Le persone che commettono atti antisociali non sono necessariamente psicopatiche, così come è sbagliata l’idea che tutti gli psicopatici siano dei folli assassini. Certamente gli psicopatici hanno gravi impulsi antisociali ai quali danno corso non curandosi delle conseguenze delle loro azioni e molti dei serial killer che affollano le cronache nere possono a pieno titolo essere annoverati in questa categoria. La maggior parte degli psicopatici, tuttavia, appare al mondo come un modello di normalità: sono molto abili a mascherare il loro mondo interiore ed a costruirsi una vita all’apparenza felice e bene adattata. Non è detto che queste persone commettano delitti o reati efferati: la maggior parte di loro conduce un’esistenza al di fuori dei circuiti penali, ma riuscendo a stabilire solo rapporti di sfruttamento e manipolazione, mancando completamente di principi morali.
Sono predatori intraspecie, sfruttano chi li circonda, approfittando dei punti deboli delle persone per manipolarle a proprio vantaggio. Le altre persone sono viste come oggetti. Sono incapaci di mettersi nei panni degli altri, così come un serpente è incapace di immedesimarsi nelle proprie prede. A differenza del disturbo antisociale di personalità, ciò che caratterizza la psicopatia è la presenza di freddezza emotiva, un vero e proprio deficit affettivo ed interpersonale, insieme a comportamenti manipolatori, predatori, malvagi e violenti. Anche gli antisociali sono manipolativi, tuttavia sono impulsivi in maniera evidente, con frequenti acting out e aggressività manifesta.
Gli psicopatici trattengono gli impulsi, li congelano e li mettono in atto al momento opportuno. Hanno una forte propensione alla noia e bisogno di stimoli sempre più forti, elemento che può diventare una forte motivazione a commettere delitti. Alcuni studi di neuroimaging, riportati da Vincenzo Caretti, rilevano in questi soggetti un deficit nel cervello “morale”: insensibilità di fronte al dolore altrui, ridotta attivazione del sistema limbico, dell’amigdala, e della corteccia orbitale (coinvolta nel ragionamento etico).
Cleckley (1941) descrive gli psicopatici come persone incapaci di provare senso di colpa, egocentriche, con un estremo senso della propria importanza, incapaci di autentico affetto, in cui è assente il rimorso, che mancano di introspezione psicologica e incapaci di apprendere dall’esperienza. Dotati di fascino superficiale e bravi parlatori, utilizzano questa loro capacità per manipolare l’interlocutore, sfruttando per questo scopo la loro capacità di leggere perfettamente gli stati mentali altrui. Manca loro, invece, la capacità di mentalizzare i propri stati emotivi e non presentano segni di sofferenza psichica: nel racconto di violenze subite, spesso presenti nelle loro storie di vita, c’è una totale assenza di emozioni. Proprio per questa ragione, a differenza di persone con disturbo antisociale di personalità, sono insensibili alle punizioni e di questo è necessario tenere conto negli eventuali programmi di trattamento.
Tuttavia sono estremamente vulnerabili all’umiliazione, tanto che i picchi di violenza, utilizzata come estrema strategia di gestione, si registrano proprio nei momenti in cui questi soggetti sperimentano maggiormente tale emozione.
Che relazione ha tutto questo con il trauma?
Il primo dato importante riportato da Vittoria Ardino nella sua relazione è che l’esposizione precoce a traumi familiari o di comunità sono correlati positivamente con un maggiore rischio di comportamenti criminali. Il secondo dato importante è che gli autori di reato hanno più elevati livelli di Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD) e che il comportamento criminale è correlato con la gravità del PTSD (nelle popolazioni forensi la percentuale di PTSD è molto maggiore rispetto alla popolazione generale). Tuttavia i meccanismi specifici sono poco esplorati in letteratura.
Ci sono fattori ed esperienze che determinano queste traiettorie fin dall’infanzia, dando origine alla “carriera” criminale: comportamenti antisociali nell’infanzia, devianza nell’adolescenza e comportamenti criminali nell’età adulta. Non ci sono individui predisposti naturalmente all’antisocialità, ma esistono alcune circostanze che rendono gli individui più vulnerabili ad essa. Il trauma è un importante fattore che aumenta questa vulnerabilità. Il costante stato di allarme e le aspettative di maltrattamento tipiche del PTSD complesso generano una sregolazione emotiva, in particolare della rabbia: a fronte di ciò la strategia di coping preferenziale è la messa in atto di comportamenti violenti per proteggersi, acquisire un certo controllo sulla situazione ed uscire dal ruolo di vittima.
Questi meccanismi sono aspetti fondamentali nella genesi delle condotte antisociali. Diversi studi mostrano come gli offender, rispetto alla popolazione generale, abbiano alti livelli di rabbia, impulsività, traumi e dissociazioni (esperienze frequenti nel PTSD complesso). Gli psicopatici, in particolare, rispetto ad altri offenders, hanno traumi più frequenti, traumi infantili più precoci e maggiori esperienze dissociative. L’insensibilità al dolore dello psicopatico ricorda il congelamento dovuto all’attivazione del nucleo vagale-dorsale di cui parla Porges (2001) nella sua analisi del sistema di difesa.
L’umiliazione, legata alla vergogna, è un’emozione che caratterizza fortemente il vissuto di chi ha subito un trauma.
Sembra, dunque, che il trauma ed i disturbi ad esso correlati siano un ambito di indagine clinica e di ricerca davvero importante per una migliore comprensione del comportamento criminale e per una strategia efficace di trattamento, riabilitazione degli autori di reato e prevenzione della recidiva. In particolare, per quanto riguarda gli psicopatici, è opportuno tenere conto della maggiore gravità delle storie traumatiche che caratterizzano il loro sviluppo e degli specifici meccanismi coinvolti, con particolare attenzione all’insensibilità al dolore, e dunque alle punizioni, ed ai vissuti di umiliazione che possono condurre ad un drammatico inasprimento della violenza.
BIBLIOGRAFIA:
- Cleckley, H. The mask of sanity. Emily S. Cleckley, Augusta, GA, 1941
-
Hare, R.D. La psicopatia. Valutazione diagnostica e ricerca empirica. Astrolabio, Roma, 2009
-
Porges SW. The polyvagal theory: phylogenetic substrates of a social nervous system. Int J Psychophysiol 2001; 42:123–146.
-
Simon, R.I. I buoni lo sognano, i cattivi lo fanno. Raffaello Cortina Editore, Milano, 1997
CLICCA QUI PER SEGNALARE UN PROBLEMA CON QUESTO SITO. UN IDEA PER MIGLIORARLO. PORRE UNA DOMANDA ALLA REDAZIONE. AVANZARE UNA CRITICA O UN CONSIGLIO
 Una recente ricerca condotta dalla Dott.ssa Robinson , collega impotenza e disfunzioni erettili alla troppa “attività” virtuale. Immagini erotiche, filmati, foto, sesso online renderebbero notevolmente inferiore la qualità del sesso “reale”: quando si dice il troppo stroppia.
Una recente ricerca condotta dalla Dott.ssa Robinson , collega impotenza e disfunzioni erettili alla troppa “attività” virtuale. Immagini erotiche, filmati, foto, sesso online renderebbero notevolmente inferiore la qualità del sesso “reale”: quando si dice il troppo stroppia.


 Perchè alcune persone riconoscono facilmente volti già visti e altre fanno più fatica o addirittura falliscono del tutto?
Perchè alcune persone riconoscono facilmente volti già visti e altre fanno più fatica o addirittura falliscono del tutto? Nei precedenti articoli pubblicati su State of Mind e intitolati
Nei precedenti articoli pubblicati su State of Mind e intitolati 

 Il fumo nuoce gravemente alla salute. Il fumo produce danni a te e a chi ti sta intorno e, ancora di più, al tuo bambino. Tutte informazioni ben note ai fumatori e le notizie delle ultime ricerche non sono certo incoraggianti. Anzi, secondo un recente studio pubblicato sul Journal of Human Capital, il fumo in gravidanza provocherebbe dei danni allo sviluppo neurologico del neonato ancora più importanti di quanto già si pensasse: il fumo, infatti, provocherebbe un rischio del 40% maggiore di incorrere in problemi dello sviluppo in bambini dai 3 ai 24 mesi dopo la nascita rispetto ai figli di madri che non fumano. Si tratta di risultati di uno dei più vasti studi in questo settore: 1600 diadi madre-bambino sono state selezionate in Argentina, Brasile e Cile. Dopo avere valutato le abitudini al fumo delle madri, i bambini sono stati sottoposti a test neuro-cognitivi e a valutazione delle abilità di comunicazione. A un anno, i bambini di madri che avevano fatto uso di sigarette in gravidanza mostravano punteggi significativamente minori a tutti i test. Data la numerosità del campione, è stato possibile osservare che questi dati rimangono validi anche a prescindere da altre variabili, come il concomitante uso di alcool o lo status socio-economico.
Il fumo nuoce gravemente alla salute. Il fumo produce danni a te e a chi ti sta intorno e, ancora di più, al tuo bambino. Tutte informazioni ben note ai fumatori e le notizie delle ultime ricerche non sono certo incoraggianti. Anzi, secondo un recente studio pubblicato sul Journal of Human Capital, il fumo in gravidanza provocherebbe dei danni allo sviluppo neurologico del neonato ancora più importanti di quanto già si pensasse: il fumo, infatti, provocherebbe un rischio del 40% maggiore di incorrere in problemi dello sviluppo in bambini dai 3 ai 24 mesi dopo la nascita rispetto ai figli di madri che non fumano. Si tratta di risultati di uno dei più vasti studi in questo settore: 1600 diadi madre-bambino sono state selezionate in Argentina, Brasile e Cile. Dopo avere valutato le abitudini al fumo delle madri, i bambini sono stati sottoposti a test neuro-cognitivi e a valutazione delle abilità di comunicazione. A un anno, i bambini di madri che avevano fatto uso di sigarette in gravidanza mostravano punteggi significativamente minori a tutti i test. Data la numerosità del campione, è stato possibile osservare che questi dati rimangono validi anche a prescindere da altre variabili, come il concomitante uso di alcool o lo status socio-economico. Robin Dunbar dopo aver indagato sul numero di amicizie che un individuo può tenere a mente, 150 appunto, continua chiedendosi in che modo sia possibile raggiungere questo scopo. Il primo aspetto preso in considerazione dall’antropologo è il tatto, il senso che più ci lega agli altri ed esprime meglio ciò che proviamo per loro. Anche nel mondo animale le effusioni tattili sono importanti, ad esempio tra le scimmie esiste la pratica del grooming una sorta di spulciamento, che oltre a togliere pulci o sporcizia, serve da vero e proprio massaggio.
Robin Dunbar dopo aver indagato sul numero di amicizie che un individuo può tenere a mente, 150 appunto, continua chiedendosi in che modo sia possibile raggiungere questo scopo. Il primo aspetto preso in considerazione dall’antropologo è il tatto, il senso che più ci lega agli altri ed esprime meglio ciò che proviamo per loro. Anche nel mondo animale le effusioni tattili sono importanti, ad esempio tra le scimmie esiste la pratica del grooming una sorta di spulciamento, che oltre a togliere pulci o sporcizia, serve da vero e proprio massaggio.
 Nella parte 1 e parte 2 della serie abbiamo visto che uno dei fattori predisponenti all’aggressività del bambino è lo stile genitoriale. Genitori che reagiscono alla rabbia dei figli con altrettanta rabbia e aggressività o che usano la minaccia e toni di voce molto elevati hanno possibilità marcatamente maggiori di avere figli aggressivi rispetto a genitori che utilizzano, invece, strategie positive (Weiss et al., 1992). Anche la sola aggressione verbale è associata allo sviluppo di comportamenti aggressivi nei bambini, così come la delinquenza e i problemi interpersonali dall’età pre-scolare fino all’adolescenza (Vissing et al., 1991).
Nella parte 1 e parte 2 della serie abbiamo visto che uno dei fattori predisponenti all’aggressività del bambino è lo stile genitoriale. Genitori che reagiscono alla rabbia dei figli con altrettanta rabbia e aggressività o che usano la minaccia e toni di voce molto elevati hanno possibilità marcatamente maggiori di avere figli aggressivi rispetto a genitori che utilizzano, invece, strategie positive (Weiss et al., 1992). Anche la sola aggressione verbale è associata allo sviluppo di comportamenti aggressivi nei bambini, così come la delinquenza e i problemi interpersonali dall’età pre-scolare fino all’adolescenza (Vissing et al., 1991).

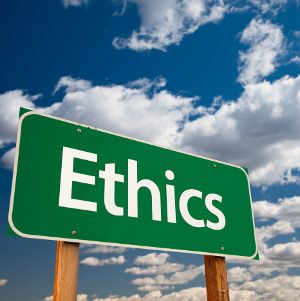 La moralità e l’etica sono tematiche sempre state appannaggio della filosofia e delle scienze cosiddette “speculative”, che cioè teorizzano funzionamenti e situazioni, senza la velleità di trovarvi spiegazioni o proporre modalità di funzionamento specifiche. Da qualche anno, però, il ragionamento morale è sfuggito a questa oligarchia e ha iniziato a essere maggiormente osservato sotto la lente della psicologia, che ha cercato di capire meglio quale potesse essere il funzionamento alla base delle scelte fatte dalle persone quando sono poste di fronte a un “dilemma morale”.
La moralità e l’etica sono tematiche sempre state appannaggio della filosofia e delle scienze cosiddette “speculative”, che cioè teorizzano funzionamenti e situazioni, senza la velleità di trovarvi spiegazioni o proporre modalità di funzionamento specifiche. Da qualche anno, però, il ragionamento morale è sfuggito a questa oligarchia e ha iniziato a essere maggiormente osservato sotto la lente della psicologia, che ha cercato di capire meglio quale potesse essere il funzionamento alla base delle scelte fatte dalle persone quando sono poste di fronte a un “dilemma morale”.
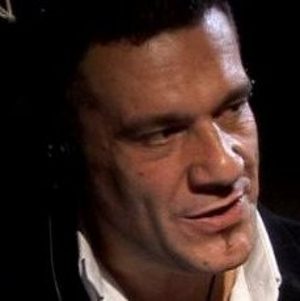
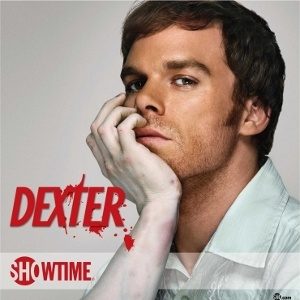 Da diversi anni assistiamo alla proliferazione di serie televisive per lo più americane incentrate su tematiche piuttosto ricorrenti, una delle quali, forse la più esplorata, è la criminologia. Sono ormai innumerevoli le produzioni che ci raccontano vicende poliziesche, indagini legali, ricerche di spietati assassini o intrighi nei quali si intersecano aspetti criminali e politici. Il pubblico è interessato a scoprire cosa si cela dietro l’immagine, spesso mitizzata, delle grandi organizzazioni americane contro il crimine, la Cia, l’Fbi, i dipartimenti di polizia e i nuclei investigativi che si occupano di ricostruire in termini scientifici le dinamiche dei fatti delittuosi. Naturalmente le serie tv tendono ad offrire un ritratto che conferma le aspettative degli spettatori, presentando il volto più efficiente ed energico della lotta all’illegalità.
Da diversi anni assistiamo alla proliferazione di serie televisive per lo più americane incentrate su tematiche piuttosto ricorrenti, una delle quali, forse la più esplorata, è la criminologia. Sono ormai innumerevoli le produzioni che ci raccontano vicende poliziesche, indagini legali, ricerche di spietati assassini o intrighi nei quali si intersecano aspetti criminali e politici. Il pubblico è interessato a scoprire cosa si cela dietro l’immagine, spesso mitizzata, delle grandi organizzazioni americane contro il crimine, la Cia, l’Fbi, i dipartimenti di polizia e i nuclei investigativi che si occupano di ricostruire in termini scientifici le dinamiche dei fatti delittuosi. Naturalmente le serie tv tendono ad offrire un ritratto che conferma le aspettative degli spettatori, presentando il volto più efficiente ed energico della lotta all’illegalità.
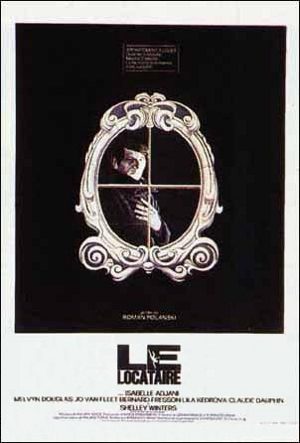
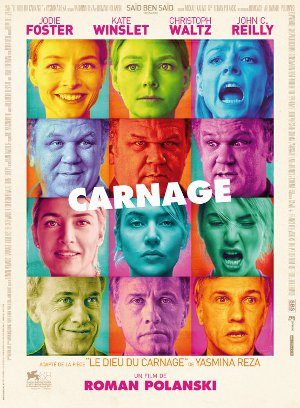
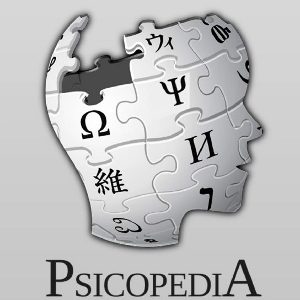 Scomparsa dai manuali diagnostici negli anni ’80, quando il DSM-III la mutò in favore della diagnosi di disturbo antisociale di personalità, la definizione di psicopatia ha continuato ad essere utilizzata per indicare una costellazione di caratteristiche affettive, intrapersonali e comportamentali che includono egocentrismo, impulsività, irresponsabilità, emozioni superficiali, assenza di empatia, senso di colpa o rimorso, mentire patologico, manipolazione e persistente violazione di norme e aspettative sociali.
Scomparsa dai manuali diagnostici negli anni ’80, quando il DSM-III la mutò in favore della diagnosi di disturbo antisociale di personalità, la definizione di psicopatia ha continuato ad essere utilizzata per indicare una costellazione di caratteristiche affettive, intrapersonali e comportamentali che includono egocentrismo, impulsività, irresponsabilità, emozioni superficiali, assenza di empatia, senso di colpa o rimorso, mentire patologico, manipolazione e persistente violazione di norme e aspettative sociali.