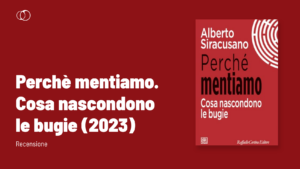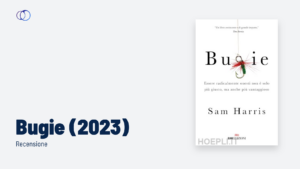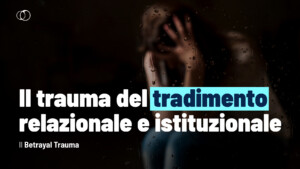Mindfulness in età evolutiva: uno sguardo al contesto scolastico e alle possibili applicazioni con bambini adhd e i loro genitori
E’ possibile estendere l’utilizzo della Mindfulness in età evolutiva come strumento di cura e prevenzione? In particolare, per la patologia ADHD, che effetto avrebbero gli interventi mindfulness diretti con i giovani pazienti nel loro contesto scolastico e gli interventi integrati di Mindfulness training per i genitori?
Sara Zanelli, Michela Quaglia, Cristina Liviana Caldiroli – Open school Psicoterapia Cognitiva e Ricerca
Mindfulness in età evolutiva: la mindfulness Nelle Scuole
Negli ultimi 20 anni, la Mindfulness è divenuta il focus dell’attenzione di una larga parte della comunità scientifica. In modo pressoché spontaneo, attraverso l’unione di studi indipendenti di clinici e ricercatori appartenenti a diversi orientamenti, si è fatto strada un approccio trans-epistemologico basato sui principi radicati nella filosofia orientale.
L’interesse verso una prospettiva apparentemente tanto diversa viene dalla crescente esigenza di integrare, nei metodi della cura clinica e psicologica, le conoscenze rigorose della ricerca empirica con una prospettiva di senso, che valorizzi le possibilità cognitive, emotive e comportamentali della natura umana. Tali possibilità sono da riferirsi alle capacità di accettazione dell’esperienza, di auto-osservazione non giudicante e di comprensione del rapporto di interdipendenza reciproca tra mente e corpo. Tutti questi aspetti possono essere riassunti nel concetto di Mindfulness.
Questo contributo vuole porre in luce la possibilità di utilizzare la Mindfulness in età evolutiva come strumento di cura e prevenzione, partendo da una disamina della letteratura esistente sul tema e focalizzandosi sull’utilizzo di tale strumento nel contesto scolastico, per poi concentrare l’analisi su un tema specifico: l’utilità della pratica di Mindfulness per la patologia ADHD, sia attraverso interventi diretti con i giovani pazienti nel loro contesto scolastico, sia attraverso interventi integrati di Mindfulness training per i genitori.
Definizioni e Origini del Costrutto
Mindfulness significa fare attenzione in modo particolare: intenzionalmente, nel momento presente e senza esprimere giudizi (Kabat-Zinn, 1994). La Mindfulness è il processo che consiste nell’alimentare la consapevolezza del presente (Hanh, 1987). Mindfulness è consapevolezza e accettazione del momento attuale (Hanh, 1987).
Gli elementi costitutivi della Mindfulness, che emergono dalle definizioni riportate sopra (consapevolezza e attenzione) evidenziano quale sia la finalità della pratica Mindfulness, e quindi la sua tensione etica: l’obiettivo è quello di eliminare la sofferenza inutile, coltivando una comprensione e accettazione profonda di qualunque cosa accada attraverso un lavoro attivo con i propri stati mentali. Secondo la tradizione originaria, la pratica della Mindfulness dovrebbe permettere di passare da uno stato di disequilibrio e sofferenza ad uno di maggiore percezione soggettiva di benessere, grazie ad una conoscenza profonda degli stati e dei processi mentali.
Questo significa che
Mindfulness è al tempo stesso il punto di partenza, ossia la chiave per una conoscenza rinnovata della mente; il punto focale, ossia lo strumento per formare la mente; il punto culminante, ossia la manifestazione più appropriata dell’avvenuta liberazione dalle abitudini consolidate della mente che producono infelicità (Kabat-Zinn, 2003).
Se la Mindfulness trova le sue origini nella tradizione buddhista, e quindi nell’approccio fenomenologico di stampo orientale, nel passaggio verso la psicoterapia occidentale il significato originario della parola Mindfulness tende ad espandersi e a trasformarsi in base allo scopo per cui viene utilizzato. Tutti i modelli terapeutici che includono i processi della Mindfulness hanno, tuttavia, uno scopo comune: quello di permettere alle persone di modificare il rapporto con le proprie esperienze in generale, e con quelle interne in particolare, così da poter osservare la propria esperienza senza esserne travolti.
Nello specifico, nel percorso di adattamento della Mindfulness come pratica meditativa alla Mindfulness come tecnica, strategia o strumento psicoterapeutico, si possono ritrovare nuove caratteristiche, definibili come assenza di giudizio, accettazione e compassione. Attorno a questi concetti si raccolgono nuove definizioni:
- Consapevolezza che emerge prestando intenzionalmente attenzione, nel momento presente e in modo non giudicante, al dispiegarsi dell’esperienza (Kabat-Zinn, 2003).
- Autoregolazione dell’attenzione, così da mantenerla sull’esperienza presente, che rende possibile un miglior riconoscimento degli eventi mentali, adottando un atteggiamento caratterizzato da curiosità, apertura e accettazione (Bishop et al., 2004).
- Consapevolezza dell’esperienza presente con accettazione (Germer, Siegel, & Fulton, 2005).
Meccanismi di Cambiamento
Se finora l’analisi condotta ha contribuito a definire il costrutto della Mindfulness (cosa), identificarne gli scopi e le tensioni etiche (perché), in questa sezione si parlerà dei possibili meccanismi di funzionamento (come).
Meccanismi Neurali
Uno dei principi su cui si basa tutto l’apparato concettuale della Mindfulness riguarda l’unione mente/corpo: tale rilevanza è basata ad esempio sulla consapevolezza che il riconoscimento e la descrizione delle sensazioni e delle percezioni del corpo veicolano informazioni riguardo alla sfera cognitivo-emotiva. Non stupisce, quindi, che un ramo della ricerca sia stato espressamente dedicato allo studio dei meccanismi cerebrali che sottendono un orientamento mindful.
Una lettura interessante viene da Siegel, il quale ritiene che alla base di un funzionamento mindful ci sia l’integrazione neurale che influenza e viene influenzata dalla consapevolezza di Mindfulness. Secondo l’autore:
La consapevolezza dell’esperienza che facciamo momento per momento ci dà la possibilità di sentire e accettare direttamente la nostra esperienza mentale. Questo stato di consapevolezza può coinvolgere in uno stato integrato tra varie regioni del cervello, incluse aree importanti della corteccia e le aree subcorticali del sistema limbico e del tronco encefalico. L’integrazione neurale, in parte condotta da queste regioni frontali, può essere essenziale per creare un equilibrio basato sull’autoregolazione. […] Questi percorsi di integrazione possono giocare un ruolo cruciale per il benessere.
(D. J. Siegel, 2009).
È possibile, quindi, ritrovare nella meditazione di Mindfulness un’attivazione contemporanea delle aree cerebrali frontali adibite alle capacità esecutive e di allerta, che inizialmente avrebbero la funzione di indirizzare e sostenere l’attenzione, e in seguito quella di sostenere l’intenzione di proseguire nella consapevolezza al momento presente, attraverso l’influenza sui processi decisionali.
Sebbene gli studi sui meccanismi neurali forniscano informazioni importanti, una comprensione esaustiva delle modalità di azione della Mindfulness non può prescindere dall’analisi dei meccanismi che si creano a livello cognitivo ed emotivo.
Meccanismi Psicologici
Al momento attuale, molti dei meccanismi psicologici che si suppone essere alla base della consapevolezza, vengono proposti a livello teorico. Shapiro, Carlson e colleghi propongono una teoria strutturata sui meccanismi coinvolti nei processi di Mindfulness, basata sull’interrelazione continua momento-per-momento di tre componenti (Shapiro et al., 2006). Gli autori definiscono queste componenti gli assiomi della loro teoria e li ritrovano nella definizione di Mindfulness formulata da Kabat-Zinn:
Prestare attenzione in un modo particolare: intenzionalmente, nel momento presente e senza giudicare
(Kabat-Zinn, 2003).
Il modello viene quindi formulato sulla base della seguente trasduzione.
L’intenzione (I) fa riferimento alla motivazione sottostante l’avvicinarsi alla meditazione di Mindfulness: chi ha l’obiettivo di imparare a regolare i propri stati interni ottiene auto-regolazione, chi vuole esplorare i propri vissuti ottiene auto-esplorazione, e chi vuole liberarsi dei sentimenti negativi ottiene auto-liberazione. L’intenzione è intesa come un concetto dinamico ed evolutivo, che può cambiare nel tempo e a seconda delle necessità, ed è una componente centrale della Mindfulness perché ne influenza direttamente gli effetti.
L’attenzione (A) è la seconda componente del modello e implica un’osservazione dell’esperienza interna ed esterna, momento per momento, che sospenda tutte le operazioni interpretative e si basi esclusivamente sulla realtà così come si presenta. Questo assioma è importante nel modello anche perché si propone di costituire un anello di congiunzione con la psicologia cognitiva, che nei suoi assunti definisce l’attenzione come meccanismo curativo di base.
L’ultimo assioma, l’atteggiamento (A), si riferisce al come della Mindfulness ed è considerato cruciale degli autori perché rappresenta quella modalità compassionevole e amorevole, verso sé stessi e gli altri, che evidenzia la tensione etica della presenza mentale. L’atteggiamento amorevole o gentilezza amorevole (‘Metta’ in lingua pali) è infatti uno degli strumenti di base della tecnica meditativa Mindfulness utilizzata per contrastare i sentimenti distruttivi di rabbia e ostilità.
Shapiro e colleghi suggeriscono che i tre assiomi IAA siano direttamente collegati a molte delle trasformazioni che si osservano grazie alla pratica della Mindfulness e sulla base di questa ipotesi propongono un modello di funzionamento che spiega la relazione reciproca e continua esistente tra i tre elementi: il prestare attenzione (A) in modo intenzionale (I) con apertura e atteggiamento non giudicante (A) porterebbe le persone a sperimentare un cambiamento di prospettiva, che gli autori chiamano ripercezione.
Questo cambiamento di prospettiva, o ripercezione, avviene nel momento in cui, attraverso la Mindfulness, ci si disidentifica dai contenuti della propria coscienza e ci si rapporta alla realtà con maggiore chiarezza e obiettività.
Il processo di graduale cambiamento di prospettiva è, evolutivamente parlando, uno dei meccanismi cognitivi che porta alla maturazione degli individui (si pensi, ad esempio, alla formulazione di una teoria della mente nel processo di sviluppo cognitivo dei bambini). La ripercezione, proprio perché orientata all’esperienza nel momento in cui essa si presenta, è un processo continuo, nel qui e ora, che riflette l’interrelazione costante tra i tre assiomi.
Il modello di Shapiro e colleghi, sebbene si collochi a livello di speculazione teorica, si pone anche come possibile ipotesi di partenza per studi empirici che vogliano testare l’efficacia dei trattamenti basati sulla Mindfulness in popolazioni specifiche (Bishop, 2002; Mace, 2008).
Interventi basati sulla mindfulness
La pratica della Mindfulness è stata portata all’attenzione della ricerca clinica e psicologica grazie soprattutto alla sua traduzione in protocollo, ad opera di John Kabat-Zinn (Kabat-Zinn & University of Massachusetts Medical Center/Worcester. Stress Reduction Clinic, 1990). Il lavoro di John Kabat-Zinn sulla riduzione dello stress basato sulla Mindfulness (Mindfulness Based Stress Reduction o MBSR, da qui in avanti nel testo) ha reso possibile a molte persone l’addestramento alla presenza consapevole senza che dovessero cercarlo sotto forma di aiuto spirituale (Mace, 2008). Ai pazienti veniva spiegato, in un incontro introduttivo, in che cosa consistessero gli esercizi di meditazione di Mindfulness e veniva loro chiesto di aderire ad un programma di addestramento della durata di 8 settimane. Il programma era previsto per circa 30 partecipanti, che si sarebbero dovuti incontrare settimanalmente per circa 2 ore in una sessione intensiva di pratica meditativa.
Le componenti centrali del programma riguardavano:
- L’istruzione sui fattori che inducono e mantengono lo stress;
- Lo svolgimento di esercizi di autocontrollo per familiarizzarsi con le cause individuali di stress;
- L’analisi dell’impatto dei pensieri e delle sensazioni sulle tensioni;
- L’addestramento alla presenza mentale tramite le tecniche meditative formali come lo yoga, il body scan e la meditazione seduta;
- L’uso regolare di discussioni di gruppo per incentivare l’apprendimento delle tecniche;
- Lo svolgimento di compiti a casa che prevedevano il ricorso alle tecniche apprese negli incontri di gruppo.
Le tecniche meditative venivano presentate con lo scopo di insegnare a dirigere l’attenzione verso diversi oggetti, di sviluppare la capacità di consapevolezza del respiro, delle sensazioni fisiche e di quelle emotive. All’interno del programma MBSR si praticava anche una libera consapevolezza, per stimolare la massima apertura a qualsiasi esperienza sorgesse in quel dato momento (Mace, 2008): l’istruzione era quella di focalizzare l’attenzione su qualsiasi cosa si presentasse alla coscienza (emozione, sensazione, idea) e di osservarla senza giudicare.
Quando il partecipante si fosse accorto che l’attenzione si era spostata dal respiro al nuovo evento mentale, avrebbe dovuto riconoscerne brevemente il contenuto e poi riportare l’attenzione sulla respirazione. Il compito era quello di riconoscere senza riconoscersi negli eventi mentali. Ai partecipanti veniva poi chiesto di dedicare almeno 45 minuti al giorno, nei 6 giorni restanti, alle tecniche apprese, anche attraverso l’utilizzo dei supporti audio forniti dall’istruttore.
Grazie alla pratica ripetuta degli esercizi di meditazione Mindfulness, il praticante avrebbe potuto apprendere la capacità di fare un passo indietro rispetto alle proprie ideazioni in situazioni stressanti, piuttosto che autoingaggiarsi in atteggiamenti preoccupati e in pattern di pensiero negativo che sarebbero potuti sfociare in un ciclo di reattività disfunzionale, con la conseguenza di peggiorare lo stress emotivo (Bishop, 2002).
Diverse reviews e meta-analisi hanno dimostrato l’efficacia degli interventi basati sulla Mindfulness (o Mindfulness Based Interventions, MBIs nel testo) in un ampio range di problemi psichiatrici e legati allo stress e, aspetto ancor più importante dal punto di vista del sopracitato ruolo formativo della Mindfulness, esiste in letteratura un accenno al potenziale preventivo e di promozione del benessere dei MBIs nelle popolazioni non-cliniche, specialmente per quanto riguarda la riduzione dello stress, l’aumento del benessere percepito, l’aumento della capacità attentiva e il prolungamento del tempo di mantenimento dell’attenzione (Shapiro et al., 2007; Jha et al., 2007; Sauer et al., 2012).
Mindfulness in età evolutiva
Partendo dal presupposto di efficacia degli MBIs negli adulti, sembra essere interessante sviluppare interventi mindfulness in l’età evolutiva: ad oggi, sebbene la ricerca in questo ambito sia ancora agli albori, le evidenze riscontrate in letteratura sembrano testimoniare l’adattabilità di questo tipo di interventi e l’efficacia in campioni, clinici e non, di bambini e adolescenti (Black et al., 2009).
Il contesto scolastico, per le sue caratteristiche strutturali, sembra essere il più adatto per l’implementazione degli interventi basati sulla Mindfulness in età evolutiva, i quali passano la maggior parte del loro tempo a scuola. Inoltre, aspetto ancor più importante, proprio in tale contesto può realizzarsi l’intento preventivo ed educativo della Mindfulness in età evolutiva: se da un lato, gli interventi MB possono aiutare i bambini in difficoltà, dall’altro possono porsi come strumento indispensabile per l’apprendimento delle competenze prosociali, di tolleranza della frustrazione e di promozione della capacità cognitive utili e fruibili da tutti i giovani discenti della società. Le caratteristiche precedentemente citate di una mente mindful (consapevolezza e attenzione, così come accettazione e compassione), partecipando al benessere degli individui in età evolutiva, permetterebbero inoltre di:
Affrontare le sfide future di un mondo in rapido cambiamento, formando persone intelligenti e accudenti e cittadini partecipi ed impegnati
(Shapiro et al., 2008).
Nello stesso tempo, la letteratura attuale riporta un aumento dei problemi di interesse clinico nell’età evolutiva, legati allo stress e alla pressione sociale: lo stress scolastico avrebbe un effetto sulle strutture cerebrali coinvolte nei compiti cognitivi e nella salute mentale (Zenner et al., 2014).
Il contesto scolastico è quindi chiamato non solo a provvedere all’educazione formale e nozionistica, ma anche a valorizzare le competenze sociali e personali dei giovani, a prevenirne il disagio psicologico e promuoverne il benessere globale. Gli interventi basati sulla Mindfulness in età evolutiva potrebbero rispondere a queste necessità, unendo l’ottica preventiva a quella formativa.
A luce di queste osservazioni, può essere opportuno riflettere su come declinare la pratica di Mindfulness in età evolutiva e renderla più adatta all’ambito scolastico. Risulta evidente, in questo senso, che una mera riproduzione del protocollo MBSR non risulterebbe adeguata, dovendo confrontarsi con differenti motivazioni e bisogni rispetto a quelli dei pazienti adulti.
Se le pratiche di meditazione in età evolutiva possono essere simili a quelle degli adulti, le modalità e i tempi devono essere differenti. A questo proposito, Fabbro propone, con i bambini più piccoli, di strutturare le sedute di meditazione in modo che siano molto brevi e che si svolgano con una routine invariata nel tempo (Fabbro e Muratori, 2012). Sempre secondo l’autore, gli esercizi devono essere semplici e adeguati alle capacità dei bambini; alla fine della meditazione è opportuno dedicare uno spazio per la condivisione delle esperienze, per poter esprimere le proprie difficoltà e discuterne. Inoltre, a seconda delle varie fasce d’età (5-8, 9-12, 13-18 anni) la letteratura fornisce suggerimenti su tecniche e procedure di meditazione specifiche (Hooker, 2008).
Molto importante, trasversalmente alle diverse tecniche e agli esercizi proposti, è aiutare i bambini a diventare consapevoli delle proprie emozioni (Fabbro e Muratori, 2012).
Nella letteratura più recente (Meiklejohn et al., 2012; Zenner et al., 2014), alcune review testimoniano l’esistenza di un sempre più ampio numero di studi che trattano degli interventi MB nelle scuole, sebbene la diversità dei programmi analizzati e la qualità di studi pilota di molti lavori non permettano tutt’ora di parlare di una vera e propria efficacia. Nello specifico, potrebbe essere utile capire se esistano specifici domini in cui gli interventi basati sulla Mindfulness possano apportare particolare beneficio. A questo proposito, la review meta-analitica di Zenner e colleghi (Zenner et al., 2014), vuole delineare lo stato dell’arte relativo agli interventi Mindfulness nelle scuole, così da fornire un utile ancoraggio per le future linee di ricerca, cercando anche di capire come integrare la pratica della Mindfulness in età evolutiva e nella routine scolastica.
I risultati riportati testimoniano buoni effetti nel dominio cognitivo, ma anche nelle variabili più specificamente psicologiche di stress, strategie di coping e resilienza. Anche l’accettazione, più volte citata, sembra essere una variabile positivamente influenzata dalla pratica Mindfulness. Accanto a questi risultati, che confermano quanto proposto dalla letteratura teorica sul tema, Zenner e colleghi evidenziano anche alcuni limiti di questo campo di ricerca, sottolineando in particolare l’eterogeneità degli interventi e l’assenza di gruppi di controllo nei campioni analizzati.
Inoltre, sembra sia possibile che diverse variabili, poco controllabili, possano influenzare gli effetti positivi riscontrati nei MBIs nelle scuole: il background socioculturale in cui il contesto scolastico è inserito, la possibilità da parte degli studenti di dedicare tempo e spazi agli esercizi di Mindfulness fuori da scuola, la presenza di insegnanti opportunamente preparati piuttosto che l’inserimento nel corpo docenti di esperti esterni. Un ulteriore limite è costituito infine dalla variabilità degli strumenti di misura e dall’instabilità delle misure di outcome, che in età evolutiva cambiano rapidamente.
Un accenno va riservato inoltre alla dimensione della motivazione che, tanto importante nella pratica Mindfulness, è chiaramente individuabile nei pazienti adulti che si avvicinano alla Mindfulness, ma meno chiara quando si parla di soggetti in età evolutiva. In sintesi, vista la qualità di studi pilota a basso numero di partecipanti, non sembra ancora possibile individuare, nel contesto scolastico, quali siano gli elementi della Mindfulness che giocano un ruolo nella modifica delle variabili di outcome, lasciando invece suppore un effetto di fattori non specifici, quali il supporto percepito dal gruppo, la novità della pratica o un generale rilassamento.
Laddove, quindi, non sembra ancora possibile parlare di omogeneità degli interventi in ambito scolastico, sembra comunque possibile determinare gli effetti che la pratica Mindfulness in età evolutiva ha sulle funzioni attentive e sulle componenti emotive. Flook et al. (2010) testimoniano l’efficacia dell’intervento Inner Kids sulle funzioni esecutive.
Il programma, ideato da Susan Kaiser Greenland (Greenland, 2010), si propone di incrementare gli aspetti di Attenzione, Consapevolezza e Compassione attraverso attività di gioco e movimento specificamente pensate per i bambini in età evolutiva e per il contesto scolastico, adattandole dal programma MBSR di John Kabat-Zinn. Gli autori hanno valutato (attraverso un questionario somministrato a genitori ed insegnanti, il Behavior Rating Inventory of Executive Function o BRIEF di Gioia et al., 2000) le dimensioni di Metacognizione e Regolazione del Comportamento in un campione di bambini -tra i 7 e i 9 anni- prima e dopo la partecipazione al training di Mindfulness in età evolutiva, evidenziando un miglioramento in entrambe le scale, specialmente per coloro che in baseline mostravano valori più bassi. I risultati sembrano quindi sottolineare un effetto positivo della pratica di presenza consapevole sui bambini che mostrano difficoltà nelle funzioni esecutive.
Per quanto concerne gli aspetti emotivi, Saltzman e Goldin (Saltzman e Goldin, 2008) hanno seguito il programma MBSR for children con 30 bambini, ottenendo risultati incoraggianti per quanto riguarda l’efficacia della Mindfulness in età evolutiva sui problemi di natura emotiva: hanno infatti riscontrato una minor reattività emotiva, una minore tendenza all’autocritica ed anche una maggiore compassione verso di sé e verso gli altri dopo un training di Mindfulness della durata di otto settimane.
Questa breve disamina degli studi permette di capire come la Mindfulness in età evolutiva possa rappresentare uno strumento di grande utilità per affrontare le problematiche riscontrabili, sia di ordine cognitivo che emotivo (anche alla luce della compresenza dei due aspetti, che spesso si trovano associati nelle più variegate forme di disagio).
Di particolare interesse, per gli scopi di questo contributo, sono gli studi condotti su campioni di adolescenti con ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) e sui loro genitori, che hanno evidenziato la possibilità di condurre un tale tipo di intervento nel contesto scolastico.
Mindfulness in età evolutiva e competenze attentive: un’applicazione con bambini con adhd
L’ADHD (acronimo di Attention Deficit Hyperactivity Disorder), anche conosciuto come Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (DDAI), è un disturbo neurobiologico dello sviluppo neuropsichico del bambino o dell’adolescente. Esso è caratterizzato da gravi difficoltà di attenzione, di concentrazione, di impulsività e di iperattività, inadeguati rispetto all’età.
A livello mondiale si stima che ne sia colpita circa il 5% della popolazione, di età compresa fra i 4 i 17 anni, con una prevalenza nettamente superiore del sesso maschile rispetto a quello femminile (Polanczyk et al., 2007).
Le criticità sopra evidenziate, dovute all’incapacità del bambino di regolare il proprio comportamento, sono soprattutto riscontrabili nella scarsa cura per i dettagli, nella labilità attentiva e nell’inabilità a portare a termine compiti/giochi intrapresi o obiettivi da raggiungere. Sono inoltre evidenziabili difficoltà organizzative e di autocontrollo, incapacità a procrastinare nel tempo la risposta ad uno stimolo interno o alle richieste dell’ambiente, perdita di oggetti di uso quotidiano, irrequietezza e incapacità a stare seduto, difficoltà nell’aspettare il proprio turno (Barkley, 1998). A questi sintomi, spesso, si accompagnano sensazioni interne e soggettive di tensione, pressione e instabilità, che devono essere scaricate.
È necessario precisare che tale corteo sintomatologico non è causato da un deficit cognitivo, non è nemmeno una normale fase di crescita del bambino, e neppure il risultato di una scorretta disciplina educativa, ma è dovuto ad oggettive difficoltà di autocontrollo e di pianificazione, presenti in tutte le situazioni di vita del bambino, che causano anche un’evidente compromissione delle attività quotidiane.
Tali incapacità sono spesso la causa dell’insuccesso scolastico, o di minor resa scolastica, e di un minor utilizzo delle proprie abilità cognitive ed hanno, per il bambino, gravi conseguenze nel breve e lungo termine. L’ADHD, pur avendo una natura organica, non può essere trattata con un solo intervento di tipo farmacologico: pertanto, per bambini con ADHD, si è soliti indicare un trattamento multimodale che unisce vari interventi indirizzati alle diverse aree compromesse. Ad oggi, ci sono due trattamenti evidence-based per bambini con ADHD: quello farmacologico (principalmente stimolante) e quello comportamentale (Van der Oord et al., 2008).
La terapia farmacologica, agisce unicamente sui sintomi primari del disturbo (impulsività, inattenzione e iperattività) e solitamente risulta inefficace nel migliorare l’autostima e le competenze sociali-relazionali, inoltre il farmaco funziona solo nel breve termine, e i bambini mostrano spesso effetti collaterali (Schachter et al., 2001).
Invece, i trattamenti cognitivo-comportamentali sono focalizzati sulla formazione comportamentale dei genitori e sull’insegnamento di competenze per affrontare e gestire i sintomi dell’ADHD e dei suoi problemi associati. Tuttavia questi interventi hanno anch’essi limitati effetti a lungo termine e sono scarsamente generalizzabili ad altri compiti (Chambles e Ollendick, 2001; Pelham e Fabiano, 2008).
Ulteriore critica, spesso avanzata dai genitori, è che tali strategie richiedano loro di imporre un controllo sul bambino, che risulta direttivo e spesso non compreso dal bambino stesso. La diretta conseguenza di tale metodologia è che non vengano imparate in prima persona dal soggetto con ADHD strategie di autocontrollo e che non si crei un’interazione positiva fra figlio e genitore (Nirbhai, 2009).
Riguardo i familiari, è necessario inoltre evidenziare che l’ADHD è altamente ereditabile, e una diagnosi di ADHD nei genitori è un predittore di fallimento a questo tipo di formazione genitoriale (Sonuga-Barke et al., 2002; Van den Hoofdakker et al., 2010).
E’ risultato pertanto necessario individuare e implementare un intervento che agisca in modo più efficace, duraturo e generalizzabile sulle problematicità attentive sopra citate, motivo per cui le recenti ricerche nel panorama internazionale si sono mosse ad indagare gli effetti della pratica Mindfulness in età evolutiva sull’ADHD.
L’attenzione ricopre un ruolo centrale nella meditazione Mindfulness, quali l’auto-regolazione dell’attenzione nell’esperienza immediata e un atteggiamento di accettazione degli eventi.
Bishop e colleghi (2004) hanno proposto una concettualizzazione, divisa in quattro moduli, in cui la regolazione attenzionale sarebbe coinvolta nella pratica della Mindfulness: regolazione dell’attenzione sostenuta, per mantenere la consapevolezza dell’esperienza nel momento presente; switching attenzionale, per permettere il ritorno dell’attenzione al momento presente dopo una distrazione; inibizione del processo elaborativo, per evitare di ruminare o rimuginare su pensieri o sentimenti che sono al di fuori del momento presente; attenzione non direzionata, per migliorare la consapevolezza dell’esperienza presente, non influenzata da ipotesi o aspettative.
Si è perciò ipotizzato che, tale tecnica, possa produrre dei benefici nel trattamento della sintomatologia ADHD con dei miglioramenti funzionali e strutturali a carico del sistema attentivo, in particolare rispetto ai meccanismi di autoregolazione e di inibizione della risposta automatica.
La ricerca condotta da Van der Oord, Bögels e Peijnenburg, nel 2012, si è mossa proprio in questo senso. Per lo studio sono stati coinvolti 22 bambini con ADHD (diagnosi effettuata secondo i criteri del DSM-IV) di età fra gli 8 e i 12 anni che, insieme ai propri genitori, sono stati sottoposti ad un percorso Mindfulness in età evolutiva di 8 settimane. In particolare il training proposto consisteva in 8 sedute settimanali, della durata di 90 minuti l’una, condotte in piccolo gruppo, composto da 4-6 bambini e genitori. Venivano inoltre forniti dei compiti a casa, così da poter consolidare la pratica attraverso un esercizio costante. Durante il trattamento di Mindful Child Training (MC) rivolto ai bambini, i loro genitori ricevevano parallelamente una formazione di Mindful Parenting (MP).
Entrambi i cicli di formazione si basano sulla Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT, Segal et al., 2002) e sul Mindfulness-Based Stress Reduction Training (MBSR, Kabat-Zinn, 1990), adattati per l’uso con bambini e genitori.
Durante le sessioni di Mindful Child Training (MC), altamente strutturate (Van der Oord et al., 2009), grazie ad esercizi di consapevolezza corporea, di sensibilizzazione sensoriale, di respirazione, yoga e meditazione, il comportamento ADHD è stato ridotto: i bambini hanno imparato a concentrarsi per migliorare la loro attenzione, la consapevolezza, l’autocontrollo e l’inibizione delle risposte automatiche. Inoltre, essi hanno anche imparato ad applicare la consapevolezza in situazioni difficili, come l’essere distratto a scuola.
Per il Mindful Parenting (MP), è stato utilizzato il manuale di Bögels et al. (2008) e Bögels et al. (2010), lievemente modificato per soddisfare le esigenze dei genitori di bambini con ADHD. Grazie a questo training i genitori hanno imparato a essere completamente presenti, in maniera non giudicante, nel qui e ora con il figlio; ad accogliere e rispondere, piuttosto che reagire negativamente di fronte ai suoi comportamenti inadeguati; ad accettare le sue problematicità; e infine a prendersi cura di se stessi. Poter affrontare e superare lo stress, per i genitori, è un traguardo importante perché, a casa, è loro compito incoraggiare i figli a fare meditazione, sia singolarmente sia insieme.
Per poter valutare l’effettiva efficacia del training, alle famiglie è stato chiesto di compilare i seguenti strumenti testistici in fase di pre-trattamento, post-trattamento e in follow up a distanza di 8 settimane: Disruptive Behavior Disorder Rating Scale (DBDRS) per i sintomi del disturbo dirompente del comportamento, The ADHD Rating Scale (ARS) per i sintomi dell’ADHD, The Parenting Scale (PS) per lo stile genitoriale, Parenting Stress Index (PSI) per il grado di stress genitoriale, Mindfulness Attention and Awareness Scale (MAAS) per il livello di attenzione consapevole genitoriale.
I risultati di questo studio hanno provato che i sintomi dell’ADHD nei bambini si sono notevolmente ridotti dopo il training di Mindfulness in età evolutiva. I genitori hanno in particolar modo notato una maggior regolazione dell’attenzione e dei processi cognitivi coinvolti, poiché si sono notevolmente ridotti momenti di disattenzione e moderatamente ridotti momenti di iperattività e impulsività.
E’ interessante notare che i genitori hanno inoltre evidenziato una riduzione del proprio livello di stress e disattenzione, in favore di una maggior autoregolazione e consapevolezza dei vissuti propri e del figlio. I risultati sopradescritti, sia per i bambini sia per i genitori, sono stati mantenuti anche al follow-up di 8 settimane.
Visti i risultati più che soddisfacenti, molte famiglie hanno chiesto un’ulteriore formazione Mindfulness dopo l’incontro di follow-up. Infatti, il sostegno alle famiglie di bambini con ADHD, per continuare ad approfondire la Mindfulness nel corso degli anni, sembra essere una buona pratica clinica, in particolare durante il periodo di sviluppo dei bambini, quando cambiano rapidamente e si confrontano con sfide nuove e diverse, per le quali la pratica della Mindfulness può essere utile. (Van der Oord et al., 2008).
Mindfulness training per i genitori di bambini con ADHD
Abbiamo fin qui affermato che il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività è un disturbo di tipo neurobiologico caratterizzato da disattenzione, iperattività ed impulsività che interferiscono con lo sviluppo sociale e personale del bambino, caratteristiche che spesso sono rinforzate dall’ambiente e dal contesto psicosociale in cui il bambino è inserito (Pezzica and Bigozzi, 2015). Per questo motivo la costruzione di contesti supportivi e contenitivi risulta essere di primaria importanza, e non una componente secondaria, quando ci si trova in presenza di bambini con ADHD (Pennington, 2006).
E’ quindi condivisa l’ipotesi secondo la quale genitori e care-giver hanno il compito di aiutare e supportare i propri figli, in particolar modo affiancandoli nel percorso terapeutico che hanno intrapreso, svolgendo un ruolo cruciale nel mantenimento dei risultati ottenuti. Un compito non facile se si pensa che i bambini con ADHD sono spesso disobbedienti, impulsivi e non ascoltano le norme genitoriali, mostrando, a volte, un comportamento oppositivo e aggressivo nei confronti dei genitori stessi (Johnson and Jassy, 2007). Di contro, i genitori sviluppano un atteggiamento over-reactivity, caratterizzato da minor pazienza, maggior attenzione ai comportamenti disfunzionali e tendenza ad agire impulsivamente (Miller-Lewis et al., 2006)
Sulla scorta di quanto detto, diversi studi si sono focalizzati sull’importanza di migliorare e rendere maggiormente efficaci le interazioni genitore-figlio nello sviluppo del bambino ADHD, ricorrendo a diversi metodi per far fronte e ridurre il comportamento problematico e disfunzionale di entrambi e creando uno stile genitoriale positivo.
In particolar modo, negli ultimi anni ha trovato ampio spazio il trattamento comportamentale, definito Parent Training (PT), che riguarda la modifica dei comportamenti e degli atteggiamenti dei genitori verso i bambini stessi attraverso suggerimenti educativi di tipo comportamentale. Ma la letteratura sottolinea come l’ADHD sia altamente ereditabile (Dumas, 2005; Thapar et al., 2007) e, quindi, i genitori di bambini con ADHD possono anche visualizzare i sintomi stessi dell’ ADHD rendendo questa componente un fattore predittivo di non risposta a questa formazione comportamentale (Sonuga-Barke et al., 2002;. Van den Hoofdakker et al., 2010). Inoltre, i genitori spesso riferiscono come queste strategie di gestione richiedono di imporre un controllo esterno sui bambini, impedendo agli stessi di imparare strategie di auto-controllo ed inficiando negativamente nella relazione genitore-figlio.
Dato lo scarso successo del Parent Training tradizionale, ci si è sempre più spostati su un trattamento non solo comportamentale ma anche cognitivo. Il Parent Training Cognitivo-Comportamentale (PTCC) si focalizza sugli aspetti cognitivi ed emotivi dei genitori dei bambini con ADHD, lavorando sulle rappresentazioni mentali dei genitori; il primo protocollo italiano è di Vio e collaboratori (Vio et al., 1999; Vio et al., 2013). Nelle sessioni di PTCC vengono fornite informazioni sul disturbo, riorganizzate le rappresentazioni mentali del figlio con ADHD e sviluppate le strategie e le competenze di gestione dei problemi.
In questa prospettiva, sono stati riscontrati diversi risultati positivi, in particolare nel modificare la percezione dei genitori sui sintomi dell’ADHD e nel miglioramento del senso di soddisfazione e percezione positiva del sé genitoriale. I limiti di questo trattamento riguardano la mancanza di effetti a lungo termine e la difficoltà nella generalizzazione delle abilità apprese al di fuori del setting terapeutico, risultato che si evince soprattutto durante i follow-up tenuti a distanza di alcuni mesi (Pelham and Fabiano, 2008; Pezzica e Bigozzi, 2015).
Un intervento che, pur partendo dalla stessa base teorica del PTCC, introduce contenuti finalizzati alla promozione delle abilità di sintonizzazione emotiva e mentalizzazione del genitore è il Parent Training Cognitivo-Comportamentale-Mentalizzante (PTCC-M).
In quest’ottica, una chiave fondamentale per ottenere degli effetti è rappresentata dall’induzione nel genitore di mentalizzazioni metacognitive riguardanti se stesso e gli altri (l’altro genitore e il bambino). Il genitore è guidato a non considerare solo i comportamenti, ma anche i pensieri e gli affetti che li accompagnano. In base ai dati raccolti, il PTCC-M risulta avere un effetto specifico nel migliorare il senso di competenza genitoriale, il sostegno del partner e la sintonizzazione con il figlio nel rapporto con i genitori (Pezzica e Bigozzi, 2015). L’intervento presenta le stesse difficoltà del PTCC nel mantenere effetti a lungo termine nel comportamento e negli atteggiamenti dei genitori e, non essendo un intervento direttamente operato sul bambino, si evidenziano tempi lunghi negli effetti prodotti sui suoi comportamenti disfunzionali (Pezzica e Bigozzi, 2015).
Nonostante non si sia arrivati a definire un Parent Training ottimale, è importante notare come si stia andando incontro ad un trattamento sempre più efficacie, migliorando il punto di vista dei genitori e le proprie competenze, influenzando, così, il comportamento del bambino con ADHD. Per questo, si è spesso ritenuto necessario studiare gli effetti di altri trattamenti, accanto a quelli tradizionali, con particolare attenzione alle problematiche di fondo dell’ADHD.
In questo senso si stanno muovendo gli studi sull’utilizzo della Mindfulness come training per i genitori di bambini ADHD, ovvero il Mindful Parenting (MP), dimostrando come questa tecnica può migliorare le interazioni positive bambino-genitore e può incrementare il livello di soddisfazione circa la propria genitorialità nonché il miglioramento del clima nell’ambiente famigliare e, più in generale, del contesto psicosociale del bambino.
Abbiamo definito la Mindfulness come un intervento sulla base di tecniche di meditazione orientali, che aiuta ad aumentare la consapevolezza del momento presente, migliora l’osservazione non giudicante, e riduce le risposte automatiche (Kabat-Zinn, 2003), ed è in questa definizione che si trova la motivazione del suo utilizzo nelle famiglie di bambini con ADHD.
Attraverso la Mindfulness si impara ad essere genitori consapevoli, una forma di allenamento alla consapevolezza così definito:
capacità di prestare attenzione al tuo bambino e alla tua competenza genitoriale in modo particolare: intenzionalmente, qui ed ora, e non in maniera giudicante
(Kabat-Zinn, 2003).
Nel Mindfulness Training per i genitori essi imparano a rivolgere la loro attenzione ai figli in maniera non giudicante, cercando di aumentare la consapevolezza del momento presente con il loro bambino, e ridurre le reazioni automatiche (negative) nei confronti del bambino stesso (Bögels et al., 2008; Bögels et al., 2010). Inoltre, facendo pratica di meditazione quotidiana, i genitori imparano a prendersi cura di se stessi e a riportare la calma nella loro famiglia, abbassando i livelli di stress ai quali si sentono costantemente sottoposti. Anche Singh e collaboratori (2010) hanno studiato gli effetti del Mindful Parenting, trovando risultati che dimostrano l’efficacia della Mindfulness in età evolutiva per i bambini con ADHD ed i loro genitori.
Van der Oord e colleghi (2012) hanno condotto uno studio pilota indagando l’efficacia di un corso di formazione sulla Mindfulness per bambini con ADHD e i loro genitori, confermando l’efficacia della Mindfulness in età evolutiva e, soprattutto, l’importanza di un intervento congiunto che riguardi sia i bambini che i genitori perché, come sottolineato anche da Singh e colleghi (2010), è indispensabile che i bambini siano adeguatamente preparati essi stessi ma che abbiano anche un supporto dall’ambiente nel quale crescono e dalle figure genitoriali.
Va sottolineato come questo intervento abbia una rilevanza positiva su altri due fattori dei quali abbiamo parlato: la familiarità dell’ADHD e lo stress che si viene a creare nei genitori stessi.
Come visto nel paragrafo precedente, l’applicazione della Mindfulness in età evolutiva su soggetti con ADHD ha ottenuto risultati positivi nel migliorare le capacità attentive e a contenere l’impulsività del comportamento; avendo una componente ereditaria, anche i genitori dei bambini con ADHD possono presentare alcuni sintomi dei figli. Questo ci porta alla conclusione che la Mindfulness facilita anche nei genitori stessi la gestione di questi tratti considerati disfunzionali (Singh et al., 2010; Dumas, 2005).
Ultima importante componente sulla quale agisce la Mindfulness in età evolutiva riguarda lo stress. Come sappiamo, i bambini con ADHD presentano un comportamento impulsivo, disattento e iperattivo, tutte caratteristiche con i quali i genitori hanno a che fare ogni giorno. A causa delle difficoltà nel relazionarsi con questi fattori spesso i genitori si trovano ad essere meno pazienti e maggiormente irritabili, con la conseguenza di mettere in crisi le proprie idee e l’immagine di sé come genitore competente; l’unione di questi fattori porta all’aumento dello stress, diventando più rifiutanti peggiorano le risposte negative nei confronti dei figli. Per non ritrovarsi in un circolo senza uscita, è importante che i genitori imparino ad abbassare i livelli stressogeni che si sono creati, attraverso l’utilizzo della Mindfulness: i genitori imparano a prestare la giusta attenzione al figlio in maniera non giudicante, a vivere il qui ed ora della situazione e ad evitare la messa in atto di risposte automatiche (negative), con il conseguente miglioramento della gestione della relazione genitore-figlio, una migliore visione del sé genitoriale e un abbassamento dello stress (Bögels et al., 2010; Singh et al., 2010).
Concludendo, si può vedere come nei vari studi, gli obbiettivi che sono stati promossi a favore dei genitori si possono riassumere in cinque punti principali:
- Aiutare i genitori ad imparare ad essere presenti nel qui ed ora, in modo non giudicante e pienamente consapevoli del proprio bambino;
- Prendersi cura di se stessi;
- Fornire informazioni sul disturbo;
- Accettare le difficoltà del proprio bambino e riorganizzare la sua raffigurazione mentale;
- Rispondere in maniera consapevole ai comportamenti disfunzionali del figlio e non in maniera impulsiva (che abbiamo definito come over-reactivity).
Gli studi sull’ADHD in accompagnamento agli studi sui disturbi psicopatologici dell’età evolutiva (disturbi d’ansia, disturbi della condotta, disturbi del tono dell’umore, disturbi del comportamento alimentare) segnalano la mindfulness in età evolutiva come pratica terapeutica promettente (Fabbro e Muratori, 2012). Nelle ricerche future sarà auspicabile porsi come obbiettivo principale la descrizione dell’utilità e dell’efficacia della Mindfulness nei differenti disturbi neuropsichiatrici dello sviluppo.