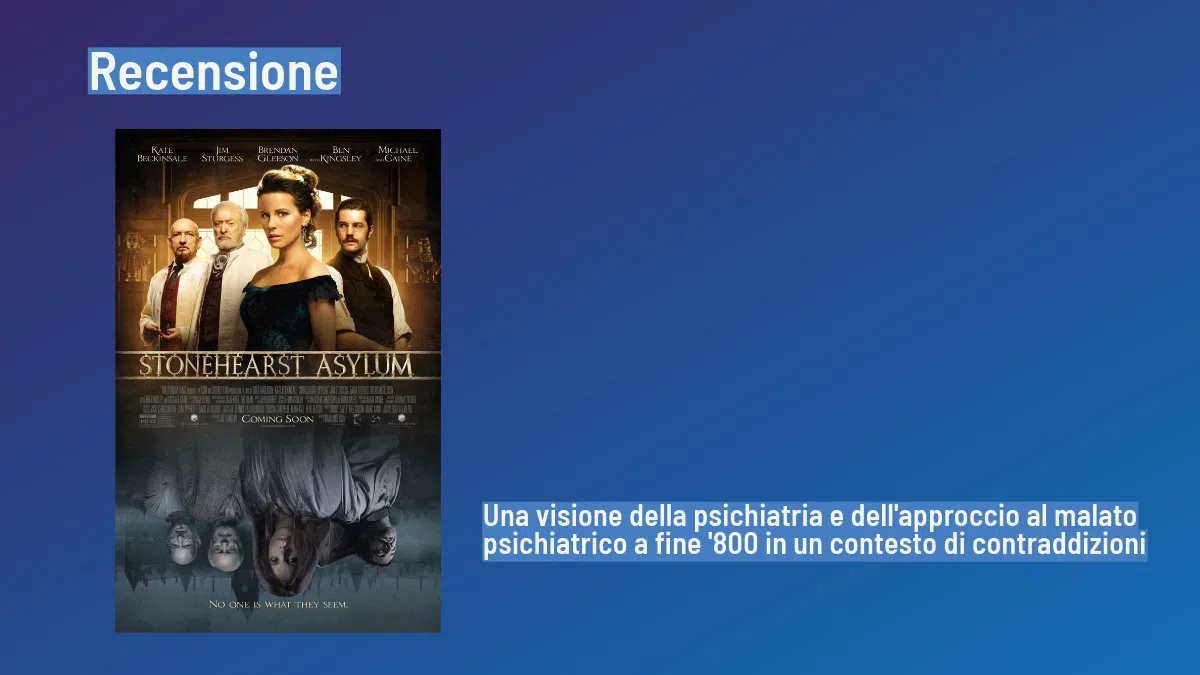Premessa: il contesto storico tra follia e sanità
Siamo verso la fine dell’anno 1899 in Inghilterra, un passaggio di secolo e un periodo storico di grande svolta dal punto di vista clinico in tutta Europa. È proprio il periodo della “scoperta” dell’isteria come disturbo (dal greco hysteron ossia “utero”, perché nella storia greca antica si credeva riguardasse solo l’apparato genitale femminile), da parte di Jean-Martin Charcot, medico neurologo francese. Gli studi portati avanti da Charcot, in Francia, vengono ampliati dai lavori di Pierre Janet, Joseph Breuer e Sigmund Freud, che attraverso la cura delle pazienti, metteranno in rilievo l’esistenza del trauma (o di plurimi trauma) alla base del sintomo manifesto.
Il film Stonehearst Asylum propone una visione storica abbastanza coerente con il periodo di riferimento, puntando i riflettori sulla malattia mentale e sul modo di agire (o forse di reagire) ad essa. Lo spettatore attento può osservare come la trama narrativa del film abilmente lo conduca ad una duplice alleanza: in alcuni momenti ci si identifica con il personale medico (i “curanti”) e in altri si viene catturati dai pazienti e ci si addentra dall’altra parte del cancello, il luogo dove viene costretto il malato, la sola stanza in cui può esprimere la propria personalità, al riparo dallo sguardo giudicante della società. Risulta dunque complicato, almeno inizialmente, comprendere “da che parte stare”, un po’ come si dovesse prendere partito in una vicenda che oscilla in modo complesso. I personaggi principali di Stonehearst Asylum, i protagonisti, sono sicuramente il dottor Silas Lamb (interpretato da Ben Kingsley) medico e direttore del manicomio e il dottor Edward Newgate (interpretato da Jim Sturgess) – medico neolaureato, giunto all’istituto psichiatrico per un apprendistato – che recitando il copione nel copione, l’uno all’oscuro dell’altro, offrono una visione della psichiatria, rivoluzionaria per quell’epoca, dove si rifugge dall’uso di qualsiasi “cura” e il paziente viene inaspettatamente lasciato libero, se non incoraggiato a esprimere la propria “follia”. Il dottor Edward Newgate, con non poco stupore, ha la possibilità di scoprire le procedure impiegate dal direttore che tanto si discostano dalle cure in vigore, e di fare la conoscenza di una paziente, ricoverata per isteria e definita “decisamente pazza”, Eliza Graves (interpretata da Kate Beckinsale), con la quale instaura da subito una particolare affinità. I due cercheranno di prendersi cura l’uno dell’altra, ed accudirsi, al di là del rapporto medico-paziente in un vortice di sguardi fugaci, discorsi segreti e sentimenti celati.
Stonehearst Asylum mette in evidenza da subito le differenze tra correnti e concezioni della malattia mentale che caratterizzavano la psichiatria nell’800. Già nella prima scena vediamo una descrizione dettagliata di quella che all’epoca era chiamata isteria. Un elenco di sintomi e la simulazione di una crisi “innescata” nella paziente da parte del medico alienista (interpretato da un algido Brendan Gleeson) che, per cercare di placare l’aggressività tipica di quelle crisi descritte come “nevrotiche”, utilizza l’eroina (all’epoca inteso come farmaco per curare diverse malattie ma con il tempo considerata illegale vista l’assuefazione che portava nelle persone).
Stonehearts Asylum: dalla malattia alla persona che soffre
Ci si basa unicamente su una diagnosi descrittiva che mira ad assegnare un’etichetta alla psicopatologia del paziente sulla base dei sintomi manifestati. Non c’è alcun interesse scientifico per la persona intesa come individuo nella sua unicità né per la sua storia o per i significati che realmente il paziente attribuisce a ciò che gli sta capitando. La necessità è individuare sintomi sui quali agire per ridurli o eliminarli totalmente. I pazienti del film, tutti dell’alta società del tempo, sono considerati un ”imbarazzo” per le famiglie e la collettività, e devono essere tenuti nascosti all’interno di una struttura, in attesa che quei sintomi vengano meno.
L’unico motivo per cui siamo qui è perché il mondo vuole liberarsi di noi, siamo l’imbarazzo della famiglia, esiliati dalla razza umana, non verremo scoperti perché a nessuno importa di noi (Silas Lamb).
Non si cura la persona ma il sintomo anche a costo di interventi che, alla nostra sensibilità, appaiono umiliazioni terribili inflitte ai pazienti.
Ci hanno spogliati, sottoposti a esami della più disgustosa e intima natura, legati a tavoli, drogati per ottundere i nostri sensi, cosparsi di acqua ghiacciata e lasciati a soffrire (dice Eliza).
Obiettivo del medico è, infatti, scoprire quello che una persona teme di più, per avere la “chiave” della sua follia e poterla controllare, per rimetterla in sesto. Va considerato che le sedie rotanti, le docce al capo, i bagni freddi e gli shock improvvisi furono di moda per un certo periodo, ma dopo il 1840 furono perlopiù abbandonati; nessuno di questi metodi era universalmente accettato nei manicomi. Tuttavia intorno alla fine del secolo, era ormai comunemente accettata l’idea che la pazzia, l’immoralità e la reprensibilità sociale fossero tutte conseguenze di tratti ereditari e che quindi la società aveva il dovere di eliminarle con la sterilizzazione, l’isolamento, la rigorosa educazione e il controllo dell’immigrazione. Le classi più sane dovevano invece essere incoraggiate a riprodursi. Non viene minimamente considerata la dignità e umanità dei pazienti come un diritto personale, perché si ritiene che l’abbiano perduta con la malattia.
Qualcuno già all’epoca però non accettava queste idee e piano piano gettava le basi a una modifica nel modello di cura non basato unicamente sul sintomo ma centrato prevalentemente sulla persona, sulla sua storia e sui significati unici che può attribuirle.
E’ stato all’orfanotrofio che ho capito quale sarebbe stata la mia professione, lavorare con gli sventurati, i reietti e gli infelici per dare a queste povere anime un briciolo di gentilezza e speranza e di tenerezza in un mondo in cui non ce n’è (dice il dott. Newgate).
Si passa perciò da “rimettere in sesto con la forza il malato” a “lavorare con reietti e sventurati”.
Modi differenti di intendere la sofferenza psichica della persona
Nel breve passaggio in cui lo spettatore incontra il paziente che si sente cavallo (13’31’’) si confrontano due modi differenti di intendere il significato della sofferenza psichica. Il tirocinante dr. Newgate chiede al dr. Lamb se abbia abbandonato la missione dell’istituzione medica e cioè “curare [i pazienti] per riportarli alla ragione”. E riceve come risposta immediata: “E tirare fuori un uomo infelice da un cavallo felice?!”. Si intravede qui la differenza tra una realtà oggettiva e necessariamente vera, sotto l’egida della ragione, da perseguire come obiettivo di salute, e la possibilità di conoscere e rispettare il modo “felice” con cui il paziente (cioè ogni persona che può soffrire) costruisce un senso di sé e struttura la sua identità personale attraverso vincoli e opportunità che ha a disposizione, anche mediante il delirio. Nel film, a questo punto, tuttavia non abbiamo delineata alcuna alternativa al dilemma: curare a forza un paziente o lasciarlo “cavallo”, assecondandone e confermandone le idiosincrasie deliranti?
La scena in cui il dottor Newgate si prende cura dell’infermiera, Mrs. Pike, nei sotterranei di Stonehearst Asylum mentre parla di Silas Lamb, in procinto di attuare il suo piano vendicativo nei confronti del personale dell’ospedale psichiatrico, sembra introdurre i concetti di empatia, cooperazione e validazione dell’esperienza dell’altro in terapia. L’infermiera afferma di non aver mai apprezzato i metodi di quel manicomio ma che “non le era permesso criticare”. Si approccia ai pazienti, dicendo di amarli come fossero suoi figli e presenta un modello di pensiero differente da quello imperante nella struttura.
C’è qualcosa di buono anche nel povero Silas… fate brillare la luce della vostra empatia negli angoli più bui della sua mente e forse troverete ciò che lui cerca disperatamente di nascondere a voi e a se stesso… solo allora avrete ciò che vi serve…
Con queste parole Mrs. Pike invita Newgate ad avvicinarsi alla comprensione di Silas Lamb attraverso una sorta di ricostruzione empatica, suggerendo di “…trascorrere del tempo dove lui ha trascorso molto del suo…”. Emerge così un’esortazione al giovane medico a tentare di entrare, in qualche modo, nel mondo dell’altro al fine di provare a comprenderne i significati e promuovere in lui un cambiamento. Questa scena rimanda al tema della ricostruzione dell’esperienza e quindi della conoscenza dal punto di vista dell’individuo che sperimenta e conosce, all’interno di una relazione paritetica e improntata alla collaborazione, tipica dell’ottica cognitivo-costruttivista. Essa si configura come una prospettiva attenta alla persona nella sua complessità e ha come obiettivo ultimo la ricostruzione e articolazione dello specifico significato personale dell’individuo all’interno di una trama narrativa coerente e unitaria. Il tutto si iscrive comunque nell’ambito del cosiddetto “trattamento morale”, tipico di fine XVIII – inizi XIX secolo, in cui si trattavano con rispetto i detenuti dei manicomi psichiatrici, dando loro routine ordinate da seguire ogni giorno. Questo modo più calmo e gentile di interagire con coloro che soffrono di malattie mentali era in netto contrasto con il metodo utilizzato in precedenza, che consisteva nel rinchiudere le persone senza nulla da fare ogni giorno, semplicemente per tenere la loro malattia lontana dagli altri nella società.
Il ritorno ai significati
Non credete a nulla di ciò che ascoltate e solo alla metà di ciò che vedete.
Questa citazione che il medico alienista consegna ai suoi discepoli come linea guida terapeutica nelle prime scene del film, pare mettere in guardia gli studenti di medicina e lo spettatore, invitandoli a dubitare dei loro sensi. Può essere intesa in senso interpretativo-investigativo come un monito a non fidarsi della percezione come fonte di conoscenza, scetticamente e moralisticamente coltivando sfiducia nei resoconti dell’altro, squalificandolo, e intendendo la pazzia come manipolazione e illusionismo. Oppure come un invito a passare attraverso la dimensione empirica e ovvia dei sensi e delle narrazioni, per coglierne un livello più sottile di esperienza, fondamentalmente tacito.
A questo proposito, poco più avanti nella trama del film, arriviamo al personaggio di Arthur, il paziente “orco”. Il dott. Newgate si vede impegnato nel medicare all’interno del suo rifugio questo paziente, assai temuto per il suo sembiante terrificante e il suo fare aggressivo. Nel guidarlo all’approccio con il paziente, il dott. Lamb gli raccomanda di usare gli occhi, dicendogli appunto che altri strumenti, ipoteticamente farmaci o sedativi, non erano necessari.
L’incontro tra i due, inizialmente condotto in modo stereotipo e a rischio per il giovane medico, mostra una svolta sorprendente, riportandoci alla singolarità della relazione terapeutica. Il riconoscimento da parte del dottore del nome del paziente, Arthur, di cui non è rimasta che una traccia di gesso sul muro, porta ad un cambiamento cooperativo nella relazione. Questo contrasta con la “lezione” iniziale dell’alienista, e ci rivela come sia di fondamentale importanza, soprattutto in questo caso specifico, il ritorno ai significati, quelli rilevanti unicamente per il paziente, un senso oltre i sensi, verrebbe da dire. Quei significati che lo identificano e nel quale si riconosce, che rappresentano, in questo caso, la chiave per la fiducia di Arthur.
A questo punto facciamo una sorta di esperimento mentale. Proviamo a pensare di nascere con una “diagnosi di orco” ben cucita sul petto. Proviamo a pensare cosa vuol dire riconoscersi quegli aspetti tipici – non troppo piacevoli – ogni giorno sulla propria persona. Proviamo a pensare di non avere altra via nel riconoscimento di noi stessi. “Quegli aspetti sono il modo in cui gli altri mi riconoscono, mi vedono, come potrebbero non corrispondere a verità? Sono sempre stato così!”. Come gli altri mi hanno detto che ero, con quale sensibilità gli altri significativi mi hanno trattato e da cui ho evinto un’amabilità o meno e a quali condizioni, come gli altri mi hanno o non mi hanno sufficientemente risposto e con quale prontezza. Qui stiamo evocando i concetti di attaccamento, di timing e responsività (sensitive responsiveness) e i Modelli Operativi Interni, messi in rilievo da Bowlby, Ainsworth e collaboratrici (vedi Bibliografia).
Può succedere, tuttavia, che un bel giorno a quella persona quell’etichetta non basti più per riconoscersi. Può succedere che quella persona non voglia più vivere in quel modo e che un giorno si ribelli alla visione che gli altri le danno di sé. E finalmente arriva il momento in cui ci si riconosce qualcosa “in più di” e “oltre a” quello che è sempre stato. Come accade? Forse proprio nelle occasioni di perturbazione e scompenso. Molto probabilmente quel nuovo significato che determina il cambiamento esisteva anche in precedenza, andava “solo” esplorato. Proprio come il nome “Arthur” andava “solo” letto dal dott. Newgate. Spesso si pensa che nel lavoro di un terapeuta ciò che riguarda il “riconoscimento” implichi una diagnosi, riconoscere quindi un gruppo di sintomi adducibili a patologia. Ma è proprio quell’etichetta diagnostica che ci parla di quel paziente o c’è dell’altro? Così come si può incontrare una possibile diagnosi di depressione, egualmente è possibile incontrare una diagnosi di “pecora nera”, di “figlio perfetto”, di “moglie devota” inscritti in un universo che possiamo osservare solo lì, proprio in quel momento, incarnate dal corpo o sulle pareti dell’antro di Arthur.
Terapeuta e paziente, aprono la strada per un ampliamento e un’integrazione di nuovi significati possibili, che permettono di andare “oltre” quella visione stretta del proprio sé. Quegli “strumenti” che non sono utili secondo il dott. Lamb, forse sono proprio quelli che ci allontanano, come terapeuti, dal vedere quella persona nella sua totalità e complessità.
Si delinea così una nuova ottica del concetto di terapia, in cui i sensi, il corpo, i significati e la relazione di reciprocità sono linee guida dell’incontro, che avviene tra cambiamento e continuità, coerenza e processo.
Il dottor Lamb, “nelle vesti” di direttore della clinica, rifiuta quelli che lui definisce “metodi di repressione”, a favore di approcci nuovi e insoliti nei confronti dei pazienti: questi sono liberi di essere ciò che desiderano, di partecipare attivamente alla vita della clinica senza essere sottoposti a cure mediche sedanti e invasive che li renderebbero sicuramente assenti e incoscienti, come vegetali. Edward Newgate, “nelle vesti” di giovane psichiatra approda in questo contesto innovativo, con il desiderio di apprendere e sperimentarsi nella professione, e con la speranza di poter alleggerire le sofferenze dei pazienti, restituendo loro un po’ di umanità. Il giovane medico, girando tra le stanze di Stonehearst Asylum per prestare il suo aiuto ai sofferenti, incontra una signora molto anziana che rifiuta categoricamente di nutrirsi. Newgate si avvicina per cercare di aiutarla a mangiare ma presto capisce quanto il rifiuto del cibo sia legato al figlio amato, morto durante la guerra. Ma in che modo? In che modo sono collegati madre, figlio e cibo?
”Tramite il cordone ombelicale, non vedete come mi attraversa? Passa da quella finestra laggiù… è la fuori a combattere gli Afgani”.
Il giovane apprendista medico, ascolta con dedizione le parole della signora, non giudica e non demonizza quello che potrebbe connotarsi come un vero e proprio delirio, ma lo accoglie e lo valida. Con gentilezza ed empatia entra nel “mondo dei significati” dell’anziana signora e, rivolgendosi a lei come se fosse suo figlio, in prima persona le propone: “Non vorrete che muoia di fame, vero madre”? … Non importa quanto grande sarà la distanza… sarete sempre nei miei pensieri”. E ancora: “Temo di dover andare nuovamente all’estero…il cibo è molto scarso lì, ho bisogno che vi nutriate per entrambi: Lo farete per me?“. Il legame è validato e trasformato in modo viabile per la sopravvivenza della signora e di se stesso.
Nell’approccio empatico del giovane psichiatra traspare anche qui una forte vicinanza con il modello cognitivo–costruttivista. Secondo questo modello non esiste una realtà oggettivamente data, uguale per tutti, una “normalità” a cui ci si dovrebbe adattare, bensì un flusso di percezioni ricostruito in base ai significati personali che ciascuna persona ha e con cui attribuisce senso agli eventi: “del resto tutto ha infatti un senso nella mente di chi lo pensa”. Nel caso dell’anziana signora quello che possiamo definire come “delirio”, rappresenta probabilmente l’unico modo per lei possibile di mantenere un legame con la persona amata e per sopravvivere alla morte di un figlio: “le persone reagiscono in un certo modo per mantenere il proprio equilibrio”. Il giovane dottor Newgate, come un inconsapevole terapeuta costruttivista, aiuta la sua paziente a fornirsi di “nuove lenti” con cui guardare gli eventi (il figlio deve partire in missione e ha bisogno di cibo), integrabili e coerenti col senso di sé e un nuovo significato che riarmonizza, attraverso la nutrizione, sopravvivenza, accudimento e mantenimento della relazione.
Il riemergere del trauma tra dissociazione e scompenso
Due momenti drammatici nel film danno modo di evidenziare la dimensione dissociativa (cfr. Farina e Liotti 2018), facendo perno su due differenti sistemi motivazionali interpersonali, strettamente interconnessi: Attaccamento e Accudimento (cfr. Liotti, 2005)
La dissociazione prorompe in maniera vivida nel momento in cui Mikey Finn, durante la festa di fine anno, aggredisce la piccola Millie, con l’intento di abusarne sessualmente. In tale situazione, infatti, Mikey vive pienamente l’attivazione di un sistema relazionale di tipo predatorio che si confà al suo modo di essere ed è quindi coerente con la narrazione tacita che lui fa di sé e del mondo. Tuttavia, qualcosa inceppa questo ingranaggio. L’affetto inaspettato che Finn riceve dalla ragazza diviene infatti per lui deflagrante, in quanto riporta alla coscienza elementi dissociati insopportabili. A quel punto, la rabbia che tali elementi suscitano nell’uomo lo acceca al punto tale da uccidere la povera sventurata. Ma perché tali esperienze richiamate dalla inaspettata reazione di Millie, che si pone fuori da un copione già scritto nella mente di Finn, sono così intollerabili? Non lo sappiamo, ma alcuni indizi nel film possono consentirne una spiegazione. Mikey era stato rinchiuso nel manicomio in quanto reo di aver ucciso la madre in preda ad un attacco di violenza incontrollabile. Questo può suggerire che egli stesso fosse stato oggetto di violenza fin da bambino, e che avesse di conseguenza elaborato un sistema basato sull’esclusione difensiva (cfr. Bowlby, 1989) verso le esperienze di attaccamento alla figura materna, che immaginiamo violenta e abusante. A tali forme di violenza si sarebbero certamente associate condotte più consone alla madre, inducendo nel figlio l’impossibilità di fidarsi del genitore, e di conseguenza di chiunque gli avesse mostrato affetto. L’attaccamento è stato quindi escluso dalle possibili tonalità emotive, perché rischioso e inaffidabile, e sostituito da altre modalità di interazione più efficaci in quel contesto violento (cfr. Liotti, Farina, 2011). Ecco che l’affetto accudente di Millie fa rivivere a Finn la paura della violenza da parte della madre, e invece di evocare una risposta analoga, lo istiga alla violenza più cieca.
Un secondo momento, uno dei centri narrativi di Stonehearts Asylum, è la dissociazione del grande “cattivo” del film, Silas Lamb. Egli ha compartimentato gli avvenimenti che lo hanno portato alla “follia”, ovvero l’esser venuto meno al suo giuramento come medico di tutelare i soldati affidati alle sue cure, da lui addirittura uccisi come atto di paradossale pietà e di liberazione dal dolore. Qui è la capacità di accudire che viene messa in discussione, quasi annientando lo stesso fulcro di significato del sé di Lamb. Quasi, appunto. La terribile esperienza vissuta, infatti, è stata completamente esclusa dalla coscienza dell’ormai ex chirurgo militare, in quanto troppo dolorosa, e riversata in un delirio di onnipotenza in cui egli sarà capace di curare la follia con metodi di sua invenzione. A tale delirio è funzionale l’antagonismo ferreo e inflessibile verso i metodi “tradizionali” e verso la figura di riferimento che accudisce i malati, il “vero” primario, il dottor Salt, contro cui Lamb scatenerà tutta la sua ira, rendendolo a sua volta folle. L’ultimo baluardo a difesa del nucleo intimo del sé di Lamb viene scardinato quando il giovane Newgate, per salvare la distruzione della propria mente, lo espone al ricordo dei poveri soldati uccisi, rendendo inefficiente e mandando in frantumi la compartimentazione protettiva che questi si era eretto. La contesa tra i due avversari (Lamb e Salt) si compone forzatamente ai silenziosi bordi di una scacchiera, dove i due in qualche modo si fronteggiano di nuovo in una partita a scacchi letteralmente demenziale, cioè tra esclusi dalla propria mente.
Da una partita a una partenza: continuità e cambiamento
Alla fine del film, a cavallo tra commedia e tragedia, possiamo trovare in un certo senso lo svelamento degli inizi, l’implicito che i sensi tacciono o dicono solo a metà. Si può considerarlo come una partita a scacchi durante la quale i vari personaggi (Elisa, Edward, Silas, il dottor Newgate “anagrafico” e Colui che ne ha rubato l’identità, il marito della signora Graves, Mickey Finn…), tra sfide, aperture e chiusure, finzioni e autoinganni, giocano e vincono o perdono, muovendo e impersonando, in un certo senso, i pezzi della scacchiera. Ognuno segue una specie di copione che li precede e da cui procedono, coerentemente. La partita del film propone vari capovolgimenti di fronte e funziona nel modo atteso finché tutti i partecipanti stanno alle regole della competizione, che è giocare posizionandosi nello spazio-tempo-relazione predeterminata e rimanendo fedeli ad essa. La serie di mosse e contromosse nel film Stonehearst Asylum conduce a un inevitabile “scacco matto” in cui le regole del gioco vengono confermate. Proprio in questo punto, però, si apre l’inattesa fuoriuscita dal copione, che la parola chess-mate! (scacco matto!), esclamata da Lamb nella partita con Salt, nasconde ed esprime. Il gioco obbligato con le sue regole competitive (di rango e umiliazione, di potere, rivalsa e cura coatta) veicolava la pazzia come determinismo fino al blocco di ogni mossa. Ora, esaurita la sua funzione, fornisce nella relazione tra i partecipanti (chess-mate, appunto) un confine e una “nuova porta” (una “newgate”!) per procedere altrove. Questo salto verso un nuovo equilibrio è proposto, ci pare, dal film in un doppio aspetto di differenza e continuità: i due amanti (Eliza ed Edward) trovano una nuova vita altrove, posizionandosi in un luogo, ambiente e relazioni differenti da quelle di dominio, violenza e prepotenza sperimentate, e connotate da angoscia e impotenza, abbracciando il loro amore reciproco (e qui sta la differenza). Fanno tutto questo, però, attribuendosi come nuovo nome di coppia “Lamb”, quasi a significare un’eredità nella follia, necessaria per sopravvivere, per non sentirsi un guscio vuoto e per recuperare una continuità con le proprie radici come coppia e come individui.