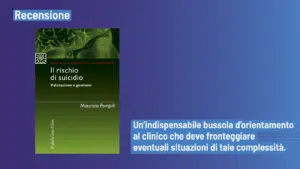Il suicidio, scrive Pompili nel libro “Il rischio di suicidio”, va inteso non tanto come “desiderio di morte”, quanto come soluzione specifica di cessazione del proprio stato di coscienza e, pertanto, interruzione di un dolore mentale insopportabile.
L’autore prende in considerazione varie prospettive inerenti lo studio delle dinamiche suicidarie, soffermandosi sulla psicodinamica, accennando ad approcci filosofici, sociologici, giuridici e a come questi approcci si interconnettano e forniscano risorse molto utili nella valutazione e formulazione del rischio di suicidio.
Da un punto di vista psicodinamico, Pompili (2022), fa spesso riferimento a Shneidemen e alla concettualizzazione proposta da questo autore. Ciò che caratterizza il suo approccio, è l’attenzione che viene posta sugli “stati mentali” e sul presupposto che il dolore mentale sia alla base del fenomeno suicidario. L’autore fa riferimento ad un dolore mentale intollerabile, ad un tale livello di “angoscia esistenziale”, che spinge il soggetto a sentirsi “costretto” e “ristretto” in una “visione a tunnel”. Si va quindi gradualmente sedimentandosi e irrigidendosi la convinzione che vi siano davvero poche opzioni per far fronte alla sofferenza sperimentata. Secondo Charmet (2009), la “fantasia suicidaria” viene lentamente coltivata nel tempo e rappresenta un “segreto” che può essere custodito con molta cura per anni, con la relativa convinzione, rinforzata da ostacoli evolutivi percepiti come “insormontabili”, che la morte possa offrire più possibilità realizzative della vita, che si possa finalmente trionfare su “stati mentali” rigidi e coatti di rabbia impotente, umiliazione, intrappolamento, sconfitta, sentimenti di inaiutabilità da parte degli altri e “inaccessibilità” ad un mondo vissuto come un “muro”, ad un “altro” vissuto come ostile e rifiutante, ad un corpo sentito come “una prigione”.
Pompili (2022) sostiene come questi individui percepiscano che la propria vita sia ingiusta rispetto a quella di altre persone e quanto sia prevalente la fantasia, derivante da un sentimento di vendetta (come se dicessero a se stessi: “Che faccia faranno adesso?”), che sarà possibile osservare l’angoscia di coloro che vedranno il corpo esanime. Alla base del sentimento centrale di soggetti a rischio di suicidio vi è “un odio per se stessi”, una mente dominata da “ideali dell’io crudeli, sadici” che lo spingono a sentirsi “inadeguato”, “in difetto”, con un senso di “incolmabilità” rispetto a “come si dovrebbe essere”, ad aspettative irrealistiche su di sé. C’è una forma di fanatismo in questo, un bisogno di vendetta su sentimenti di “offesa”, “ingiustizia” costantemente sperimentati. L’aggressività non è integrata con gli obiettivi maturi dell’io ma, al contrario, vi è un accanimento al servizio di un “sé grandioso ed arcaico”, che non trova pace finché non ha scovato e cancellato il nemico. Vuole uccidere i carcerieri per ottenere la libertà. Il nemico è interno, vi è quindi un “attacco al corpo”, ad un’immagine di sé inadeguata rispetto ad una grandiosità irremovibile insaziabile. La vergogna è un altro sentimento centrale. Lancini (2020), nella propria esperienza, come psicoterapeuta, con gli adolescenti, riporta quanto sia preponderante il senso di inadeguatezza, quanto la vitalità del corpo sia pericolosa per loro, una vitalità che porta con sé il rischio che si sentano esposti ad un fallimento senza gli spazi potenziali e riparativi forniti da “comunità educative”. Un conto infatti è il corpo idealizzato, un conto è il corpo evolutivo, vulnerabile, esposto al costante cambiamento.
Il suicidio, scrive Pompili, va inteso non tanto come “desiderio di morte”, quanto come soluzione specifica (dettata da una modalità prevalente di pensiero dicotomico) di cessazione del proprio stato di coscienza e, pertanto, interruzione di un dolore mentale insopportabile (Pompili, 2022, p.161).
Altro importante aspetto argomentato da Pompili (2022), è rappresentato dalla “valutazione e formulazione” del rischio di suicidio. La valutazione del rischio comporta la raccolta di dati riguardanti la presenza e/o l’assenza di fattori di rischio e di protezione, ma anche di segnali di allarme. La formulazione del rischio, invece si fonda sulle modalità in cui i fattori di rischio si combinano tra loro, si alimentano o vengono arginate dai fattori di protezione e, in questo, l’individuazione dei segnali di allarme che aumentano il rischio a breve termine. Tra i fattori di rischio, si possono annoverare quelli distali, cronici o anche detti duraturi (come, ad esempio, eventi infantili avversi, l’esordio o il peggioramento di un disturbo psichiatrico) e quelli prossimali, presenti nel breve termine e che possono notevolmente incidere sul livello di sofferenza dell’individuo (più facilmente riconducibili, in termini di spazio e di tempo, al suicidio, come vissuti di umiliazione, perdite significative, vergogna dovuta a situazioni di grande impatto emotivo). Per esempio, la presenza di ansia, agitazione, insonnia, e sentimenti di disperazione, originati da situazioni presenti avverse, rappresenta un fattore di rischio prossimale che, se mal gestito, può rivelarsi pericoloso in soggetti con fattori di rischio distali (personalità perfezionistiche improntate ad una maggiore rigidità e sensibilità a rifiuti e potenziali sconfitte sono senza dubbio foriere di maggiori criticità). I fattori di protezione sono invece rappresentati dalla presenza di un valido sostegno familiare, dalla percezione di una “base sicura” nelle relazioni significative, da attività creative e ricreative che possano facilitare la presenza di aree intermedie di esperienza tra il mondo interno e l’esterno e quindi favorire l’espressione di sé.
In tutto questo, è importante esplorare come si manifesta l’ideazione suicidaria attuale e quindi come si concretizza il desiderio di morire nel “qui ed ora”, come si esplicita rispetto al passato, e se è accompagnata da un’intenzione suicidaria. Nell’intenzione suicidaria, il soggetto ha già provveduto ad organizzare alcuni particolari relativi al “piano di suicidio”. Pompili (2022), scrive: “È importante esplorare e indagare qualsiasi atto preparatorio compiuto dal paziente, come sistemare i propri affari, fare ricerche sui metodi di suicidio, oppure fare prove su come compiere l’atto”. Possono risultare inoltre utili i segnali di allarme che, al contrario dei fattori di rischio, sono episodici e variabili (comportamenti preparatori, pensieri, cambiamenti di umore repentini, ansia, agitazione, insonnia), che, se contestualizzati e interconnessi in una formulazione accurata, possono costituire ulteriori validi elementi nel valutare la “concretizzazione del desiderio di morire”.
Altro aspetto trattato riguarda il tema della “responsabilità del clinico”. In particolare, Pompili (2022) rimanda ad una dimensione che allenti il potere dato a credenze “salvifiche e onnipotenti”, in cui il clinico possa leggere nella mente del paziente suicida, che alimentano modelli accusatori nei confronti del clinico e deresponsabilizzanti nei confronti del paziente, concepito come un individuo totalmente dipendente dal medico. I survivors (ovvero familiari o relazioni intime del paziente deceduto), alle prese con sentimenti di vergogna, colpa, impotenza, possono attuare meccanismi di proiezione e spostamento della colpa all’esterno del proprio contesto. In particolare, Pompili (2022) fa riferimento all’importanza del coinvolgimento e accoglienza della famiglia durante il percorso terapeutico e anche dopo l’eventuale decesso del paziente. L’inclusione della famiglia e l’alleanza con il nucleo familiare del paziente rappresenta un’importante risorsa, in quanto stimola la collaborazione, la responsabilità verso se stessi e verso l’altro e, nondimeno, viene incoraggiato un movimento di legittimazione verso le percezioni reciproche. In caso di decesso del paziente, sentimenti di tradimento da parte sia del terapeuta, sia della famiglia, possono essere molto intensi. Il terapeuta, spinto da un forte “senso di inadeguatezza”, dalla rabbia verso se stesso, dalla convinzione di “non aver fatto abbastanza”, potrebbe pertanto mettere in atto meccanismi di evitamento-fuga, lasciando la famiglia sola, abbandonata, spingendo inconsapevolmente quest’ultima ad ulteriori acting-out controfobici con azioni legali di rivalsa.
A tutela della cornice terapeutica, dell’efficacia della stessa e della responsabilità del terapeuta, è importante che egli segua i principi indicati nello “standard of care” menzionato all’interno del testo. Tra questi vi è l’importanza di una documentazione clinica accurata, delle linee guida per la valutazione e la formulazione del rischio, del consenso informato, e, in questo, della valutazione dell’integrità delle funzioni cognitive, di orientamento spazio-temporale e dello stato di coscienza del paziente, che consentano quindi a quest’ultimo di poter collaborare e, nondimeno, comprendere gli elementi salienti del consenso.
Altra dimensione abbracciata dall’autore è quella dei sentimenti controtransferali del terapeuta nei confronti di pazienti a rischio suicidario. Si è parlato della centralità del sentimento dell’odio verso se stessi nel vissuto di questi soggetti, e quanto ciò alimenti una “visione a tunnel” con la concomitante percezione di “intrappolamento”. La condizione quasi magica di “inaiutabilità” in cui il soggetto si pone esprime nondimeno l’impotenza derivante da quelli che da lui vengono percepiti come ostacoli insormontabili nel mondo esterno. Odio che può essere rivolto verso il terapeuta e verso le relazioni significative. Il paziente inoltre può esercitare una pressione interpersonale più o meno coercitiva e manipolatoria, affinché l’odio che sente verso se stesso e verso gli altri venga introiettato dal terapeuta e agito (attraverso il meccanismo dell’identificazione proiettiva). Il terapeuta può avere reazioni controtransferali, in cui si sente insicuro, inadeguato nel tipo di aiuto che sta fornendo, può perdere l’autostima e, di conseguenza, agire ciò che viene negato dal paziente stesso, l’inimicizia verso se stesso. Il terapeuta può oscillare da una posizione salvifica, in cui si sente spinto a fare sempre di più per il paziente, spinto da irrequietezza, ansia, a stati di noia e sonnolenza. Può arrivare ad agire, ad es. attraverso sbadigli, segni di disattenzione che comunicano rifiuto e alimentano ulteriori comportamenti di fuga. Il terapeuta, attraverso il meccanismo della formazione reattiva, può anche trasformare l’odio nel suo opposto, trovandosi pertanto spinto in un circolo di fantasie salvifiche-onnipotenti. Nel testo, viene menzionata la tecnica di Galynker, che invita a porsi domande dirette rispetto ad emozioni e comportamenti del terapeuta e del clinico. Per esempio “Lo vedo più frequentemente e per sedute più lunghe rispetto ad altri pazienti?”; “ Mi fa sentire bene con me stesso?” (Pompili, 2022, p.136). Queste ed altre domande indicate nel testo, suggeriscono la presenza della “formazione reattiva”. Altre domande, invece, suggeriscono che sia in atto la difesa della negazione come ad esempio: “Rispondo alle sue domande meno tempestivamente di quanto dovrei?”; “Mi sento con le mani legate?”; “Mi sento svalutato?”( Pompili, 2022, p.136).
La cornice supportiva di riferimento per uno psicoterapeuta che lavora con pazienti a rischio di suicidio è quindi, come già accennato, attenersi alle linee guida per lo “standard of care” e, elemento non meno importante, l’accompagnamento di un supervisore senior. La presenza di quest’ultimo è nondimeno importante nelle fasi post-intervento, e quindi anche nei casi in cui il paziente sia deceduto. Pompili (2022) scrive: “Il paziente mette alla prova e sfida il clinico circa la sua capacità e disponibilità. Solo l’atteggiamento accogliente del terapeuta verso il paziente e verso se stesso, attraverso un’empatia che comprenda i tre tipi descritti in appendice (empatia affettiva, cognitiva e motivazionale), favorisce l’inizio di una conversazione: “Permettimi di capire meglio la tua sofferenza, al fine di ridurla”“(Pompili, 2022, p.169).