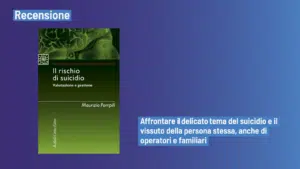Nelle note introduttive del volume “Il rischio di suicidio” l’autore chiarisce come il testo offra una visione completa delle problematiche connesse ai principali aspetti del rischio suicidario e della sua prevenzione, ma correttamente mette in guardia da considerarlo una sorta di linea-guida applicabile in tutte le situazioni cliniche che richiamano il suicidio.
Il tema è troppo delicato e la casistica inevitabilmente troppo varia per potersi concedere delle semplificazioni. Piuttosto, esso si propone di favorire anche con il supporto di una documentazione clinica, un dibattito multidisciplinare tra esperti, al fine di scongiurare valutazioni inappropriate e riduzionistiche. Il libro, comunque, grazie ad un adeguato approfondimento storico e teorico, fornisce un’indispensabile bussola d’orientamento al clinico che deve fronteggiare eventuali situazioni di tale complessità. Esso offre anche una panoramica su tecniche di base con cui condurre un colloquio o produrre una valutazione più attenta del rischio di suicidio. Si tratta di un tema che merita grande approfondimento in quanto il comportamento suicidario pone diversi interrogativi al clinico, così come è anche innegabile che talvolta di fronte ad esso si produca un atteggiamento evitante, anche da parte degli specialisti.
L’autore del volume è Maurizio Pompili, professore ordinario di Psichiatria presso l’Università Sapienza di Roma e direttore UOC di Psichiatria presso l’A.O.U. Sant’Andrea di Roma. Ha già pubblicato diversi altri testi sullo stesso tema ed è considerato uno dei maggiori esperti italiani in tale ambito di ricerca. Difatti, è componente dell’Executive Committee dell’I.A.S.P. (International Association for Suicide Prevention).
Riguardo alle vicende storiche, colpisce apprendere che prima del 1630 la parola “suicidio” non era in uso e l’atto di togliersi la vita era equiparato ad un assassinio. Fino al 1800, il reo veniva definito autore di un crimine contro se stesso e i suoi beni potevano essere confiscati o subire altro genere di sanzioni. La valutazione, nel tempo divenuta sempre più condivisa, di considerare “folle” tale gesto è servita anche a mitigare gli effetti sanzionatori, con una miscela di misericordia o severità, che si è alternata nella trattazione dei diversi casi. Questo atteggiamento sociale spiega perché lo psichiatra sia diventato lo specialista di riferimento e si sia creata un’associazione logica tra suicidio e disturbo mentale che, come le ricerche statistiche più recenti mostrano, è effettivamente pertinente, ma solo in una percentuale relativa di situazioni.
Nel primo capitolo sono riassunti in cornice i diversi approcci utilizzati nel corso dei secoli nel tentativo di dare un senso al suicidio. Si parte dall’approccio filosofico e teologico, con il pensiero di S. Agostino; l’approccio letterario, con le descrizioni proposte da poeti e scrittori; si passa all’approccio demografico, sociologico e socioculturale, per comprendere l’entità del fenomeno nelle varie epoche e nei diversi contesti, oltre che nelle sue possibili determinanti sociali, vedi il contributo di Durkheim; l’approccio biologico per giungere all’approccio interpersonale e più propriamente psicologico. Freud sviluppò solo negli anni 1915-17 una propria ipotesi sul suicidio, a partire dal presupposto che la sofferenza di fronte alla perdita di un oggetto amato o di una persona alla quale si era legati si può rivelare impossibile da accettare da parte dell’Io, al punto che l’individuo può giungere a introiettare l’oggetto perso. In seguito, per punire l’oggetto perso ma introiettato, l’aggressività può rivolgersi a se stesso, sino alle conseguenze estreme.
L’approccio di Shneidman (1993), fondatore della suicidologia, ha posto finalmente il dolore mentale in primo piano, ponendo le basi per una concettualizzazione secondo cui i soggetti non desiderano la morte, bensì ricercano l’allontanamento da un dolore vissuto come insopportabile e da una vita percepita come non degna di essere vissuta. Con questa prospettiva, si mette in primo piano anche la ricerca che l’individuo compie sempre delle opzioni potenzialmente capaci di ridurre la sofferenza, in quanto è proprio la loro drammatica assenza a far assumere come risolutiva la tragica opzione del suicidio. Dal punto di vista del clinico, quindi, diventa essenziale enfatizzare proprio l’importanza di tali opzioni alternative, senza banalizzare l’entità del dolore mentale, ma invitando la persona ad una ricerca più approfondita delle alternative esistenziali che possano scongiurare il rischio suicidario. In questa ricerca si dovrebbe sempre tentare di mobilizzare i legami di appartenenza e le risorse affettive presenti in ambito familiare. In un altro articolo, anche Vannotti e Gennart (2022) sottolineano come il rischio suicidario sia fortemente connesso alla riduzione del senso di appartenenza dell’individuo al proprio contesto relazionale e confermano l’opportunità di coinvolgere la famiglia nel percorso psicoterapico.
Inoltre, un intero capitolo è dedicato all’autopsia psicologica, ovvero il metodo, nato in ambito medico-legale negli Stati Uniti, finalizzato alla comprensione della mente suicida, per chiarire nei casi di morti ambigue, se si sia trattato effettivamente di suicidio. Essa comporta una serie di interviste a persone che avevano relazioni significative con il defunto e l’analisi di documenti rilevanti per la valutazione psicologica. Shneidman metteva in guardia dal rischio di confondere tale procedura psicologica con un’indagine investigativa che, per quanto complessa, si sofferma su tutt’altro genere di fattori. Essa dovrebbe essere obiettiva, proprio come l’autopsia medica, e costituire uno strumento di supporto al magistrato e non un contributo di parte.