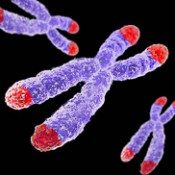Sam, un amico virtuale per i bambini autistici

Gli ultimi dati raccolti dagli esperti confermano che circa la metà dei soggetti affetti da autismo possiedono buone capacità intellettive, ma mantengono serie difficoltà di adattamento negli ambienti sociali e lavorativi a causa della grave compromissione delle loro abilità di interagire e comunicare con gli altri.
I trattamenti comportamentali si sono dimostrati efficaci soprattutto nell’incrementare il potenziale intellettivo degli individui con autismo ma con più fatica sono stati in grado di promuovere le carenti abilità sociali.
Una risposta a tale esigenza arriva dalla realtà virtuale e si chiama Sam, un individuo dal rassicurante aspetto di un bambino di 8 anni, che si è dimostrato capace di favorire la messa in atto di comportamenti interattivi e comunicativi da parte dei compagni di gioco affetti da disturbi dello spettro autistico.
Justine Cassell, dirigente del Center for Technology and Social Behavior della Northwestern University, e il suo gruppo di ricerca hanno osservato sei bambini autistici ad alto funzionamento, di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, giocare per un’ora sia con un bambino reale che con Sam.
L’analisi di tali interazioni ha evidenziato un incrementale utilizzo di frasi legate alla situazione specifica nella sessione di gioco con il pari virtuale, mentre tale utilizzo di frasi contingenti non aumentava quando il soggetto autistico interagiva con il bambino reale.
La felice scoperta non sta certo nell’aver individuato nel bambino virtuale il perfetto compagno di giochi per bambini che presentano carenze nell’area delle abilità sociali, ma nella possibilità di aiutare questi bambini a generalizzare le abilità di interazione apprese nelle realtà virtuale al contesto di vita reale. La sfida ovviamente sarà capire come!
Tra i principali motivi che inducono i bambini autistici ad una maggiore apertura nei confronti del pari virtuale sembrano esserci la sua infinita pazienza e la capacità di non mostrare mai segnali di noia nel giocare con l’amico autistico. Le sue conversazioni, il suo comportamento e il suo modo di apparire possono inoltre essere programmati così da favorire determinati comportamenti sociali e sollecitare l’interesse nel bambino che gioca con lui.
In attesa che Sam sbarchi anche Italia, le persone coinvolte a vario titolo nel trattamento dell’autismo potrebbero cominciare già a trarre da lui qualche utile spunto per insegnare a tutti coloro che interagiscono con i bambini affetti da tale disturbo un po’ di quella infinita pazienza e amore incondizionato dimostrato da Sam.
Fonti e bibliografia:
ScienceDaily – Mar. 8, 2008
www.psychcentral.com – Mar. 21, 2011
Howlin P., Baron-Cohen S. e Hadwin J., (1999) Teaching children with autism to mind-read, John Wiley & Sons Ltd



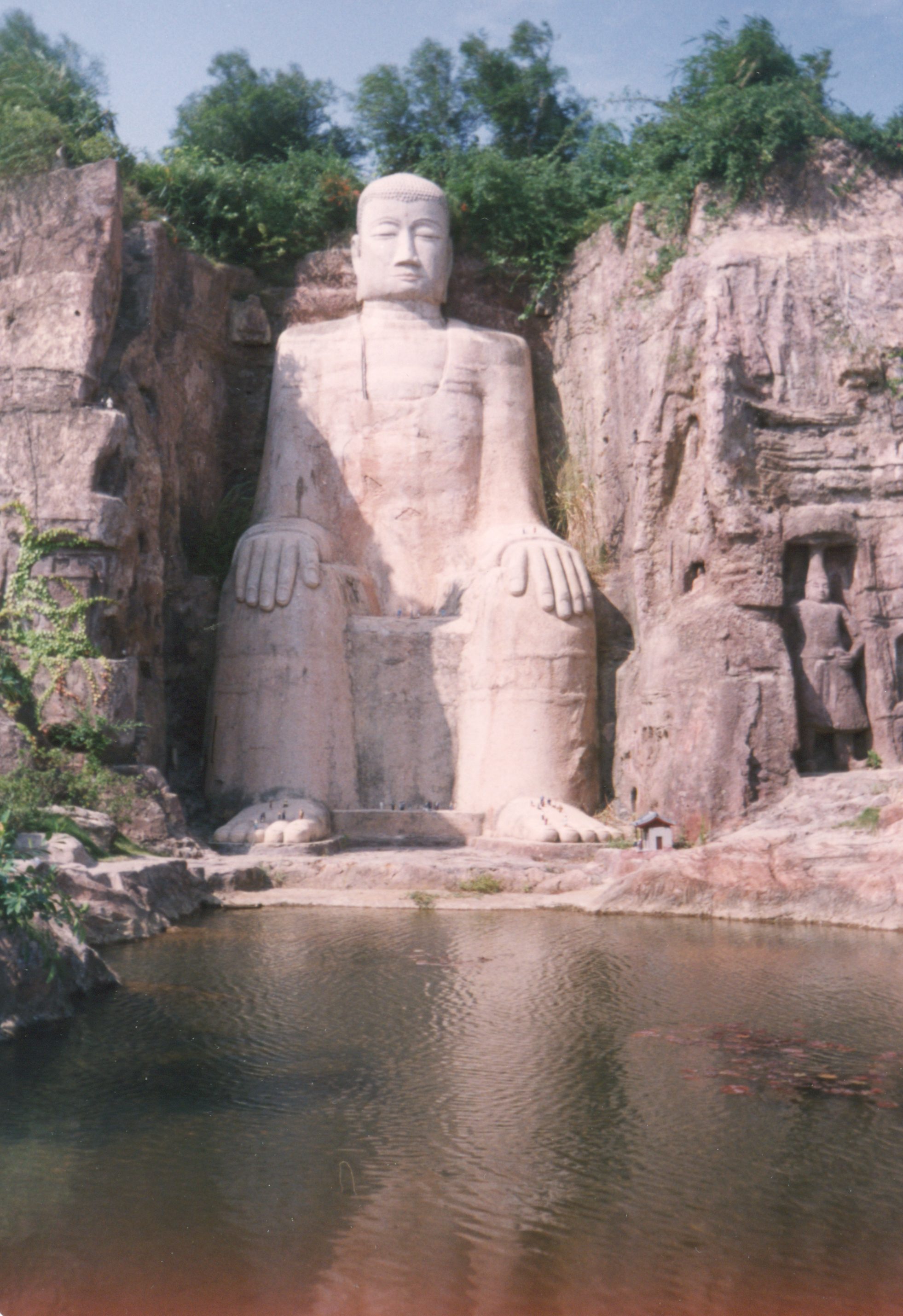 La mindfulness è da molti anni uno strumento terapeutico la cui efficacia è oggetto di verifica rigorosa. È ormai dimostrato che la pratica costante della mindfulness riduce di circa il 50% il rischio delle ricadute depressive. Inoltre, chi nella vita ha avuto più di un episodio depressivo, con la mindfulness potrebbe arrivare a prevenire le ricadute addirittura del 70% circa. I due protocolli terapeutici elaborati da Segal e colleghi, e poi rivisti e adattati da molti altri nel mondo, sono il MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) e la MBCT (Mindfulness- Based Cognitive Therapy). Al di là di questi due programmi, però, sembra efficace e opportuno inserire degli interventi di mindfulness all’interno di percorsi psicoterapici più complessi e “vestiti” sul singolo paziente.
La mindfulness è da molti anni uno strumento terapeutico la cui efficacia è oggetto di verifica rigorosa. È ormai dimostrato che la pratica costante della mindfulness riduce di circa il 50% il rischio delle ricadute depressive. Inoltre, chi nella vita ha avuto più di un episodio depressivo, con la mindfulness potrebbe arrivare a prevenire le ricadute addirittura del 70% circa. I due protocolli terapeutici elaborati da Segal e colleghi, e poi rivisti e adattati da molti altri nel mondo, sono il MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) e la MBCT (Mindfulness- Based Cognitive Therapy). Al di là di questi due programmi, però, sembra efficace e opportuno inserire degli interventi di mindfulness all’interno di percorsi psicoterapici più complessi e “vestiti” sul singolo paziente.