Your First Day of School will be Scary!
Parents’ words and anxiety disorders – part 4
 Up to this point in the series, I have discussed why it is so important to further understanding of the development of anxiety disorders in children. I have also touched on the importance of various types of parenting styles which may increase the development of anxiety in children. As I explained,parental discussions regarding unfamiliar situations or objects can increase their children avoidance. But why are some discussions doing this and not others? Surely the differences of a few words cannot change the development of our children in either the short or long term, could it? For the answer to these questions we turn to the experimental psychopathology literature.
Up to this point in the series, I have discussed why it is so important to further understanding of the development of anxiety disorders in children. I have also touched on the importance of various types of parenting styles which may increase the development of anxiety in children. As I explained,parental discussions regarding unfamiliar situations or objects can increase their children avoidance. But why are some discussions doing this and not others? Surely the differences of a few words cannot change the development of our children in either the short or long term, could it? For the answer to these questions we turn to the experimental psychopathology literature.
A series of studies has investigated the transfer of information as a pathway to fear. One study asked children to perform a behavioral task involving novel animals, but first, children were read either positive, neutral or negative stories regarding the animals. Those children presented with negative stories showed a significant increase whereas those presented with positive stories showed a significant decrease. Those presented with no information showed no change during the behavioral task (Field & Lawson, 2003). One study used the same design; however, the experimenters presented information about social fear beliefs not novel animals. The study showed that children provided with negative information about uncommon social interactions showed increased social fear beliefs (Field, Lawson & Manerjee, 2008). Therefore, it appears that specific positive and negative information can change the way that children behave not only with novel non-social objects, such as animals, but it can also change the way they behave socially.
While these findings are interesting, further examination of literature using similar methods shed more light on the importance of other aspects of information transfer. Research has also shown that even after six months time, when presented with negative information, children still show behavioral avoidance. This finding was the strongest for those children between six and eight years old (Field, Lawson & Manerjee, 2008). But what about the source of information? Well it appears that the effect of negative information has the largest effect when it is presented to a child by an adult, rather than a peer or a non-informative control source (Field, Argyris & Knowles, 2001).
Thus it appears that specific positive or negative information does influence the behavior of children. In the next installment in the series I will be further discussing the effect of maternal psychopathology and child anxiety on mother-child conversations.
BIBLIOGRAPHY:
- Field, A. P., & Lawson, J. (2003). Fear information and the development of fears during childhood: Effects on implicit fear responses and behavioral avoidance. Behavior Research and Therapy, 41, 1277 – 1293.
- Field, A. P., Lawson, J., & Banerjee, R. (2008). The verbal threat information pathway to fear in children: The longitudinal effects on fear cognitions and the immediate effects on avoidance behavior. Journal of Abnormal Psychology, 117, 1, 214 – 224.
- Field, A. P., Argyris, N. G., & Knowles, K. A. (2001). Who‟s afraid of the big bad wolf: A prospective paradigm to test Rachman‟s indirect pathways in children. Behavior Research and Therapy, 39, 1259 – 1276.
| READ ALSO: | – Part 1 – | Part 2 – | Part 3
|




 Economia mentale: dimenticare serve a ricordare.
Economia mentale: dimenticare serve a ricordare. Leggiamo sul volume settembrino di
Leggiamo sul volume settembrino di  Mi sono fatta questa domanda al ritorno dal mio secondo Forum di Assisi, un evento pensato e organizzato per i giovani psicoterapeuti in Formazione che hanno voglia di fare ricerca, e che si conclude con la premiazione dei lavori più meritevoli.
Mi sono fatta questa domanda al ritorno dal mio secondo Forum di Assisi, un evento pensato e organizzato per i giovani psicoterapeuti in Formazione che hanno voglia di fare ricerca, e che si conclude con la premiazione dei lavori più meritevoli. Com’è strutturato il servizio nel quale lavora?
Com’è strutturato il servizio nel quale lavora? Nella giornata del 15 ottobre del forum di Assisi mi hanno colpito due presentazioni, entrambe dedicate ai disturbi alimentari. Le ricordo per la loro originalità, e ne riporto alcune impressioni. La prima era di Eleonora Dovera e Giuseppe Pantaleo e esplorava alcune variabili di solito trascurate nei disturbi alimentari: la sfiducia interpersonale e l’ascetismo, che naturalmente non è l’ascetismo religioso ma una variabile cognitiva e comportamentale definita da David Garner negli anni ’80 e che indica la tendenza delle pazienti con disturbo alimentare a compiacersi del loro elevato grado di autocontrollo alimentare.
Nella giornata del 15 ottobre del forum di Assisi mi hanno colpito due presentazioni, entrambe dedicate ai disturbi alimentari. Le ricordo per la loro originalità, e ne riporto alcune impressioni. La prima era di Eleonora Dovera e Giuseppe Pantaleo e esplorava alcune variabili di solito trascurate nei disturbi alimentari: la sfiducia interpersonale e l’ascetismo, che naturalmente non è l’ascetismo religioso ma una variabile cognitiva e comportamentale definita da David Garner negli anni ’80 e che indica la tendenza delle pazienti con disturbo alimentare a compiacersi del loro elevato grado di autocontrollo alimentare. Il romanzo narra il progressivo sgretolamento di una mente, di una personalità, quella del soccombente appunto, che dedica ogni risorsa vitale allo studio del pianoforte con l’obiettivo di diventare non un pianista, non un grande pianista e nemmeno uno dei più grandi concertisti, bensì il più inarrivabile interprete del secolo. Il protagonista dell’opera ha studiato a Salisburgo sotto l’insegnamento del genio Horowitz e suo compagno di viaggio è stato un altro pianista la cui morte per suicidio è precedente al tempo della narrazione. Il tema che unisce i due personaggi è l’incontro con Glenn Gould, che da allievo di Horowitz diventerà…Glenn Gould, spalancando agli altri il dramma di non saper eguagliare le sue esecuzioni.
Il romanzo narra il progressivo sgretolamento di una mente, di una personalità, quella del soccombente appunto, che dedica ogni risorsa vitale allo studio del pianoforte con l’obiettivo di diventare non un pianista, non un grande pianista e nemmeno uno dei più grandi concertisti, bensì il più inarrivabile interprete del secolo. Il protagonista dell’opera ha studiato a Salisburgo sotto l’insegnamento del genio Horowitz e suo compagno di viaggio è stato un altro pianista la cui morte per suicidio è precedente al tempo della narrazione. Il tema che unisce i due personaggi è l’incontro con Glenn Gould, che da allievo di Horowitz diventerà…Glenn Gould, spalancando agli altri il dramma di non saper eguagliare le sue esecuzioni.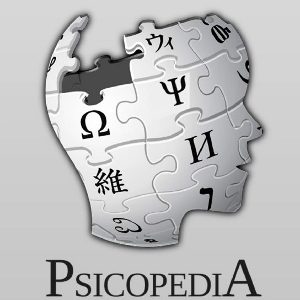 Sempre più conosciuta e praticata sia in psicoterapia cognitiva sia in contesti molto differenti, dalla formazione dei manager allo sport, la mindfulness è una forma di meditazione applicabile all’attività clinica. La mindfullness è una pratica di attenzione consapevole, intenzionale, non-giudicante nel momento presente”. Jon Kabat-Zinn, primo al mondo a portare la mindfulness nel contesto psicoterapico, dice che per nutrire il terreno del nostro atteggiamento, affinché la nostra pratica della consapevolezza possa crescere rigogliosa e fiorire, dobbiamo coltivare sette atteggiamenti: non giudizio, pazienza, la “mente del principiante” (essere disposti a guardare ogni cosa come se la vedessimo per la prima volta), fiducia, non cercare risultati, accettazione, lasciare andare, impegno nella pratica e visione di ciò che si desidera per se stessi. Negli ultimi venticinque anni la mindfulness è stata efficacemente applicata su diverse psicopatologie. Esempi? depressione, disturbi d’ansia, disturbo ossessivo-compulsivo, post-traumatico da stress, dipendenze, dolore cronico e fibromialgie, solo per citarne alcune.
Sempre più conosciuta e praticata sia in psicoterapia cognitiva sia in contesti molto differenti, dalla formazione dei manager allo sport, la mindfulness è una forma di meditazione applicabile all’attività clinica. La mindfullness è una pratica di attenzione consapevole, intenzionale, non-giudicante nel momento presente”. Jon Kabat-Zinn, primo al mondo a portare la mindfulness nel contesto psicoterapico, dice che per nutrire il terreno del nostro atteggiamento, affinché la nostra pratica della consapevolezza possa crescere rigogliosa e fiorire, dobbiamo coltivare sette atteggiamenti: non giudizio, pazienza, la “mente del principiante” (essere disposti a guardare ogni cosa come se la vedessimo per la prima volta), fiducia, non cercare risultati, accettazione, lasciare andare, impegno nella pratica e visione di ciò che si desidera per se stessi. Negli ultimi venticinque anni la mindfulness è stata efficacemente applicata su diverse psicopatologie. Esempi? depressione, disturbi d’ansia, disturbo ossessivo-compulsivo, post-traumatico da stress, dipendenze, dolore cronico e fibromialgie, solo per citarne alcune. Qualche anno fa un crudele Corrado Guzzanti sapeva prendere in giro quel partito che allora si chiamava “Casa delle Libertà”. E come? Sottolineando come appunto, nella Casa delle Libertà, ognuno fa un po’ come gli pare. Contraddittorio con la fede di sinistra di Guzzanti? Possibile. Ma aveva ragione: non c’è libertà senza regole. E poi, come diceva Whitman, che importa contraddirsi? “Mi contraddico? Certo che mi contraddico! Sono grande, contengo moltitudini”.
Qualche anno fa un crudele Corrado Guzzanti sapeva prendere in giro quel partito che allora si chiamava “Casa delle Libertà”. E come? Sottolineando come appunto, nella Casa delle Libertà, ognuno fa un po’ come gli pare. Contraddittorio con la fede di sinistra di Guzzanti? Possibile. Ma aveva ragione: non c’è libertà senza regole. E poi, come diceva Whitman, che importa contraddirsi? “Mi contraddico? Certo che mi contraddico! Sono grande, contengo moltitudini”.  Come giustamente cantano i Daft Punk, Television Rules the Nation. Il duopolio televisivo concentrato e controllato dal potere centrale restituisce un’immagine a dir poco parziale della situazione del paese, i quotidiani -con la sola eccezione de
Come giustamente cantano i Daft Punk, Television Rules the Nation. Il duopolio televisivo concentrato e controllato dal potere centrale restituisce un’immagine a dir poco parziale della situazione del paese, i quotidiani -con la sola eccezione de 
 Il modello cognitivo considera l’ansia come il risultato di un’incapacità, più forte in alcune persone, di tollerare emozioni negative intense e spiega le strategie utilizzate per evitarle come importanti fattori di mantenimento del disturbo. In quest’ottica il rimuginio ansioso (worry) costituisce uno dei principali strumenti dell’ “evitamento emotivo”: chi rimugina ritiene che pensare continuamente a possibili conseguenze negative aiuti a generare nuove soluzioni per prevenirle o per prepararsi al loro inevitabile verificarsi. “Staccare” da quel pensiero, seppur intrusivo e spesso disturbante, è vissuto in modo terrifico e perciò costantemente evitato. Il rimuginio ha inoltre un effetto calmante a breve termine sull’attivazione neurovegetativa (tachicardia, sudorazione, pressione alta,..) legata all’ansia (Borkovec, Alcaine, & Behar, 2004): l’immediato sollievo del corpo rinforza, di nuovo, la credenza che rimuginare aiuti a tenere sotto controllo le emozioni!
Il modello cognitivo considera l’ansia come il risultato di un’incapacità, più forte in alcune persone, di tollerare emozioni negative intense e spiega le strategie utilizzate per evitarle come importanti fattori di mantenimento del disturbo. In quest’ottica il rimuginio ansioso (worry) costituisce uno dei principali strumenti dell’ “evitamento emotivo”: chi rimugina ritiene che pensare continuamente a possibili conseguenze negative aiuti a generare nuove soluzioni per prevenirle o per prepararsi al loro inevitabile verificarsi. “Staccare” da quel pensiero, seppur intrusivo e spesso disturbante, è vissuto in modo terrifico e perciò costantemente evitato. Il rimuginio ha inoltre un effetto calmante a breve termine sull’attivazione neurovegetativa (tachicardia, sudorazione, pressione alta,..) legata all’ansia (Borkovec, Alcaine, & Behar, 2004): l’immediato sollievo del corpo rinforza, di nuovo, la credenza che rimuginare aiuti a tenere sotto controllo le emozioni!