Rassegna Stampa: 13-11-2011
 Donne bisessuali a maggior rischio di depressione e abuso alcolico rispetto a uomini bisessuali
Donne bisessuali a maggior rischio di depressione e abuso alcolico rispetto a uomini bisessuali
Le donne bisessuali sarebbero a maggior rischio di depressione e abuso alcolico rispetto ai maschi bisessuali, secondo quanto emerge da uno studio nazionale condotto presso la George Mason University dalla ricercatrice Lisa Lindley. Lo studio, pubblicato su American Journal of Public Health considera tre diverse dimensioni della sessualità, nello specifico identità, comportamento e attrazione, andando a studiarne il legame con diverse variabili legate al benessere e alla salute.
In particolare, il rischio di sviluppare forme di depressione e abuso alcolico è elevato in misura simile durante l’adolescenza per maschi e femmine bisessuali, mentre nell’età adulta tale rischio sembrerebbe ridursi per i maschi ma non per le femmine di orientamento bisessuale. Interessante punto nello studio è anche il risultato secondo cui le donne bisessuali presenterebbero un tale elevato profilo di rischio non riscontrato invece nelle donne prettamente omosessuali.
Dare supporto sociale fa bene sia a chi lo dà che a chi lo riceve.
Un nuovo studio di brain-imaging condotto presso la Univeristy of California Los Angeles da Naomi Eisenberg e colleghi dimostra come il fornire supporto sociale e aiuto agli altri fa bene non solo a chi lo riceve ma anche a chi lo dà. Gli autori hanno coinvolto nella ricerca 20 coppie eterosessuali con buon funzionamento relazionale e hanno sottoposto le 20 donne a risonanza magnetica funzionale per identificare le aree di attivazione a livello cerebrale mentre i loro fidanzati ricevevano brevi ma dolorosi shock elettrici proprio di fianco a loro. Le partners sono state divise in due gruppi sperimentali: un primo gruppo aveva la possibilità di tenere per mano il proprio compagno mentre subiva shock elettrici, mentre un secondo gruppo doveva limitarsi a guardarlo ma senza potergli fornire un minimo supporto. Dai risultati è emerso che le donne che effettivamente fornivano supporto ai loro fidanzati durante l’esperienza dolorosa, mostravano un incremento di attivazione nelle regioni cerebrali relative alla ricompensa, quali lo striato ventrale. In particolare, è stata rilevata una correlazione tra l’intensità del sentimento di vicinanza soggettivamente riportato dalle partners e l’intensità dell’attivazione di tale area cerebrale. Di conseguenza, se il fornire supporto sociale attiva tali aree della ricompensa, attive anche durante l’attività sessuale o guadagni economici, significa che l’attività del dare supporto agli altri viene processata al pari di altre esperienze di piacere e ricompensa. Lo studio è pubblicato nell’attuale numero di Psychosomatic Medicin.
Padri depressi e influenze sui figli
Non più solo madri depresse nel mirino. I bambini che vivono vicino ai loro papà depressi avrebbero maggiori probabilità di sviluppare problemi emotivi e comportamentali rispetto ai loro pari. Questo è l’esito di uno studio condotto da Michael Weitzman, professore di pediatria e psichiatria presso la New York University School of Medicine, pubblicato il 7 Novembre sulla rivista Pediatrics. A fronte delle ampie documentazioni degli effetti negativi di disturbi psicologico-psichiatrici materni sul benessere dei figli, per la prima volta viene dimostrato che vivere insieme a padri depressi è correlato con una maggiore frequenza di problemi emotivi e comportamentali nei figli. Lo studio ha coinvolto un campione di ben 22,000 bambini e relativi genitori. “Questi risultati stimolano a porsi questioni di grande rilevanza” scrive Weitzman “riguardo alle modalità di sviluppo e implementazione di strategie volte a facilitare l’identificazione e l’eventuale intervento nei confronti di padri alle prese con disturbi depressivi”.
Razionalità vs. irrazionalità nel decidere di questioni economiche
 Un recentissimo studio pubblicato mercoledi 9 Novembre su PloS ONE ha dimostrato che solo un ristretto numero di persone si comporta in modo più razionale rispetto alla maggioranza quando ha a che fare con questioni di soldi. La maggior parte delle persone si comporterebbe invece in modo irrazionale. L’autore leader dello studio Wim De Neys ricercatore del National Center for Scientific Research (CNRS) in Francia, insieme al proprio gruppo di ricerca, ha analizzato il comportamento dei partecipanti coinvolti in un gioco in cui i concorrenti devono negoziare, proporre e accettare offerte di denaro. La best practice “razionale” prevista dai modelli economici, prevede che il primo giocatore offra una somma modesta di denaro al secondo giocatore, il quale, secondo una logica razionale dovrebbe accettare l’offerta sulla base del principio “sempre meglio di niente”. Tuttavia la maggior parte delle persone agisce in modo differente: il primo giocatore offre spesso una divisione equa della somma; d’altro canto il secondo giocatore generalmente rifiuta l’offerta di una divisione non equa. Soltanto un ristretto numero di persone si comportano in accordo con le previsioni razionali dei modelli economici, accettando quindi anche l’offerta di somme esigue di denaro. Ulteriori indagini su questo ristretto gruppi di “razionali” hanno dimostrato che tali individui presentano un elevato “controllo cognitivo” valutato mediante il compito comportamentale (Go/No-Go performance) e mediante specifici indici di attivazione neurale rispetto agli individui meno razionali. Di conseguenza i decision-makers che presentano maggiori indici di controllo cognitivo e razionalità hanno più probabilità di massimizzare i loro guadagni monetari rispetto ai decision-makers con scarsi punteggi di controllo cognitivo.
Un recentissimo studio pubblicato mercoledi 9 Novembre su PloS ONE ha dimostrato che solo un ristretto numero di persone si comporta in modo più razionale rispetto alla maggioranza quando ha a che fare con questioni di soldi. La maggior parte delle persone si comporterebbe invece in modo irrazionale. L’autore leader dello studio Wim De Neys ricercatore del National Center for Scientific Research (CNRS) in Francia, insieme al proprio gruppo di ricerca, ha analizzato il comportamento dei partecipanti coinvolti in un gioco in cui i concorrenti devono negoziare, proporre e accettare offerte di denaro. La best practice “razionale” prevista dai modelli economici, prevede che il primo giocatore offra una somma modesta di denaro al secondo giocatore, il quale, secondo una logica razionale dovrebbe accettare l’offerta sulla base del principio “sempre meglio di niente”. Tuttavia la maggior parte delle persone agisce in modo differente: il primo giocatore offre spesso una divisione equa della somma; d’altro canto il secondo giocatore generalmente rifiuta l’offerta di una divisione non equa. Soltanto un ristretto numero di persone si comportano in accordo con le previsioni razionali dei modelli economici, accettando quindi anche l’offerta di somme esigue di denaro. Ulteriori indagini su questo ristretto gruppi di “razionali” hanno dimostrato che tali individui presentano un elevato “controllo cognitivo” valutato mediante il compito comportamentale (Go/No-Go performance) e mediante specifici indici di attivazione neurale rispetto agli individui meno razionali. Di conseguenza i decision-makers che presentano maggiori indici di controllo cognitivo e razionalità hanno più probabilità di massimizzare i loro guadagni monetari rispetto ai decision-makers con scarsi punteggi di controllo cognitivo.
Leggi anche: Cognitivismo ed Economia



 Poiché notoriamente “chi di spada ferisce, di spada perisce” come suggerì Gesù al focoso Pietro, confuso evidentemente dal fatto che lui stesso aveva precedentemente detto di essere venuto a portare la spada (Cristo,mettiamoci d’accordo una buona volta!). prima o poi doveva toccarmi questa sorta di abiura galileiana. Non c’è momento migliore per riparare al mio peccato che il ritiro nel ricovero per i poveri infermi costruito da Bernardino da Siena in quel di Barga, enclave fiorentina nella lucchesia, nel 1456, esattamente 400 anni prima della nascita di Sigmund Freud.
Poiché notoriamente “chi di spada ferisce, di spada perisce” come suggerì Gesù al focoso Pietro, confuso evidentemente dal fatto che lui stesso aveva precedentemente detto di essere venuto a portare la spada (Cristo,mettiamoci d’accordo una buona volta!). prima o poi doveva toccarmi questa sorta di abiura galileiana. Non c’è momento migliore per riparare al mio peccato che il ritiro nel ricovero per i poveri infermi costruito da Bernardino da Siena in quel di Barga, enclave fiorentina nella lucchesia, nel 1456, esattamente 400 anni prima della nascita di Sigmund Freud.
 In una recente ricerca della
In una recente ricerca della  Un bambino può apprendere a parlare bene senza conoscere, esplicitamente, le regole grammaticali ma non può parlare bene senza applicare corettamente queste regole. Un alunno può imparare senza che gli sia stato spiegato cos’è la metacognizione, però non può essere davvero efficace nel proprio apprendimento se non lavora metacognitivamente: se non conosce le differenza tra sapere e non sapere, tra memorizzazione e comprensione, se non “impara ad imparare”.
Un bambino può apprendere a parlare bene senza conoscere, esplicitamente, le regole grammaticali ma non può parlare bene senza applicare corettamente queste regole. Un alunno può imparare senza che gli sia stato spiegato cos’è la metacognizione, però non può essere davvero efficace nel proprio apprendimento se non lavora metacognitivamente: se non conosce le differenza tra sapere e non sapere, tra memorizzazione e comprensione, se non “impara ad imparare”.  Siamo forse giunti all’epilogo della carriera politica di Berlusconi, per alcuni un’epopea per altri un incubo lungo 17 anni. Tralascio molti altri aspetti di questa parabola e mi dedico all’analisi del sogno italiano di copiare i modelli sociali americani. Un’analisi poco freudiana e molto personale.
Siamo forse giunti all’epilogo della carriera politica di Berlusconi, per alcuni un’epopea per altri un incubo lungo 17 anni. Tralascio molti altri aspetti di questa parabola e mi dedico all’analisi del sogno italiano di copiare i modelli sociali americani. Un’analisi poco freudiana e molto personale.  Non si tratta del delirio florido di uno psicotico, ma è il risultato di studio della Keele University’s School of Psychology (Gran Bretagna), secondo cui le persone che imprecano riescono a tollerare il dolore fisico più a lungo rispetto a quelli che non dicono parolacce, in risposta ad un forte trauma o ad una disavventura.
Non si tratta del delirio florido di uno psicotico, ma è il risultato di studio della Keele University’s School of Psychology (Gran Bretagna), secondo cui le persone che imprecano riescono a tollerare il dolore fisico più a lungo rispetto a quelli che non dicono parolacce, in risposta ad un forte trauma o ad una disavventura. 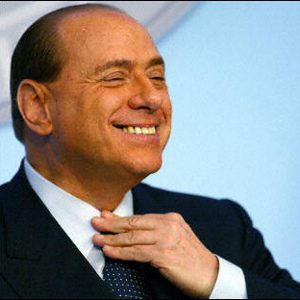 Chiusa, o quasi, la lenta agonia di Berlusconi, ci si chiede perché un uomo che sulla carta dominava Parlamento, Esecutivo e Comunicazioni, primo, secondo e quarto potere, si sia dimostrato così poco incisivo nel muovere le leve del potere. Capace di conquistarlo e di conservarlo, ma poco di usarlo, questo potere. La spiegazione più semplice è che non gli interessasse, in fondo, fare politica. A Berlusconi non interessava governare, ma controllare il potere per proteggere i propri interessi. È la spiegazione più feroce e becera, ma per ora mettiamola da parte…
Chiusa, o quasi, la lenta agonia di Berlusconi, ci si chiede perché un uomo che sulla carta dominava Parlamento, Esecutivo e Comunicazioni, primo, secondo e quarto potere, si sia dimostrato così poco incisivo nel muovere le leve del potere. Capace di conquistarlo e di conservarlo, ma poco di usarlo, questo potere. La spiegazione più semplice è che non gli interessasse, in fondo, fare politica. A Berlusconi non interessava governare, ma controllare il potere per proteggere i propri interessi. È la spiegazione più feroce e becera, ma per ora mettiamola da parte…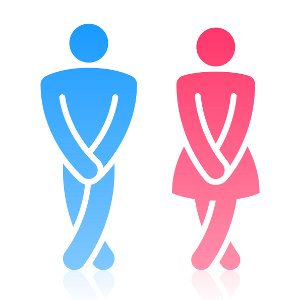 Se la vostra risposta fosse positiva, allora concordate su quanto ottenuto nella seguente ricerca in cui si dimostra che l’urgente bisogno di urinare può farvi prendere decisioni migliori in certi campi, e peggiori in altri.
Se la vostra risposta fosse positiva, allora concordate su quanto ottenuto nella seguente ricerca in cui si dimostra che l’urgente bisogno di urinare può farvi prendere decisioni migliori in certi campi, e peggiori in altri.  La pratica della mindfulness ci insegna molte cose in termini di consapevolezza e di “presenza” a noi stessi ma ci mostra anche come il respiro sia un “ancora di aggancio” per imparare a notare i nostri pensieri e le nostre emozioni e non rimanervi impantanati, ritenendoli la verità assoluta e non un prodotto della nostra mente.
La pratica della mindfulness ci insegna molte cose in termini di consapevolezza e di “presenza” a noi stessi ma ci mostra anche come il respiro sia un “ancora di aggancio” per imparare a notare i nostri pensieri e le nostre emozioni e non rimanervi impantanati, ritenendoli la verità assoluta e non un prodotto della nostra mente.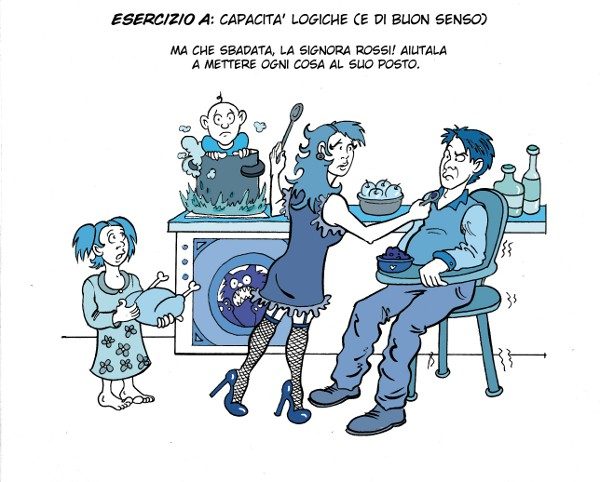
 Copertina 1: Elisa Sednaoui, dall’alto del suo vestito da sposa semitrasparente (sembra un po’ la sposa cadavere), con in mano guantoni di gomma e spazzolone per pulire, ci ricorda:
Copertina 1: Elisa Sednaoui, dall’alto del suo vestito da sposa semitrasparente (sembra un po’ la sposa cadavere), con in mano guantoni di gomma e spazzolone per pulire, ci ricorda: Seconda copertina: “Sono una mamma e mi sento ancora più donna”.
Seconda copertina: “Sono una mamma e mi sento ancora più donna”. L’ultima copertina (se vogliamo sceglierci come amica Irina Shayk) recita: Amo gli animali. Devo proprio rinunciare alle pellicce? E poi spiega: “Le persone che si scandalizzano per le pellicce spesso dimenticano le scarpe di cuoio che stanno calzando in quel preciso istante. Questa sì che è una contraddizione”. Con la stessa stringente logica con cui si potrebbe sostenere che siccome in alcuni stati esiste la pena di morte allora va benissimo andare in giro ad ammazzare la gente. Anche perché, in fondo, disprezzare i problemi legati all’ambiente è così cool al giorno d’oggi. Soprattutto in un posto come l’Italia, evidentemente situato all’interno del circolo polare artico, per cui, come per gli Inuit, usare una pelliccia è praticamente una questione di sopravvivenza.
L’ultima copertina (se vogliamo sceglierci come amica Irina Shayk) recita: Amo gli animali. Devo proprio rinunciare alle pellicce? E poi spiega: “Le persone che si scandalizzano per le pellicce spesso dimenticano le scarpe di cuoio che stanno calzando in quel preciso istante. Questa sì che è una contraddizione”. Con la stessa stringente logica con cui si potrebbe sostenere che siccome in alcuni stati esiste la pena di morte allora va benissimo andare in giro ad ammazzare la gente. Anche perché, in fondo, disprezzare i problemi legati all’ambiente è così cool al giorno d’oggi. Soprattutto in un posto come l’Italia, evidentemente situato all’interno del circolo polare artico, per cui, come per gli Inuit, usare una pelliccia è praticamente una questione di sopravvivenza. 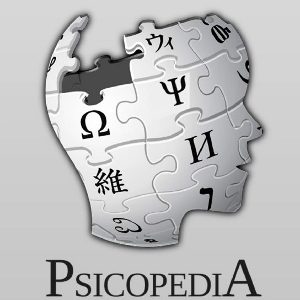 Arousal
Arousal Mi è accaduto negli ultimi tempi di radunare parecchie riflessioni attinenti sia dalla pratica clinica sia da quanto ascoltato nelle parole di amici e conoscenti che hanno intrapreso una terapia; altra fonte di ispirazione assai fertile, la mia esperienza personale di paziente. Ebbene vi è
Mi è accaduto negli ultimi tempi di radunare parecchie riflessioni attinenti sia dalla pratica clinica sia da quanto ascoltato nelle parole di amici e conoscenti che hanno intrapreso una terapia; altra fonte di ispirazione assai fertile, la mia esperienza personale di paziente. Ebbene vi è 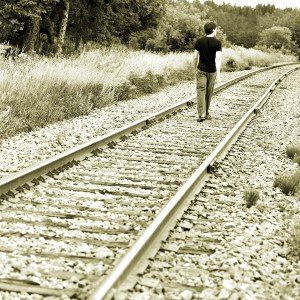 Qualche giorno fa mi è capitato di vedere in televisione un dibattito in occasione del compleanno delle gemelline Schepp scomparse lo scorso Febbraio. Ricordiamo che delle due bambine di 6 anni si è persa traccia dopo il suicidio del padre alla stazione di Cerignola, in Puglia. Uno dei temi centrali della discussione riguardava la figura paterna: uomo distinto, laureato, mai dato segni di squilibrio, al di sopra di ogni sospetto, tanto che la ex moglie gli aveva permesso di portare via le figlie per qualche tempo. La domanda chiave veniva ripresa più volte dagli ospiti della trasmissione: è possibile che quest’uomo non avesse mai dato un qualche segno di instabilità, debolezza, di stranezza? È possibile che fosse ritenuto affidabile e responsabile e un minuto dopo compiva un atto del genere?
Qualche giorno fa mi è capitato di vedere in televisione un dibattito in occasione del compleanno delle gemelline Schepp scomparse lo scorso Febbraio. Ricordiamo che delle due bambine di 6 anni si è persa traccia dopo il suicidio del padre alla stazione di Cerignola, in Puglia. Uno dei temi centrali della discussione riguardava la figura paterna: uomo distinto, laureato, mai dato segni di squilibrio, al di sopra di ogni sospetto, tanto che la ex moglie gli aveva permesso di portare via le figlie per qualche tempo. La domanda chiave veniva ripresa più volte dagli ospiti della trasmissione: è possibile che quest’uomo non avesse mai dato un qualche segno di instabilità, debolezza, di stranezza? È possibile che fosse ritenuto affidabile e responsabile e un minuto dopo compiva un atto del genere? Circa il 28% della popolazione almeno una volta nella vita sperimenta un occasionale ed inaspettato attacco di panico, tuttavia solo nel 3-5-% della popolazione insorge il terrore di poterlo sperimentare nuovamente. Terrore che a sua volta innesca il circolo vizioso dell’ansia fino a dare origine a un Disturbo da Attacchi di Panico. Questo disturbo è caratterizzato dalla presenza di attacchi di panico che, sebbene durino pochi minuti, provocano un disagio molto intenso e possono lasciare l’individuo prostrato per molte ore. Questo disturbo, se non curato, non solo tende a cronicizzarsi rapidamente, ma riduce anche l’autonomia personale, l’efficienza lavorativa e scolastica, la qualità della vita compromettendo le relazioni familiari e sociali di chi ne è affetto.
Circa il 28% della popolazione almeno una volta nella vita sperimenta un occasionale ed inaspettato attacco di panico, tuttavia solo nel 3-5-% della popolazione insorge il terrore di poterlo sperimentare nuovamente. Terrore che a sua volta innesca il circolo vizioso dell’ansia fino a dare origine a un Disturbo da Attacchi di Panico. Questo disturbo è caratterizzato dalla presenza di attacchi di panico che, sebbene durino pochi minuti, provocano un disagio molto intenso e possono lasciare l’individuo prostrato per molte ore. Questo disturbo, se non curato, non solo tende a cronicizzarsi rapidamente, ma riduce anche l’autonomia personale, l’efficienza lavorativa e scolastica, la qualità della vita compromettendo le relazioni familiari e sociali di chi ne è affetto.