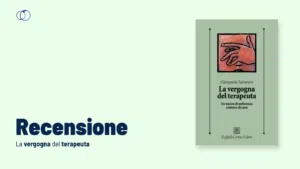La vulnerabilità nella stanza di psicoterapia secondo Giampaolo Salvatore
Nel silenzio della stanza di psicoterapia, c’è un’emozione che raramente trova voce. È la vergogna. Non quella del paziente, che spesso si lascia intuire tra i racconti e gli sguardi bassi. Ma quella del terapeuta. Una vergogna più sottile e più nascosta. Ed è proprio da qui che Giampaolo Salvatore decide di cominciare, nel suo libro La vergogna del terapeuta, edito da Raffaello Cortina. E da lì, non si ferma più.
Salvatore, già noto per il suo contributo nell’ambito della psicoterapia cognitiva evoluzionista influenzata da Giovanni Liotti e per la sua partecipazione alla costruzione del modello metacognitivo interpersonale (MIT) elaborato da Antonio Semerari e poi da Giancarlo Dimaggio, compie nel libro La vergogna del terapeuta una sorta di uscita dall’ombra. Con sensibilità clinica, mette in discussione il ruolo del terapeuta come figura regolativa, asimmetricamente forte, per proporre una visione più emotivamente vulnerabile del lavoro psicoterapeutico e ancor più relazionale, se possibile, di quella di Dimaggio.
La vergogna del terapeuta (2023): l’eredità del cognitivismo relazionale
Chi ha seguito il percorso della psicoterapia italiana degli ultimi trent’anni da Guidano e Liotti in poi riconoscerà in queste pagine una tensione che parte da lontano. Salvatore si è formato con i maestri del cognitivismo relazionale italiano. Da Giovanni Liotti ha imparato che il trauma non è solo un evento, ma una frattura relazionale che disgrega il sé; la terapia è un luogo di holding e riparazione affettiva. Da Antonio Semerari ha ereditato l’attenzione al funzionamento della mente, alle funzioni metacognitive, all’equilibrio tra consapevolezza e autoregolazione. Da Giancarlo Dimaggio, infine, ha accolto la dimensione narrativa ed esperienziale del sé, incarnata e dinamica, dove il terapeuta entra in gioco come co-autore della storia del paziente.
Eppure, tutto questo non bastava. Qualcosa continuava a mancare. La proposta di Salvatore è che quel qualcosa fosse proprio il terapeuta stesso. Non come costrutto tecnico, non come funzione clinica, ma come persona. Come essere umano che, dentro la relazione terapeutica, non solo guida, sostiene, riflette, ma anche sente. E può fallire. E provare vergogna.
La forza del libro La vergogna del terapeuta sta qui: nel portare alla luce ciò che di solito si tace. La vergogna del terapeuta diventa, in queste pagine, non un errore, non un ostacolo, ma una chiave preziosa. Un segnale da ascoltare, una finestra aperta sull’autenticità della relazione clinica. Invece di combatterla o nasconderla, Salvatore ci invita ad abitarla. A chiederci cosa dice di noi, cosa dice del paziente, cosa dice di quella relazione, in quel momento.
Ed è proprio in questo spostamento, in questa centratura sull’incontro emotivo tra due soggettività vulnerabili, che il libro La vergogna del terapeuta di Salvatore si rivela – nel bene e nel male – l’esito più coerente e radicale del pensiero di Giovanni Liotti e, più in generale, della tradizione del cognitivismo relazionale italiano. È il compimento naturale di una linea teorica che ha progressivamente messo al centro la relazione terapeutica come luogo primario della trasformazione, anziché come contenitore tecnico o cornice operativa.
Ma questa coerenza porta con sé anche una tensione irrisolta. Nel dare voce alla soggettività del terapeuta, nel restituirgli umanità e vulnerabilità, il libro rischia – come tutti e anzi più di tutti i suoi predecessori – di svalutare l’aspetto tecnico della psicoterapia. Il metodo, la struttura, la competenza, sembrano farsi da parte, in favore di un’etica dell’incontro, di una terapeuticità che nasce dall’essere-con, piuttosto che dal sapere-come. È una scelta deliberata che vuole opporsi al tempo contemporaneo in cui – secondo Salvatore – la psicoterapia rischia di appiattirsi sul protocollo. Ma è anche una scelta che lascia aperta una domanda: basta essere autentici – come raccomandava Liotti – per curare?
E a questo punto, una notazione lievemente sarcastica è d’obbligo: se c’è un’emozione che ben rappresenta il terapeuta cognitivo post-Liotti, quella è proprio la vergogna. Ma non solo la vergogna sana di Salvatore della coscienza dei propri limiti, ma anche quella epistemologica, quella che nasce dal sentirsi parzialmente inadeguati in un modello che da Liotti in poi ha progressivamente spogliato la tecnica di ogni necessità, lasciando il terapeuta nudo – e, inevitabilmente, un po’ impacciato – davanti all’altare della relazione. Forse non è un caso che proprio questa emozione abbia meritato il titolo del libro.
La vergogna del terapeuta (2023): il terapeuta come risorsa emotiva nella relazione clinica
Lungi dall’essere un manuale, il libro La vergogna del terapeuta si sviluppa come una riflessione fluida, intima, quasi confidenziale, che tocca le corde più profonde del lavoro psicoterapeutico. Il linguaggio è preciso ma mai freddo, teorico ma sempre radicato nella clinica viva. La vergogna non viene “concettualizzata” nel senso classico, ma narrata, raccontata, condivisa con alcune potenti e audaci self-disclosure di Salvatore che a volte raggiunge i vertici di auto flagellazione di un personaggio di Dostoevskij. Ciò che emerge è un modello di terapia profondamente relazionale, in cui la soggettività del terapeuta non è un inciampo, ma una risorsa. In cui il cambiamento non avviene solo attraverso la ristrutturazione cognitiva alla Beck o la mentalizzazione dei processi interni alla Semerari o l’esperienza relazionale e corporea alla Dimaggio, ma nella reciprocità emotiva dell’incontro sincero tra due vulnerabilità. Una psicoterapia che non ha più paura del fallimento, perché ha imparato a riconoscere nella frattura la possibilità del contatto.
La vergogna del terapeuta è un libro che commuove e fa pensare. Che si assume il rischio di non cercare di insegnare, ma di testimoniare. E che riesce però a parlare a tutti, perfino a un cultore della tecnica come me: ai terapeuti esperti che si sono sentiti “smascherati” almeno una volta, ai giovani clinici che temono di non essere “abbastanza”, ma anche – e forse soprattutto – a chi crede che la cura, prima ancora che tecnica, sia relazione. Una lettura indispensabile per chi vuole fare terapia con il cuore acceso, la mente vigile, e la pelle scoperta. Con la convinzione che curare non è solo sapere, ma anche sentire. E talvolta, persino crollare un po’.