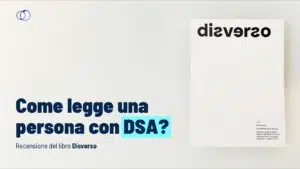I progressi scientifici sulla dislessia
Articolo in collaborazione con Clinica Età Evolutiva
Negli ultimi anni, la comprensione scientifica della dislessia e di altre difficoltà di apprendimento ha visto rapidi progressi in merito alla definizione, alla classificazione, ai correlati neuropsicologici e all’intervento.
Di seguito vedremo alcune tra le domande più importanti sulla dislessia con l’obiettivo di fornire ai genitori e agli insegnanti informazioni chiare e comprensibili.
Che cos’è la dislessia?
In passato, le definizioni di dislessia richiamavano aspetti come il quoziente intellettivo e lo status socio-economico. Ad oggi, è possibile affermare che tali caratteristiche sono invece utili a identificare ciò che la dislessia non è, fungendo proprio da criteri di esclusione.
L’International Dyslexia Association (IDA) definisce la dislessia come:
Una disabilità specifica dell’apprendimento di origine neurobiologica, caratterizzata da difficoltà nel riconoscimento accurato e/o fluente delle parole e da scarse capacità di ortografia e decodifica. Queste difficoltà derivano tipicamente da un deficit nella componente fonologica della lingua che è spesso inaspettata in relazione alle altre abilità cognitive e all’erogazione di un’istruzione efficace in classe.
Si noti che questa definizione sottolinea come la dislessia si verifica a causa di un deficit cognitivo specifico nonostante la presenza di un’adeguata istruzione e l’assenza di altre disabilità che spiegherebbero il problema di lettura (ad esempio, ritardo intellettivo). In altre parole, l’organizzazione cerebrale tipicamente utilizzata per la lettura e l’ortografia non funziona normalmente nei bambini dislessici, anche se possono essere molto intelligenti. Pertanto, le persone che presentano una dislessia possono imparare a leggere riorganizzando i circuiti cerebrali e accedendo a regioni diverse. È importante sottolineare, inoltre, che ogni persona ha il proprio funzionamento cerebrale e che ciò implica la presenza di numerose variazioni nel modo in cui questa condizione si manifesta.
Quanto è comune la dislessia?
Analizzando la letteratura emerge una diffusa difficoltà nel rispondere a questa domanda. In effetti, è probabile che la combinazione dei diversi tipi di indicatori della dislessia tenuti in considerazione nelle varie indagini produca dati di prevalenza diversi (Wagner et al., 2020).
Secondo le ultime stime fornite dal Ministero dell’Istruzione, relative agli studenti con disturbi specifici di apprendimento nelle scuole italiane statali e non statali dal 2019 al 2021, gli alunni con dislessia sono pari al 2,8% rispetto al totale dei frequentanti.
La dislessia è ereditaria?
La dislessia ha un’origine genetica. Studi condotti sui gemelli suggeriscono che le difficoltà di lettura e le altre abilità correlate sono altamente ereditarie (Hulme & Snowling, 2016). Inoltre, la meta-analisi condotta da Snowling & Melby-Lervåg (2016) mostra come nel 44% dei casi, i figli di genitori dislessici manifestano dislessia.
Nonostante l’importanza dei fattori genetici, secondo Sénéchal & LeFevre (2002) l’ambiente di alfabetizzazione domestica e la qualità dell’insegnamento sono altri fattori che influenzano lo sviluppo dell’abilità di lettura. Ma ancor di più è la combinazione genetica-ambiente che influenza i risultati dell’alfabetizzazione. In effetti, i genitori con dislessia non condividono soltanto il corredo genetico con i loro figli, ma probabilmente possono anche fornire un ambiente di alfabetizzazione diverso da quello che potrebbe offrire un genitore senza dislessia (Hulme & Snowling, 2016).
Le persone dislessiche vedono le parole in modo diverso?
La lettura è un’abilità complessa che migliora con l’esperienza e diventa sempre più automatica e precisa. Sebbene la dislessia non sia un problema oculomotorio primario, i movimenti oculari differiscono durante la lettura tra lettori tipici e dislessici (Smyrnakis et al., 2017). Le differenze osservate possono essere attribuite a un’elaborazione linguistica o cognitiva anormala. Sono state proposte diverse possibili eziologie, come lo squilibrio o l’”affollamento” del campo visivo tra sinistra e destra o la scarsa attenzione (Schneps et al., 2013).
Perché è importante eseguire una diagnosi precoce e corretta di dislessia?
Nella maggior parte dei casi l’identificazione degli studenti con dislessia avviene al terzo anno della scuola primaria, quando la capacità di lettura è in ritardo rispetto a quanto previsto per l’età e pertanto ostacola il progresso educativo del bambino. Vi è, inoltre, un numero significativo di studenti in cui la dislessia non viene diagnosticata e i relativi sintomi non ricevono trattamenti specifici (Smyrnakis et al., 2017).
Secondo l’International Dyslexia Association, la diagnosi completa della dislessia è un processo elaborato che deve considerare molteplici fattori tra cui: intelligenza, abilità linguistiche orali, riconoscimento delle parole, decodifica, ortografia, elaborazione fonologica, comprensione della lettura, etc.
E’ importante sottolineare che le difficoltà di lettura di tipo dislessico possono avere un impatto negativo non soltanto sui risultati accademici di un individuo ma possono, inoltre, influenzare anche altri aspetti come ad esempio l’immagine di sé e l’adattamento sociale. Pertanto, eseguire una corretta diagnosi di dislessia è importante per evitare ripercussioni personali, accademiche e sociali.