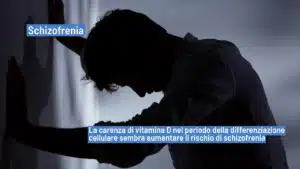Schizofrenia: che cos’è?
Il termine schizofrenia origina etimologicamente dal greco e significa letteralmente “scissione della mente”. Tale termine è stato coniato nel 1908 da Eugen Bleuler ed è stato utilizzato per i quadri clinici che precedentemente venivano indicati con il termine Dementia praecox.
I disturbi schizofrenici sono caratterizzati dalla presenza di sintomi psicotici (deliri, allucinazioni, appiattimento affettivo, riduzione dell’espressione delle emozioni, abulia, alogia) (Andreasen, Flaum, 1991). L’esordio del disturbo si colloca tra i 18 ed i 25 anni e raramente durante l’infanzia o l’adolescenza (Esan, Oluyomi, Ojagbemi, Akin, Gureje, Oye 2012).
Eziologia della schizofrenia
L’eziologia della schizofrenia non è ancora ben definita; dall’analisi dei contributi presenti in letteratura, emergono alcune ipotesi sulla base delle ricerche condotte. L’ipotesi genetica è sostenuta dai valori di concordanza rilevati tra fratelli (8-14%) e gemelli omozigoti (50%) (Chen, Lipska, Weinberger, 2006). Attualmente nell’ambito di tale ipotesi viene privilegiato il modello poligenico che prevede l’intervento anche di fattori ambientali (Fabi, Fusco, Valiante, Celli, 2013). Secondo l’ipotesi neurotrasmettitoriale il sistema maggiormente coinvolto, in questa patologia, è quello dopaminergico seguito da quello serotoninergico, ma vari studi prendono in considerazione un’interazione tra più sistemi neurotrasmettitoriali (Miyamoto, Duncan, Marx, 2005). Le ricerche che riguardano le ipotesi neuroendocrinologiche hanno fornito risultati contrastanti. Gli studi autoptici e di neuroimaging mostrano nei pazienti schizofrenici alterazioni dei lobi frontali e del sistema mesolimbico; tuttavia, è difficile stabilire se queste alterazioni abbiano un ruolo primario o un siano secondarie al disturbo (Hirao et al. 2008). Le ipotesi psicodinamiche e relazionali si fondano nel vedere il disturbo schizofrenico come una difesa necessaria in presenza dell’incapacità di tollerare e gestire l’angoscia (Klein, 1958).
È documentato in letteratura il ruolo dell’attaccamento nello sviluppo della mentallizzazione. L’attaccamento di tipo sicuro favorisce il bambino nel potenziare le proprie capacità cognitive e sociali e lo aiuta a sviluppare i processi di mentallizzazione (Debbané et al., 2016). La mancanza di uno stile sicuro costituisce, secondo Escher e collaboratori (2002), un fattore favorente lo sviluppo di disturbi psicotici.
Attualmente i disturbi dello spettro schizofrenico sono da considerarsi disfunzioni a genesi multifattoriale, riconducibili alla complessa interazione tra fattori genetici, neurobiologici ed ambientali (Walker, Kestler, Bollini, Hochman, 2004).
Piuttosto recentemente si è iniziato a ritenere che una disfunzione del sistema immunitario possa avere un ruolo nella genesi e nell’evoluzione della schizofrenia (Bauer, Teixeira, 2019)
In uno studio pubblicato nel 2023 su The Lancet Psychiatry, sono state indagate le alterazioni che le citochine infiammatorie periferiche presentano nelle varie fasi dei disturbi schizofrenici, confrontando le proteine infiammatorie periferiche con quelle presenti in una popolazione sana (Halstead, Dan Siskind, AmfT, et al. 2023).
Il ruolo delle citochine infiammatorie nei quadri acuti e cronici della schizofrenia
Le fasi sequenziali della schizofrenia, che possono presentare una durata variabile, sono quella prodromica, acuta, di stabilizzazione e stabile o residua (APA, 1999). I disturbi schizofrenici possono essere quindi distinti in acuti e cronici.
Lo studio pubblicato su The Lancet Psychiatry, attraverso una revisione sistematica ed una metanalisi, ha indagato le alterazioni nelle concentrazioni periferiche di citochine infiammatorie nei quadri acuti e cronici della schizofrenia. Complessivamente i casi presi in considerazione sono 13925 con disturbo schizofrenico e 10969 controlli sani. L’analisi dei dati ha mostrato che le concentrazioni di interleuchina (IL)-1β, antagonista del recettore IL-1 (IL-1RA), del recettore solubile dell’interleuchina-2 (sIL-2R), di interleuchina IL-6, IL-8, IL-10, del fattore di necrosi tumorale (TNF), della proteina α e di quella C-reattiva sono costantemente alterate negli individui con disturbo dello spettro schizofrenico sia acuto che cronico, rispetto ai controlli sani. La concentrazione dell’interleuchina IL-2 e l’interferone (IFN)-γ sono significativamente elevate nel disturbo dello spettro schizofrenico acuto, mentre quelle dell’interleuchina IL-4, IL-2, IL-1 e IFN-γ sono significativamente diminuite nel disturbo dello spettro schizofrenico cronico.
I risultati dello studio suggeriscono che le persone con disturbi dello spettro schizofrenico presentano un’alterazione delle proteine infiammatorie. Nel caso di quadro acuto, l’aumento di molecole come IFN-γ può essere considerato come un marcatore di una sovrapposta attività immunitaria durante questa fase della malattia. Nonostante l’ampio numero di casi presi in considerazione nella revisione, sono necessari ulteriori studi per comprendere se quanto registrato perifericamente dell’attività del sistema immunitario si rifletta sul funzionamento del sistema nervoso centrale. Tuttavia, la metanalisi apre una prospettiva su come i biomarcatori infiammatori possano essere utili per la diagnosi e la prognosi dei disturbi schizofrenici.