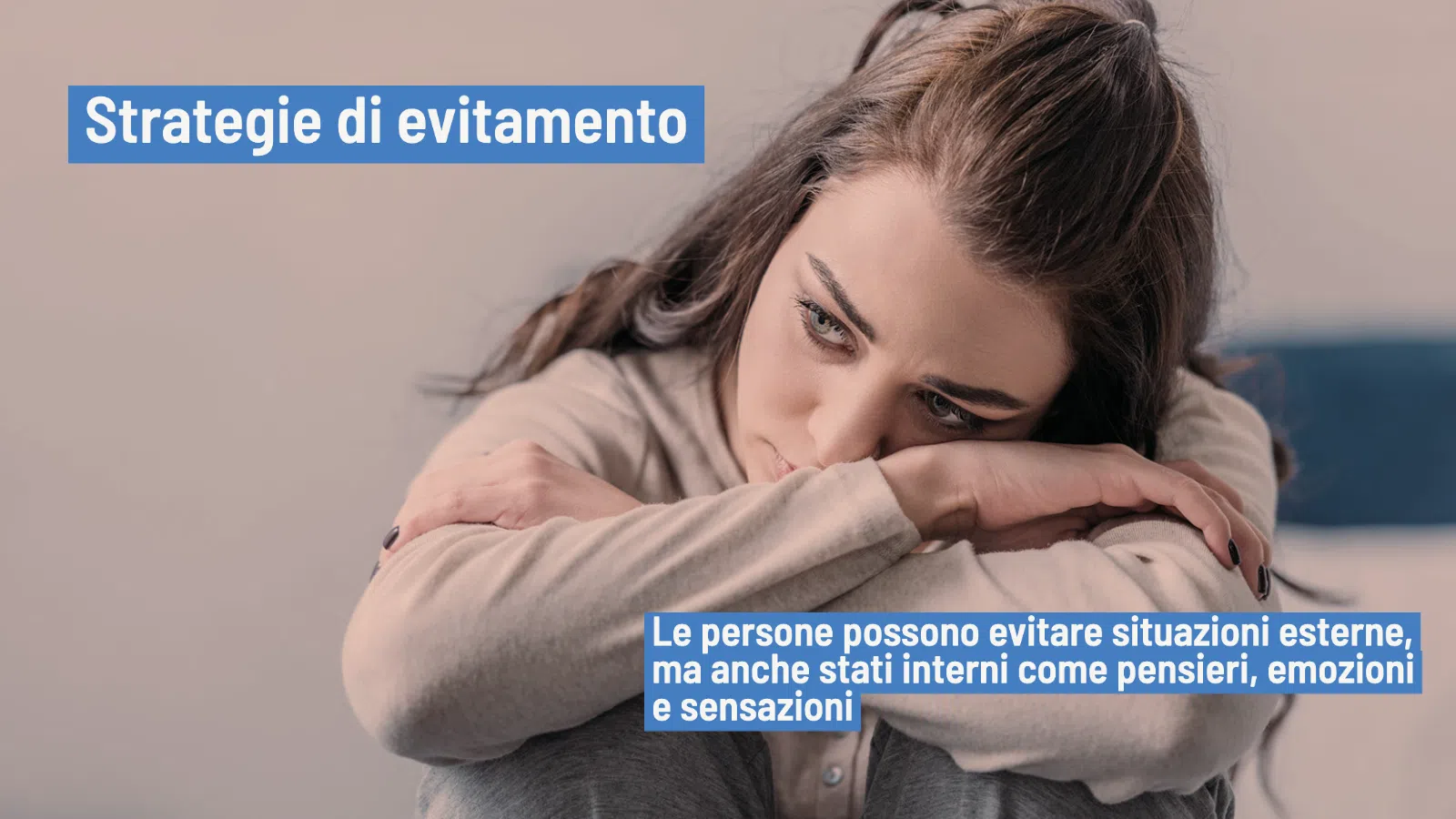In psicologia, il concetto di evitamento è definito come una strategia volta a sottrarsi a persone, situazioni, eventi, pensieri temuti.
L’evitamento è considerato una strategia adattiva, ovvero utile a uno scopo in una determinata situazione, se messo in atto in situazioni di reale pericolo o minaccia.
Tuttavia, la messa in atto sistematica di questa strategia può diventare una vera e propria forma di difesa, che ha lo scopo di proteggere l’individuo da una situazione/persona che causa disagio considerato intollerabile.
Definizione del concetto di evitamento
In psicologia, il concetto di evitamento è definito come una strategia comportamentale, che implica la messa in atto di comportamenti atti a sottrarsi a persone, situazioni e/o eventi temuti. È importante sottolineare che l’evitamento può riguardare situazioni esterne, ma anche stati interni come pensieri, emozioni e sensazioni. Questi contesti sono generalmente evitati a causa delle emozioni negative che suscitano nella persona.
L’evitamento come strategia adattiva
L’evitamento è considerato una strategia adattiva, ovvero utile a uno scopo in una determinata situazione, se messo in atto in situazioni di reale pericolo o minaccia (Sassaroli et al., 2006). Per esempio, evitare di camminare di notte su strade prive di illuminazione è un comportamento protettivo adeguato alla situazione, e dunque adattivo poichè volto a garantire la sopravvivenza. Infatti, l’evitamento è una strategia comune, usata in maniera molto diffusa proprio per la sua funzionalità.
L’evitamento come strategia disfunzionale
Tuttavia, la messa in atto sistematica di questa strategia può diventare una vera e propria forma di difesa, che ha lo scopo di proteggere l’individuo da una situazione/persona che causa disagio considerato intollerabile. Infatti, l’evitamento diventa una strategia disfunzionale quando viene applicato in maniera rigida e generalizzata a molti contesti di vita, impedendo all’individuo di esplorare adeguatamente l’ambiente (Sassaroli et al., 2006). In molti casi, si innesca un circolo vizioso: più si teme una situazione, più la si evita, più si perde fiducia nelle proprie capacità, più viene rinforzata l’idea di non essere in grado di svolgere un compito o affrontare una situazione.
I tipi di evitamento
Sono stati teorizzati vari tipi di evitamento, riferiti a diversi contesti.
- Evitamento cognitivo: messa in atto di strategie cognitive che hanno lo scopo di evitare, procrastinare o nascondere pensieri temuti (Dickson et al., 2012).
- Evitamento situazionale: evitamento attivo di contesti o, appunto, situazioni che richiamano o riguardano situazioni temute (Davis & Conlon, 2017). Per esempio: un bambino che subisce bullismo a scuola tenderà a temere il contesto scolastico proprio perché considerato pericoloso. A livello psicopatologico, le fobie sono l’emblema dell’evitamento situazionale, proprio perché implicano l’evitamento di situazioni, persone, animali o oggetti che causano eccessiva ansia, paura o disagio.
- Evitamento comportamentale: non voler ingaggiarsi in un determinata azione (Uzun et al., 2020). Per esempio: la procrastinazione è l’atto di rimandare un’attività il più a lungo possibile, non adempiendo ai propri obblighi per ansia e paura.
- Evitamento aggressivo: proiettare le proprie emozioni spiacevoli su altre persone, al posto di affrontare i problemi alla base delle proprie paure (Lyons-Ruth, 1996). Per esempio: usare un linguaggio aggressivo con una persona a cui si è legati nel momento in cui si sperimentano difficoltà o situazioni stressanti in un altro ambito di vita.
- Evitamento emotivo: messa in atto di comportamenti compulsivi o dannosi per evitare il disagio emotivo (Kahn & Garrison, 2009). Per esempio: le dipendenze (internet, sostanze) o i disturbi alimentari sono comportamenti di evitamento emotivo messi in atto per non rimanere nel disagio provato a causa di una situazione stressante.
Come si affronta l’evitamento in psicoterapia
In psicoterapia, una tecnica molto diffusa ed efficace per trattare l’evitamento è l’esposizione: questa strategia prevede che l’individuo affronti le situazioni, eventi o persone che teme, con l’aiuto del terapeuta, così da disincentivare la messa in atto di comportamenti protettivi e la progressiva desensibilizzazione a stimoli temuti.
Sul piano pratico, vengono fissati con il paziente step graduali per fronteggiare l’evento o la situazione temuti, andando progressivamente da quello meno ansiogeno al più spaventoso, in modo da affrontare le paure temute in diversi contesti.
Questa tecnica è riconducibile alla terapia cognitivo-comportamentale, ma viene comunemente utilizzata in svariate forme di psicoterapia, nel trattamento dei disturbi d’ansia, ma anche dei disturbi dell’alimentazione e del disturbo da stress post traumatico.