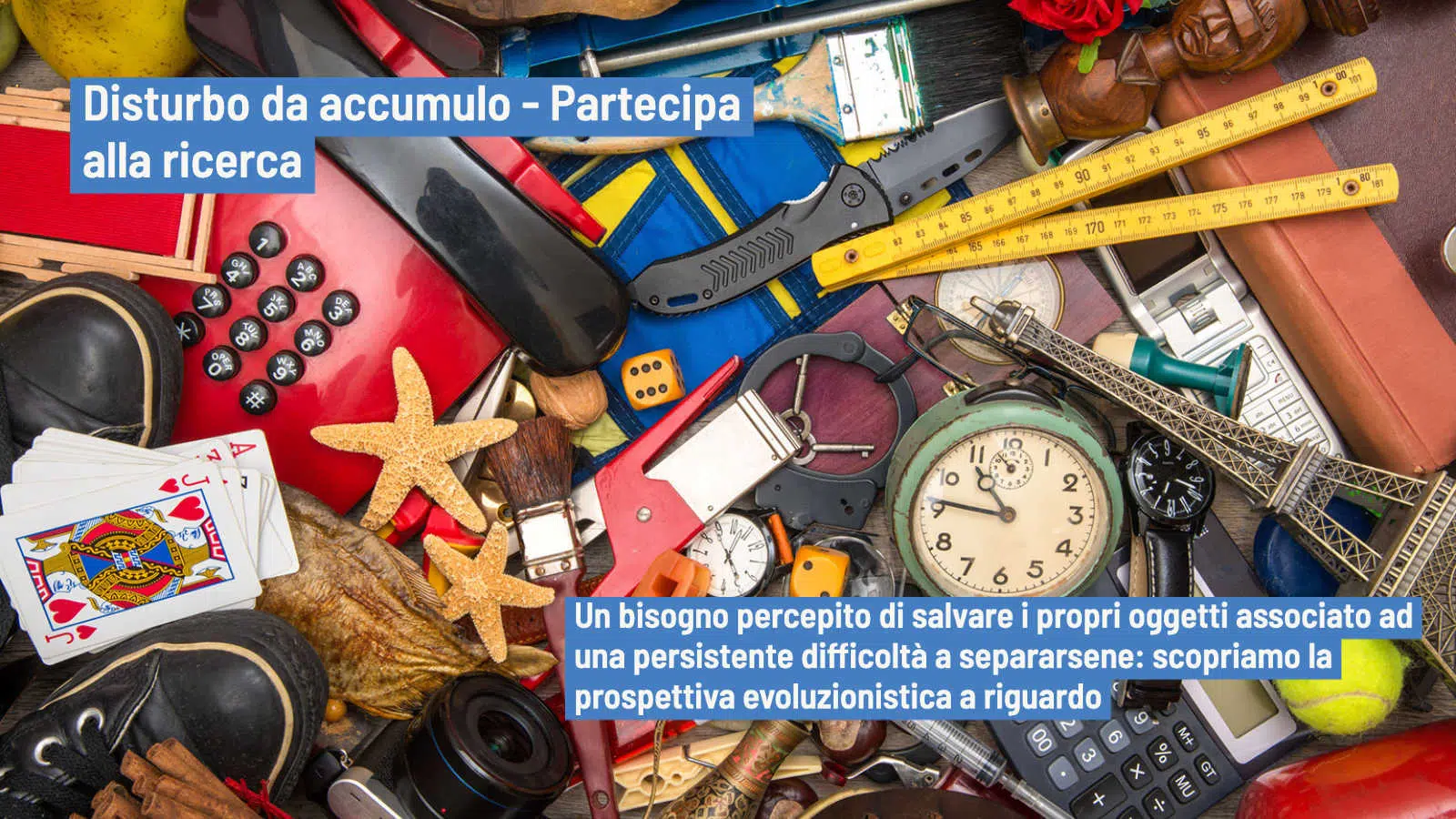La prospettiva psicopatologico-evoluzionistica al disturbo da accumulo ritiene che gli individui con alte tendenze ad accumulare tendano a sperimentare un senso affettivo di forte insicurezza interna e di avversione al rischio percepito; per far fronte a questo stato l’individuo risponderebbe attraverso una motivazione all’accumulo come forma (maladattiva) di protezione dal mondo esterno.
Il disturbo da accumulo
La tendenza ad esprimere comportamenti di accumulo patologico è stata tradizionalmente considerata un sottotipo del disturbo ossessivo-compulsivo (Fontenelle et al., 2004), fino a che, con la pubblicazione della quinta versione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5; American Psychiatric Association, 2013), è stata resa indipendente attraverso la formulazione di una categoria diagnostica separata, denominata disturbo da accumulo. Attualmente il disturbo da accumulo viene definito da un bisogno percepito di salvare i propri oggetti associato ad una persistente difficoltà a separarsene, cosa che comporta la congestione degli spazi di vita domestica, spesso minandone la sicurezza e risultando in una significativa compromissione del funzionamento sociale e occupazionale dell’individuo. Dato che il tasso di prevalenza del disturbo da accumulo nella popolazione generale è stimato essere dell’1.5-2.5% (Postlethwaite et al., 2019; Zaboski et al., 2019; Samuel et al., 2008), negli ultimi anni, il fenomeno ha suscitato notevole interesse rispetto ad una maggiore comprensione clinica ed al trattamento. Infatti, il costo stimato di 6.65 miliardi associato a tale disturbo nel contesto statunitense, all’anno (Tolin et al., 2008), rende questa condizione clinica un enorme onere di tipo economico e sociale.
La prospettiva etologica/evoluzionistica sul disturbo da accumulo
Rifacendosi ad una prospettiva etologica/evoluzionistica come tentativo di comprensione dei comportamenti di accumulo nell’essere umano, si evidenza come negli animali, ed in particolare nelle specie mammifere, questo comportamento venga ritenuto una strategia adattiva di allocazione delle risorse (Preston et al., 2014; Preston, 2011). Tale fenomeno è stato selezionato dall’evoluzione naturale al fine di permettere un costante accesso alle proprie risorse nello spazio e nel tempo in relazione alla variabilità ecologica, contestuale ed ambientale in cui l’organismo può trovarsi (VandeWall, 1990). Anche gli esseri umani mostrano forme di accumulo analoghe e funzionali all’allocazione adattiva delle risorse, si pensi, ad esempio, all’utilizzo di dispense domestiche, di frigoriferi e delle diverse forme di conservazione dei beni (es. banche, casseforti, ecc…); questi esempi offrono solo alcuni elementi possibili attribuibili all’accumulo umano. Alla luce di ciò, la tendenza ed il relativo comportamento di accumulo umano si ritiene essere potenzialmente adattivo, fondamentale per la sopravvivenza, in maniera analoga a quanto avviene in altre specie animali. Una condizione specifica che elicita il comportamento da accumulo è quella dovuta ad una risposta avversa al rischio percepito (Bergstorm, 2014; Murray et al., 2006; Preston, 2011, 2014). Per esempio, durante la recente situazione relativa alla condizione pandemica del COVID-19 è stato documentato un acuirsi della tendenza, nella popolazione, all’accumulo (Banerjee, 2020; David et al., 2021; Micalizzi et al., 2021).
È stato infatti proposto che, a fronte di un mondo esterno percepito come imprevedibile e rischioso, l’accumulo potrebbe rappresentare un tentativo di protezione attraverso gli oggetti, in maniera analoga al comportamento animale di costruzione di una tana o di un nido volto al raggiungimento di un livello ottimale di calore, comfort e protezione dai predatori (Preston, 2014). La funzione motivazionale alla base dell’accumulo comporta che esso sia elicitato da segnali affettivi di rischio e insicurezza ed inibito da segnali di sicurezza percepita internamente (Preston, 2014). Negli individui con disturbo da accumulo si assisterebbe a livelli esageratamente elevati e non adattativi di questo meccanismo motivazionale (“alti” segnali affettivi di forte rischio vs “bassi” segnali di sicurezza percepita internamente inibizione). Di conseguenza, gli individui con disturbo da accumulo sperimenterebbero il loro contesto e ambiente di vita come estremamente rischioso, imprevedibile ed insicuro. L’accumulo patologico sarebbe determinato quindi da una cronica attività di tale funzione della motivazione, che non risulterebbe mai placata ed inibita da sentimenti di comfort e sicurezza, portando l’individuo verso una costante ricerca per il suo raggiungimento attraverso l’accumulo stesso. Infatti, gli individui con disturbo da accumulo sarebbero sorretti da una forte e cronica tendenza motivazionale-affettiva, la cui intensità comporterebbe una bassa capacità di regolazione della motivazione sottostante al loro comportamento.
Partecipa alla ricerca
La prospettiva evoluzionistica al disturbo da accumulo non ha ancora ricevuto un supporto empirico adeguato vista l’esiguità di progetti di ricerca sull’argomento. A tal proposito, l’Università degli Studi di Torino sta conducendo uno studio dal titolo “Struttura disposizionale e motivazionale nel Disturbo da accumulo” (Prot. n. 0420699; nella sua versione inglese dal titolo “Dispositional and motivational structure in hoarding disorder”) a cui è possibile accedere e partecipare in forma totalmente anonima.
Per partecipare alla ricerca: