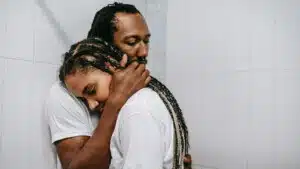A partire dalla diagnosi di Sindrome di Rokitansky, l’immagine di sé che si riformula è estremamente negativa, la ragazza si sente difettosa e imperfetta; questa considerazione di sé è fortemente legata alla rappresentazione simbolica dell’utero, segno di femminilità.
La Sindrome di Rokitansky
La sindrome di Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, o più comunemente Rokitansky, è una rara malformazione congenita caratterizzata dalla mancanza dell’utero, che colpisce 1 donna su 4500, senza l’alterazione delle ovaie, genitali esterni e delle caratteristiche sessuali secondarie e del cariotipo. La sindrome si può presentare in due forme: o con la sola mancanza dell’utero, o associata a malformazioni di altri organi (Deng et al., 2019; Herlin et al., 2016).
La diagnosi ha serie ripercussioni sul benessere emotivo e psicologico della donna e questo fattore è influenzato anche dagli schemi mentali e dagli stereotipi di genere. L’identità sessuale viene messa in discussione e la vita sociale e sentimentale vanno a ridimensionarsi qualitativamente. L’aspetto più debilitante nel lungo periodo è l’infertilità, dovuta alla mancanza dell’utero (Deka e Sarma, 2010)
La diagnosi avviene quasi sempre durante l’adolescenza per via dell’assenza del menarca. Quest’ultimo, unito al periodo nel quale avviene la diagnosi e l’infertilità sono i fattori che maggiormente influenzano la salute psicosessuale della persona (Ragozzino et al., 2020).
A partire dalla diagnosi, l’immagine di sé che si riformula è estremamente negativa, la ragazza si sente difettosa e imperfetta; questa considerazione di sé è fortemente legata alla rappresentazione simbolica dell’utero, segno di femminilità. Il ruolo sociale di donna viene, in questo modo, messo in discussione ed è compromesso il senso di normalità e di appartenenza al gruppo delle coetanee (Holt e Slade, 2003)
Il menarca ha un ruolo centrale per la formazione e lo sviluppo dell’identità femminile poiché rappresenta la raggiunta maturità sessuale; quindi, l’assenza della prima mestruazione può far sentire le ragazze incomplete e diverse dalle loro coetanee (Holt e Slade, 2003; Patterson et al., 2016). L’assenza del menarca può essere percepita come la perdita di una parte del proprio corpo, crea una ferita narcisistica in una fase della vita dove la maturità cognitiva non è totalmente raggiunta. Questa, unita alla mancanza di esperienza e a una modalità di pensiero dicotomico, può portare la donna ad una autovalutazione negativa e ad un utilizzo di strategie di coping disfunzionali per affrontare questa nuova condizione (Gueniche et al., 2014; Wagner et al., 2016).
La comunicazione ai familiari nella diagnosi di Sindrome di Rokitansky
Un altro aspetto rilevante è la risposta della famiglia alla diagnosi. Le reazioni della famiglia e dell’ambiente possono essere un ulteriore carico emotivo che aumenta lo stress dell’adolescente. Durante le visite mediche le pazienti possono sentirsi trascinate dagli eventi e per questo motivo alcune ragazze possono decidere di informare loro stesse famigliari e amici, sia per minimizzare l’effetto che la diagnosi può avere sulla famiglia, sia per riprendere il controllo della situazione e decidere cosa comunicare e a chi comunicarlo (Holt e Slade, 2003).
La comunicazione della diagnosi può avere un effetto anche sulle madri che possono diventare più premurose (Leithner et al., 2015) o prendere il controllo della situazione, sia durante le consultazioni mediche, sia per la divulgazione della diagnosi (Espie, 2012), mettendo in secondo piano le figlie. Inoltre, le madri potrebbero sentirsi in colpa e attribuirsi la responsabilità della condizione della figlia (Gueniche et al., 2014). Questo può influenzare significativamente l’atmosfera famigliare e il rapporto madre-figlia (Bargiel-Matusiewicz et al., 2013). Un’altra criticità che si può incontrare durante i colloqui è legata al tema della sessualità e dell’intimità, oltre all’utilizzo di termini tecnici che rendono maggiormente difficile la comprensione della patologia e le sue conseguenze (Holt e Slade, 2003).
Il tema dell’infertilità spesso è collegato a una perdita di attrazione fisica e fiducia tra partner. L’incapacità di concepire un bambino può comportare una distorsione dell’equilibrio psicologico sia della singola persona che della coppia e viene paragonata al lutto. Studi su donne sterili rivelano un aumento di sospettosità e ostilità che può influenzare la relazione con il partner (Malina et al., 2016). Per fare fronte a questo aspetto vengono proposte delle soluzioni mediche per l’infertilità quali la maternità surrogata, l’adozione e il trapianto dell’utero.